Download This PDF File
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Press Release
BWA PRESS RELEASE The cultural organization “Immagine latente” is launching for the first time an INTERNATIONAL COMPETITION ENTIRELY DEDICATED to BLACK !and WHITE PHOTOGRAPHY. Candidates are called to enter their images in ANALOGUE or in DIGITAL format. Digital pictures will not necessarily have to be shot with cameras (as also pictures shot with any digital device will be accepted). ROME will be both the departure and the arrival of the context as the first prize !winners will be awarded trip and/or accommodation in the city. Through the use of photography’s universal language the Black and White International Photography Award Rome aims to promote the dialogue among different cultures and people. Furthermore the goal is to enhance on a large scale the divulgation and rediscovery of black and white art, a source of beauty and evocative power able to give immortality to images and to express every day life intensity and !feelings. The Black&White International Award has deliberately chosen to exclude specific topics to give the contest a wider range and allow full freedom of expression to all participants. Black and white photography will be the only guideline to follow as a link between form and content. Members of the jury are expecting to receive high technical, compositional, content and emotional quality images. The Association - IMMAGINE LATENTE The start of the roman cultural association “Immagine Latente” (i.e. Latent image) together with the Black&White International Award Rome are ideas developed by a group of professional photographers and communication experts wishing to promote visual arts through the spreading of photography. -

XLI Mostra Internazionale Del Cinema Libero Fondazione Cineteca Di Bologna
XLI Mostra Internazionale del Cinema Libero Fondazione Cineteca di Bologna “Il cinema è l’istituzione più democratica e più internazionale... Apre spazio alla fantasia creativa degli spettatori [...] costretti e autorizzati a dare loro stessi un’anima a quei corpi in movimento; detto altrimenti: a scriversi il proprio testo per il film” “Cinema is the most democratic and most international of institutions... Provides space for the viewer’s creative imagination [...] compelled and enabled to give a soul to those moving bodies – or, to put it more simply, to write their own text for the pictures” Viktor Klemperer, 1912 “Procediamo con disordine. Il disordine dà qualche speranza, l’ordine nessuna” “Let’s start with disorder. Disorder gives you some hope, order none” Marcello Marchesi, 1963 Promosso da / Promoted by: FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA Coordinator: Sara Mastrodomenico Fondazione Cineteca di Bologna Presidente / President: Carlo Mazzacurati Coordinamento Cinema Lumière 1 / Cinema Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero Direttore / Director: Gian Luca Farinelli Lumière 1 coordinator: Andrea Peraro Consiglio di amministrazione / Board of Coordinamento Cinema Lumière 2 / Cinema Con il sostegno di / With the support of: Directors: Carlo Mazzacurati (Presidente), Lumière 2 coordinator: Nicola Di Battista Comune di Bologna Alina Marazzi, Valerio De Paolis Coordinamento Piazza Maggiore / Piazza Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Maggiore coordinator: Silvia Fessia con Direzione Generale per il Cinema Ente Mostra Internazionale -

William A. Seiter ATTORI
A.A. Criminale cercasi Dear Brat USA 1951 REGIA: William A. Seiter ATTORI: Mona Freeman; Billy DeWolfe; Edward Arnold; Lyle Bettger A cavallo della tigre It. 1961 REGIA: Luigi Comencini ATTORI: Nino Manfredi; Mario Adorf; Gian Maria Volont*; Valeria Moriconi; Raymond Bussires L'agente speciale Mackintosh The Mackintosh Man USA 1973 REGIA: John Huston ATTORI: Paul Newman; Dominique Sanda; James Mason; Harry Andrews; Ian Bannen Le ali della libert^ The Shawshank Redemption USA 1994 REGIA: Frank Darabont ATTORI: Tim Robbins; Morgan Freeman; James Whitmore; Clancy Brown; Bob Gunton Un alibi troppo perfetto Two Way Stretch GB 1960 REGIA: Robert Day ATTORI: Peter Sellers; Wilfrid Hyde-White; Lionel Jeffries All'ultimo secondo Outlaw Blues USA 1977 REGIA: Richard T. Heffron ATTORI: Peter Fonda; Susan Saint James; John Crawford A me la libert^ A nous la libert* Fr. 1931 REGIA: Ren* Clair ATTORI: Raymond Cordy; Henri Marchand; Paul Olivier; Rolla France; Andr* Michaud American History X USA 1999 REGIA: Tony Kaye ATTORI: Edward Norton; Edward Furlong; Stacy Keach; Avery Brooks; Elliott Gould Gli ammutinati di Sing Sing Within These Walls USA 1945 REGIA: Bruce H. Humberstone ATTORI: Thomas Mitchell; Mary Anderson; Edward Ryan Amore Szerelem Ung. 1970 REGIA: K‡roly Makk ATTORI: Lili Darvas; Mari T*r*csik; Iv‡n Darvas; Erzsi Orsolya Angelo bianco It. 1955 REGIA: Raffaello Matarazzo ATTORI: Amedeo Nazzari; Yvonne Sanson; Enrica Dyrell; Alberto Farnese; Philippe Hersent L'angelo della morte Brother John USA 1971 REGIA: James Goldstone ATTORI: Sidney Poitier; Will Geer; Bradford Dillman; Beverly Todd L'angolo rosso Red Corner USA 1998 REGIA: Jon Avnet ATTORI: Richard Gere; Bai Ling; Bradley Whitford; Peter Donat; Tzi Ma; Richard Venture Anni di piombo Die bleierne Zeit RFT 1981 REGIA: Margarethe von Trotta ATTORI: Jutta Lampe; Barbara Sukowa; RŸdiger Vogler Anni facili It. -

Sono Solo Fantasmi - Il Film
Sono solo fantasmi - Il Film Sono solo fantasmi di Christian e Brando De Sica, è una curiosa contaminazione tra horror e commedia brillante, un po’ sulla falsariga di alcuni esempi ibridi tipo Tempi duri per i vampiri (1959), dove il comico nostrano Renato Rascel era inserito in una bizzarra parodia degli horror movies della Hammers con Christopher Lee nel ruolo di Dracula. Ma ancora di più Sono solo fantasmi guarda a Ghostbusters (1983) di Ivan Reitman, per gli effetti speciali e agli zoombie movies. Ma ancora di più è debitore, nella leggerezza e nello stile, allo splendido Fantasmi a Roma (1961), di Antonio Pietrangeli. Ma è ancora di più un omaggio di Christian De Sica alla figura del padre Vittorio; ma non passi inosservato neanche che il personaggio interpretato da Gianmarco Tognazzi si chiami Ugo. La sequenza finale, in bianco e nero, con Christian De Sica che assume le sembianze del padre, è da pelle d’oca, mentre sulla discesa del palazzo del Giudizio Universale, saluta il pubblico nella classica posa del padre. Scopri il nuovo numero > Il Natale che verrà La trama è presto detta. E’ la storia di tre fratelli: Thomas (Christian De Sica), Carlo (Carlo Buccirosso) e Ugo (Gianmarco Tognazzi), i quali alla morte del padre, Vittorio De Paola (!!! neanche questo un caso), scoprono che lui aveva sperperato al gioco tutte le sue ricchezze. Per salvare l’antico palazzo di famiglia, scelgono quindi di sfruttare la superstizione popolare degli abitanti di Napoli per mettere in piedi una redditizia attività di acchiappafantasmi. Molto scettici in principio, strane apparizioni e voci convincono presto i fratelli a prendere molto più sul serio l’intera faccenda, arrivando a intuire che la profezia del risveglio di una terribile strega – la janara del folklore locale – arsa viva secoli prima e pronta a scatenare la sua furia su Napoli, sia tutt’altro che da prendere sotto gamba. -
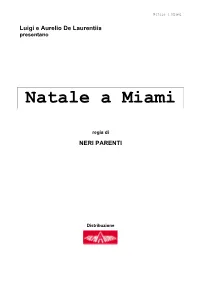
Natale a Miami
Natale a Miami Luigi e Aurelio De Laurentiis presentano Natale a Miami regia di NERI PARENTI Distribuzione Natale a Miami CAST ARTISTICO (crediti non contrattuali) Ranuccio Massimo Boldi Giorgio Christian De Sica Mario Massimo Ghini Stella Vanessa Hessler Paolo Francesco Mandelli Lorenzo Giuseppe Sanfelice Diego Paolo Ruffini Daniela Raffaella Bergé Tiziana Caterina Vertova CAST TECNICO Regia Neri Parenti Soggetto e Sceneggiatura Neri Parenti, Fausto Brizzi, Marco Martani Fotografia Tani Canevari Scenografia Gerry Del Monico, Maurizio Marchitelli Costumi Nicoletta Ercole e Nadia Vitali Montaggio Luca Montanari Effetti Speciali Ottici Proxima Direttore di Produzione Elisabetta Bartolomei Produttore Esecutivo Maurizio Amati Line Producer Luigi De Laurentiis Prodotto da Aurelio De Laurentiis Distribuzione Filmauro Uscita 16 dicembre 2005 Durata 100 m Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Filmauro 06 69958442 pressoffice@filmauro. Natale a Miami Siamo alla vigilia delle vacanze natalizie. RANUCCIO (Massimo Boldi), GIORGIO (Christian De Sica) e PAOLO (Francesco Mandelli) hanno in comune un destino sfortunato. Tutti e tre vengono lasciati dalle rispettive mogli e compagne. Tutti e tre cadono nella stessa terribile depressione. Giorgio si rifugia tra le braccia del suo migliore amico, MARIO (Massimo Ghini) in partenza per Miami per raggiungere la sua ex moglie e la figlia STELLA (Vanessa Hessler). Decide quindi di raggiungerlo in Florida nel tentativo di dimenticare la moglie DANIELA (Raffaella Bergè). Folle di gelosia per la moglie fuggita con un altro, Giorgio sarà oggetto di spudorate seduzioni da parte di Stella, da sempre innamorata di lui. Mentre Mario dovrà inventarsi mille storie per non far scoprire all’amico un segreto imbarazzante. Ranuccio si unisce al figlio ventenne Paolo, in partenza per una eccitante vacanza a Miami con due suoi amici, DIEGO (Paolo Ruffini) e LORENZO (Giuseppe Sanfelice). -

IIIIIII Programmi Di Oggi
09SPE04A0908 ZALLCALL 14 10:03:06 08/09/96 K IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII pagina l’Unità Venerdì 9 agosto 1996 6 2 IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII programmiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII di oggiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M ATTINA 6.30 TG 1. [4204828] 7.00 PARADISE BEACH. Telero- 8.30 VIDEOSAPERE. All’interno: 7.15 L A FAMIGLIA BRADFORD. Te- 6.40 CIAO CIAO MATTINA. Conteni- 6.00 TG 5 - PRIMA PAGINA. Attua- 6.00 CNN. [88002] 6.45 UNOMATTINA ESTATE. Conte- manzo. [1921793] Speciale - Alla ricerca dell’Ar - lefilm. [6598335] tore. [10565151] lità. [89005335] 7.00 EURONEWS. [4505880] nitore. All’interno: 7.00, 7.30, 7.45 QUANTE STORIE! Varietà cheo; Il luogo del pensiero; 8.00 U N AMORE ETERNO. Teleno- 9.15 LA FAMIGLIA HOGAN. Tele- 8.50 ARCA DI NOÈ - ITINERARI. 7.55 BUONGIORNO ZAP ZAP. Con- 8.00, 9.00 Tg 1; 8.30, -

Buon Compleanno Dy Stiamo Lavorando Per
Numero 1.2 Dy’s Chronicles LA RIVISTA UFFICIALE DELLA JMN & DY ■ AVVISO AI NAVIGANTI articoli più disparati. ■ NOVITA’ DAL SITO Il secondo anno di Dy’s Buon Compleanno Chronicles si apre quindi con i Dy migliori auspici tanto che Stiamo lavorando abbiamo deciso di rimandare il per voi 19 – 1 – 2001 nasceva libro dedicato agli esordi del ufficialmente Dy’s Chronicles la product placement per dare Due anni fa nasceva il sito della prima web-zine italiana di spazio ad un Book zero dedicato JMN & DY www.jmnanddy.com product placement e all’anno appena trascorso. che si proponeva di affrontare comunicazione. A questo seguiranno numerose per la prima volta in Italia lo Chi era presente sa che era più altre iniziative che vi verranno studio del product placement che altro un esperimento: tre fogli anticipate nei prossimi numeri. come strumento di in word spediti via e-mail Nel frattempo desideriamo comunicazione aziendale. esclusivamente per rendere più ringraziare tutti i collaboratori Il sito è rimasto fermo, ma sarà partecipi i collaboratori della per il lavoro svolto durante questo nostra cura rinnovarlo al più JMN & DY. Così il primo e così primo anno e soprattutto i nostri presto in vista dei nuovi sviluppi. il secondo numero (sette pagine), fedeli abbonati ai quali Un anno dopo nasceva Dy’s poi l’esplosione. Tutti alla JMN ricordiamo che per qualunque Chronicles & DY hanno messo a richiesta, proposta, www.dyschronicles.com, sito disposizione le proprie collaborazione possono sempre decisamente più vivo che ha competenze per perfezionare il contattarci all’indirizzo riscosso il favore di numerosi progetto che a un anno di distanza [email protected] esponenti della comunicazione e si è dimostrato un successo. -

Una Produzione R.T.I. Prodotto Da RIZZOLI AUDIOVISIVI DIEGO
una produzione R.T.I. prodotto da RIZZOLI AUDIOVISIVI DIEGO ABATANTUONO in con ALESSIA MARCUZZI e ANTONIO CATANIA FABIO FULCO VITTORIA PIANCASTELLI GENNARO DIANA ELENA CANTARONE UGO CONTI RICCARDO ZINNA e con DINO ABBRESCIA con la partecipazione di LUIGI MARIA BURRUANO con la partecipazione di AMANDA SANDRELLI Soggetto di serie GRAZIANO DIANA, ENRICO OLDOINI, SALVATORE BASILE, GIANCARLO DE CATALDO Soggetti e sceneggiature GIANCARLO DE CATALDO, GRAZIANO DIANA, FRANCO FERRINI, ENRICO OLDOINI, CARLO BELLAMIO, MARCO TIBERI Prodotto da ANGELO RIZZOLI Regia di ENRICO OLDOINI serie tv in 4 puntate in onda in prima serata su CANALE 5 venerdì 4, 11, 18 e 25 maggio 2007 CREDITI NON CONTRATTUALI CAST ARTISTICO PRINCIPALE Diego Abatantuono (Giudice Diego Mastrangelo) Alessia Marcuzzi (Claudia Nicolai) Antonio Catania (Uelino) Fabio Fulco (Paolo Parsani) Vittoria Piancastelli (Cristiana Mastrangelo) Gennaro Diana (Naselli) Dino Abbrescia (Gerardo) Elena Cantarone (Finzi) Ugo Conti (Palmieri) Riccardo Zinna (Frappampina) Luigi Maria Burruano (Procuratore De Cesare) Melissa Satta (Francesca) Amanda Sandrelli (Federica Denza) CREDITI NON CONTRATTUALI CAST TECNICO Soggetto di serie GRAZIANO DIANA ENRICO OLDOINI SALVATORE BASILE GIANCARLO DE CATALDO Soggetti e Sceneggiature CARLO BELLAMIO GIANCARLO DE CATALDO GRAZIANO DIANA FRANCO FERRINI ENRICO OLDOINI MARCO TIBERI casting director FRANCO ALBERTO CUCCHINI Face ON suono FABRIZIO ANDREUCCI organizzatore di produzione EMANUELE EMILIANI costumi PATRIZIA CHERICONI FLORENCE EMIR scenografia MARISA RIZZATO musiche PIVIO & ALDO DE SCALZI montaggio FABIO e JENNY LOUTFY fotografia SANDRO GROSSI organizzatore generale ALESSANDRO LOY delegato di produzione R.T.I. FABIANA MOCCIA produttori R.T.I. MARCO MARCHIONNI ALESSANDRA SILVERI prodotto da ANGELO RIZZOLI per RIZZOLI AUDIOVISIVI S.p.A. regia di ENRICO OLDOINI UFFICIO STAMPA RIZZOLI AUDIOVISIVI: UFFICIO STAMPA MEDIASET: ENRICO LUCHERINI Maria Cristina de Caro TEL. -

L'immagine Di Roma Nel Cinema
EDUCARE ALLE MOSTRE EDUCARE ALLA CITTÀ PROGETTO INFORMATIVO PER I DOCENTI INCONTRO | L’IMMAGINE DI ROMA NEL CINEMA Museo dell’Ara Pacis – Auditorium | mercoledì 9 novembre 2011, h 16.00 FILMOGRAFIA SU ROMA SCIPIONE L'AFRICANO Anno: 1937 Regista: Carmine Gallone Attori: Annibale Ninchi, Carlo Lombardi, Camillo Pillotto, Isa Mirando, Lamberto Ricasso, Memo Benassi ROMA CITTÀ APERTA Anno: 1945 Regista: Roberto Rossellini Attori: Anna Magnani, Aldo Fabrizi QUO VADIS? Anno: 1951 Regista: Mervin LeRoy Attori: Peter Ustinov, Robert Taylor, Leo Genn, Deborah Kerr TOTÒ E I RE DI ROMA Anno: 1951 Regista: Steno, Mario Monicelli Attori: Totò, Anna Carena, Alberto Sordi, Aroldo Tieri LE RAGAZZE DI PIAZZA DI SPAGNA Anno: 1952 Regista: Luciano Emmer Attori: Eduardo De Filippo, Marcello Mastroianni, Lucia Bosè, Cosetta Greco, Liliana Bonfatti GIULIO CESARE Anno: 1953 Regista: Joseph Mankiewicz Attori: Marlon Brando, James Mason, Louis Calhern VACANZE ROMANE Anno: 1953 Regista: William Wyler Attori: Gregory Peck, Audrey Hepbourn LA ROMANA Anno: 1954 Regista: Luigi Zampa Attori: Gina Lollobrigida, Franco Fabrizi UN AMERICANO A ROMA Anno: 1954 Regista: Steno Attori: Alberto Sordi LA BELLA DI ROMA Anno: 1955 Regista: Luigi Comencini Attori: Alberto Sordi, Silvana Pampanini, Paolo Stoppa RACCONTI ROMANI Anno: 1955 Regista: Gianni Franciolini Attori: Totò, Vittorio De Sica, Silvana Pampanini, Franco Fabrizi, Aldo Giuffrè, Mario Carotenuto LA DOLCE VITA Anno: 1960 Regista: Federico Fellini Attori: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg UN AMORE A ROMA Anno: 1960 -

Auch Die Körper Von Jago Und Othello. Eine Lange Fahrt Mit Subjektiver
Auch die Körper von Jago und Othello. angeht, die 'Sittenkomödie' mit ihrer opportunistischen Korrum- Eine lange Fahrt mit subjektiver Kamera, die Erde, Himmel und piertheit, auch wenn diese zum Schein hinter Denunziationspro Müllhalde schwindelerregend sich drehen läßt, aus der Sicht der blemen verborgen ist. beiden Körper, die schreiend vor Entsetzen hinunterrollem Bis Diese Unterscheidung und diese Bevorzugung decken sich mit un das Objektiv, unbewegt, nach oben gerichtet ist, gegen den un serer eigenen Beurteilung. Das Totb-Revival ist also nicht nur An endlichen blauen Himmel, über den weiße Wolken eilen. laß zur Freude. Aber gerade deshalb ist es notwendig, den Punkt In dem aufgeplatzten, geschwollenen Gesicht Othellos leuchten auf das i zu setzen, bevor man uneingeschränkte Genugtuung die Augen vor brennender Neugier und nicht unterdrückbarer äußert oder die neue Vorliebe gänzlich und ausschließlich positiv Freude. interpretiert. Tatsächlich geht die subproletarische Komik oft und Auch Jagos Augen betrachten höchst verblüfft oder in Ekstase gern in die unpolitische Haltung des kleinen Mannes über und hat wesentliche Beiührungspunkte mit der kleinbürgerlichen Komik. dieses nie gesehene Schauspiel von Himmel und Welt. Da es ihr an einer genau bestimmten Verwurzelung in einer Klasse Othello: Was ist denn das? und an expliziten Widersprüchen mangelt, ist die Ideologie, die sie Jago: Das sind ... das sind ... die Wolken ... zum Ausdruck bringt, die Frucht einer verzweifelten Lebensangst, Othello: Und was sind Wolken? die im täglichen -

Print Catalogue
ORPHÉE | ORPHEUS | ORFEUS Directed by Jean Cocteau Starring : Jean Marais, François Périer, María Casarès, Marie Déa, Roger Blin, Juliette Greco 1950 | 91’ | B&W | OV French | Fantasy | DCP Film restored in 2008 Subtitles : English, German, Finnish Rights : International (except for UK, USA & Anglophone Canada) Once again Jean Cocteau updates a classic to a compelling modern allegory. Jean Marais is Orpheus, a poet in search of inspiration. Marie Déa is radiant as Eurydice. María Casarès is Death, the imperious and se- ductive princess, whose glove-clad hand ripples though a mirror, leading Orpheus to another world. “If a poet has a dream, it is not of becoming famous, but of being believed.” - Jean Cocteau Cannes Film Festival, Cannes Classics, 2008 LA PISCINE | THE SWIMMING POOL DER SWIMMING POOL Directed by Jacques Deray Starring : Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet, Jane Birkin 1968 | 120’ | Colour | OV French | Crime, Drama | DCP Film restored in 2008 Subtitles : English, German, Dutch Rights : International (except USA, Canada, Italy, Russia, Japan, Ex-USSR, Dutch-speaking territories) Jean-Paul and Marianne spend lazy holidays at their villa in idyllic Southern France. However when Harry and his attractive young daughter Penelope show up, the dreamy summer days are suddenly filled with unspoken tension and jealousy. The shimmering swimming pool becomes the scene of a crime of passion. * Music by Michel Legrand 2 LA BANDERA | ESCAPE FROM YESTERDAY KOMPANIE DER VERLORENEN Directed by Julien Duvivier Starring : Jean Gabin, Anabella, Robert Le Vigan 1935 | 100’ | B&W | OV French | French classic | DCP Film restored in 2006 Subtitles : English, German Rights : International Jean Gabin is unforgettable as a French Legionnaire relentlessly pursued by his criminal past – and a fellow soldier who seems to know a little too much about him… Sent to the frontline, the two men come to terms with their courage in the face of danger. -

Christian De Sica Christian De Sica
www.mapmagazine.it MapMagazine è gemellato con il blog Tracce Volanti www.traccevolonti.com ANNO 2 - NUMERO 17 NOVEMBRE 2019 COPIA OMAGGIO o t a g e r e MAP i MAP h C o c r a m n a MAGAZINE i MAGAZINE G i d a n i t r e p o c n i o t o f O R E B I L E M I G E R N I E P M A T S 9 1 0 2 / 1 2 ° N . T U A - E L A T S O P O T N E M A N O B B A N I E N O I Z I D E P S – . A . P . S E N A I L A CHRISTIAN DE SICA T CHRISTIAN DE SICA I E T S O P ««SSoonnoo iill ffaannttaassmmaa ddii mmee sstteessssoo»» Il popolare attore dal 14 novembre al cinema protagonista e regista della commedia Sono solo fantasmi Le relazioni preziose La generosità e la stima di tanti, l’affetto per un appello importante n “come stai?” non retorico; una telefonata breve, ma attenta; l'offerta gratuita di una mano tesa; quelle parole, pronunciate proprio nel momento in cui sono necessarie per provocare un sospiro di sollievo inatteso: i rapporti umani sono fonte di forza e di speranza. Raccontati con la necessaria ironia da Woody Allen; sezionati in ogni contraddizione dalla poetica di Pasolini; riprodotti, anche nelle dinamiche più crude, nei romanzi, nei film e persino nelle fiction televisive, ricordano chi siamo, in un riflesso che ci mostra il possibile percorso.