Esercito Italiano
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Giornalino-2014
RIVISTA UFFICIALE ZAGATO CAR CLUB N. 7 OTTOBRE 2014 IN QUESTO NUMERO: Lettera del Presidente ❱ Auto e Moto d’Epoca Padova 2013 ❱ Lancia Aprilia Sport Continuation ❱ 250 Anniversario Alfa Romeo S.Z. ES 30, ❱ intervista ad Andrea Zagato ❱ Uno sguardo al Lago di Garda ❱ 15eme Concours d’Elegance Salvarola Terme 2014 ❱ 440 Raduno internazionale Zagato Car Club ❱ Volpago 2014 “Fra Treviso e Belluno“❱ Maserati 450 S Le Mans (Costin - Zagato) ❱ Programmi per la Stagione 2014-2015 ❱ Lettera del Presidente Auto e Moto d’Epoca - Padova 2013 Cari Amici, dopo dotta discussione, all’inizio del secolo scorso, l’au- to venne definita “Femmina” da Gabriele D’Annun- zio, che ne aveva titolo essendone un precursore ed un grande utilizzatore e si potè concedere le migliori auto allora esistenti, dalle Fiat alle Lancia alle Alfa Romeo, tutte Italiane. Il tema del sesso dell’automobile appassionava molto i pensatori di quell’epoca, in cui grandi cambiamenti si stavano manifestando nel mondo a seguito delle innovazioni tecnologiche, elettricità. telegrafo senza fili. nuovi materiali e locomozione. ove l’autovettu- I vertici del consiglio ra anno dopo anno assumeva un ‘importanza pre- Zagato Car Club con il Dott. Enrico Masala Uno scorcio dello stand Zagato fiera di Padova 2013 dominante. Quindi se non si sapeva di cosa si parlava, come si poteva dotta- mente disquisirne? Oramai storica la presenza dello Zagato Car Club alla Fiera Auto e Moto d’Epoca di Padova. Anche nel 2013 il Nostro Club ha Alla fine fu Femmina. Femmina Italiana. voluto offrire ai propri soci e a tutti gli appassionati del marchio Zagato, la possibilità di ammirare tre splendidi esempi di auto da Oggi se vi guardate attorno di auto Italiane ne vedete ben poche, e quelle poche che vengono ancora prodotte corsa carrozzate Zagato: LANCIA FULVIA SPORT ZAGATO COMPETIZIONE, una ABARTH 750 ZAGATO e una FIAT 8VZ. -

I Camion Italiani Dalle Origini Agli Anni Ottanta
I camion italiani dalle origini agli anni Ottanta AISA Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile MONOGRAFIA AISA 124 I I camion italiani dalle origini agli anni Ottanta AISA - Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile Brescia, Fondazione Negri, 19 ottobre 2019 3 Prefazione Lorenzo Boscarelli 4 I camion italiani Massimo Condolo 15 Nasce l’autocarro italiano Antonio Amadelli Didascalia MONOGRAFIA AISA 124 1 Prefazione Lorenzo Boscarelli l camion è nato pochi anni dopo l’automobile e se di rado frutto di progetti originali, ma fruitori in buo- Ine è ben presto differenziato, per soluzioni costrut- na parte di componenti – innanzitutto il motore – di tive, dimensioni e quant’altro. Potremmo chiederci origine camionistica. Un comparto particolare sono perché si ebbe quel sia pur breve “ritardo”; un motivo le macchine movimento terra, per l’iniziale sviluppo con ogni probabilità fu che per i pionieri dell’auto- dei quali tra i paesi europei un ruolo importante ha mobile era molto più attraente fornire un mezzo di avuto l’Italia. trasporto a persone, suscitando curiosità e di diverti- La varietà degli utilizzi dei camion, da veicolo com- mento, piuttosto che offrire uno strumento per il tra- patto per consegne cittadine o di prossimità a mezzo sporto di cose. Un secondo motivo fu senza dubbio la per trasporti di grande portata, da veicolo stradale a limitatissima potenza che avevano i primi motori per mezzo da cantiere, da antincendio a cisterna aeropor- automobili, a fine Ottocento, a stento in grado di por- tuale, e chi più ne ha più ne metta, ha prodotto una tare due o quattro passeggeri, di certo non un carico varietà di soluzioni tecniche e progettuali senza pari, significativo. -

LANCIA Storie Di Innovazione Tecnologica Nelle Automobili Storie Di Innovazione Tecnologica Nelle Automobili
LORENZO MORELLO LANCIA Storie di innovazione tecnologica nelle automobili Storie di innovazione tecnologica nelle automobili LORENZO Morello LANCIA Storie di innovazione tecnologica nelle automobili Editing, progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino © 2014 Lorenzo Morello Stampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. PRESENTAZIONE volontari del progetto STAF (Storia della Tecnologia delle Automobili FIAT), istituito nel 2009 al fine di selezionare i disegni tecnici più rilevanti per documentare l’e- I voluzione tecnica delle automobili FIAT, sono venuti a contatto anche con i disegni Lancia, contenuti in una sezione dedicata dell’Archivio Storico FIAT: il materiale vi era stato trasferito quando, nel 1984, la Direzione tecnica di FIAT Auto, il settore aziendale incaricato di progettare le automobili dei marchi FIAT, Lancia e Autobianchi, era stata riunita in un unico fabbricato, all’interno del comprensorio di Mirafiori. Fu nell’oc- casione del ritrovamento di questo nucleo di disegni che i partecipanti al progetto si proposero di applicare il metodo impiegato nel predisporre il materiale raccolto nel libro FIAT, storie di innovazione tecnologica nelle automobili, anche per preparare un libro analogo dedicato alle automobili Lancia. Questo secondo libro, attraverso l’esame dei disegni tecnici, del materiale d’archivio e delle fotografie di automobili sopravvissute, illustra l’evoluzione delle vetture Lancia e i loro contenuti innovativi, spesso caratterizzati da elementi di assoluta originalità. Il reperimento del materiale si è mostrato, tuttavia, più arduo rispetto al lavoro sulle vetture FIAT, almeno per le automobili più anziane, poiché l’archivio dei disegni Lancia era organizzato senza impiegare una struttura logica di supporto, per distinguere agevolmente i diversi gruppi funzionali dai particolari di puro dettaglio. -

Scheda Adesione
SCHEDA ADESIONE “GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO MILITARE STORICO” Raduno Centenario Associazione Nazionale Autieri d’Italia Milano 9/11 aprile 2021 _____°_____ In occasione del Raduno del Centenario dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, programmato a Milano dal 9 all’11 aprile 2021, durante il quale è in atto l’organizzazione di una mostra di veicoli militari storici dell’Esercito ed un’eventuale sfilata per le vie cittadine, con modalità in corso di definizione, il sottoscritto: Cognome e Nome ___________________________ appartenente a __________________________ per il quale ricopre la carica di __________________ avente sede legale a _____________________ Prov. ______ cap. __________ indirizzo ______________________________________ n. ________ Tel. fisso ____________ Tel. mobile ______________ e-mail: _______________________________ ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE CON I VEICOLI INDICATI IN ALLEGATO All’uopo, sotto la personale responsabilità, dichiara: che tutti i veicoli segnalati sono coperti da assicurazione RC Auto che copre anche i danni causati a persone ed cose dagli stessi e sono in regola con il Codice della Strada e gli autisti/proprietari, a cui ricade ogni responsabilità civile, sono dotati di patente di guida e sono in possesso della documentazione probatoria che esibiranno al Comitato Organizzatore ed i quali rilasceranno apposita liberatoria sottoscritta; di essere a conoscenza che l’evento si svolge su strade aperte al traffico ed al pubblico e nell’area della mostra è assolutamente proibito fumare; che farà -

Donald TRUMP La SCUOLA Che Cambia E Le TECNOLOGIE Digitali
MENSILE D’INFORMAZIONE - POSTE ITALIANE s.p.a. - SPED. IN ABB. POST. D.L. 353/2003 (conv.in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Torino - ISSN 0393-3903 - Data prima uscita: 3 marzo 2017 9 770393 390002 LIBRO DEL MESE: l’idea della storia di Winckelmann dellastoriadi DELMESE: l’idea LIBRO La 70003 SCUOLA Il tardo MACCARTISMO di Donald TRUMP TRUMP diDonald MACCARTISMO tardo Il Marzo Marzo 2017 Anno XXXIV - N. 3 che cambia e le TECNOLOGIE digitali TECNOLOGIE checambiaele www.lindiceonline.com € 7,00 N. 3 2 Lettere della letteratura: La letteratura fan- Baudrillard – ha sempre la meglio OME ABBONARSI ALL NDICE tastica Te o r i e d e l s i m b o l o DIREZIONE C ’“I ” , , tra gli altri su qualsiasi altro possibile valore? Mimmo Cándito direttore responsabile titoli. Quindi la virata verso l’indagi- Ripensare alla !liera che dalla lettu- [email protected] o Abbonamento annuale alla versione ne sulle modalità – sia storiche che ra conduce alla ricomprensione del Mariolina Bertini vicedirettore cartacea (questo tipo di abbonamento strutturali – dell’egemonia politica e testo in un quadro non solo di tradi- COORDINAMENTO DI REDAZIONE include anche il pieno accesso alla versione Cristina Bianchetti, Bruno Bongiovanni, elettronica): culturale europea. Lo sterminio dei zione disciplinare ma di modelli epi- Guido Bonino, Andrea Carosso, Francesco Italia: € 60 popoli precolombiani, i campi di stemologici, non vuol dire ricaricare Cassata, Anna Chiarloni, Pietro Dean- Europa: € 75 concentramento, la con!gurazione di senso la lettura, l’interpretazione, drea, Franco Fabbri, Giovanni Filoramo, € Beatrice Manetti, Walter Meliga, Santina Resto del mondo: 100 della prospettiva dell’“altro”, la di- farne un momento di storia della Mobiglia, Franco Pezzini, Rocco Sciarro- scussione sull’individuo e l’appar- cultura, superando quella che oggi ne, Giuseppe Sergi, Massimo Vallerani o Abbonamento annuale solo elettro- tenenza. -

Pier Ugo E Ugo Gobbato Due Vite Per L'automobile
PIER UGO E UGO GOBBATO DUE VITE PER L’AUTOMOBILE AISA·Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile Patrocinio Comune di Volpago del Montello II PIER UGO E UGO GOBBATO DUE VITE PER L’AUTOMOBILE AISA·Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile con il patrocinio del Comune di Volpago del Montello 3 Prefazione Roberto Toffoletto 4 Ugo e Pier Ugo Gobbato, attori di un’epoca Lorenzo Boscarelli 5 90 anni nella vita di Pier Ugo Gobbato (curriculum vitae e decorazioni al valor militare) 7 Pier Ugo Gobbato. A futura memoria Intervista di Lorenzo Boscarelli e Angelo Ruffini, Torino 4 marzo 2008 19 Lancia Stratos. Auto vincente contro tutto e contro tutti Pier Ugo Gobbato 26 Ricordo di Ugo Gobbato a 50 anni dalla morte Duccio Bigazzi 34 I Gobbato. Storia e valori ritrovati a Volpago del Montello Marino Parolin 37 Volpago del Montello In copertina: Pier Ugo Gobbato sulla pista di Fiorano negli anni Novanta. In IV di copertina: L’insegna del 4° Stormo della Regia Aeronautica con il Cavallino di Francesco Baracca. Pier Ugo Gobbato è stato il solo a potersi fregiare anche del Cavallino Rampante della Ferrari. MONOGRAFIA AISA 86 Ugo Gobbato, Volpago del Montello 16 luglio Pier Ugo Gobbato, Firenze 12 giugno 1918 - 1888 - Milano 28 aprile 1945. Torino 20 dicembre 2008. 2 PREFAZIONE Roberto Toffoletto per me un grande onore presentare questo docu- fosse altro che il primo di tanti omaggi rivolti a una Èmento in ricordo di due grandi uomini, Pier Ugo e così importante figura. Ugo Gobbato. Indipendente e dinamico, la sua spiccata intelligenza -

Annual Report Faces His Destiny
The artist faces the work he wishes to create. He also Annual Report faces his destiny. A struggle begins out of which a © Roberto Borgo Roberto © sculpture, painting or photograph emerges from the artist’s At 31 December 2011 subconscious, revealing his imagination, his sensitivity, his creativity. Often it begins in the unknown, arrives at a junction, takes a side street, changes course and takes yet another route to culminate in the work that embodies “his” truth within. The manager goes through the same process. He faces decisions that will determine the destiny of his enterprise and the men and women in it. A duel begins – to make plans, set targets, establish strategies, evaluate results. Most of the time, just as the artist, he must act with the unknowns of the market, reckon with many variables and explore new roads, to then finally give form to “his” enterprise. The artist and the manager have a need in common: to take a decision, chart a course. Whether we are talking of a painting or photographic technique, as in one case, or an alliance or product launch, as in the other, the artist and the manager have to stay the course, to work in uncertainty without prevaricating. It’s about intuition and clearness of purpose. Artist or manager, we seek a truth for the continuity of our respective enterprises, the artwork I create or the leadership of this Group. I like to imagine the moment when each of us, in our own way, sets out on a course and makes choices, convinced financial year th of our own truth. -

100 Anni Di Lancia
100 ANNI DI LANCIA Tavola rotonda con Franco Amatori, Pierugo Gobbato, Mike Robinson, Guido Rosani. Coordinatore: Lorenzo Boscarelli Museo Nicolis , Villafranca di Verona, 25 novembre 2006 Dopo il saluto di Luciano Nicolis , fondatore del Museo, Lorenzo Boscarelli, presidente AISA, ha presentato i relatori: Franco Amatori, direttore del Dipartimento di Storia dell’Industria dell’Università Bocconi di Milano; Pierugo Gobbato, direttore generale della Lancia dal 1969 al 1976; Guido Rosani, che ha restaurato e ricostruito le più belle Lancia da competizione; Mike Robinson, già responsabile del design Lancia. FRANCO AMATORI (estratto da Impresa e Mercato: “Lancia 1906- 1969”) Premessa Nel variegato panorama dell’industria automobilistica italiana dei primi decenni della sua storia, la Lancia si pone quale interessante caso - fra i pochi - di impresa in grado di restare immune dalla crisi che colpisce molte altre piccole-medie aziende simili. Nel periodo in cui, da un lato, nomi illustri quali l’Itala, la Spa e l’Isotta Fraschini escono di scena e, dall’altro, si afferma il predominio della Fiat, la Lancia pare ritagliarsi una propria ben definita fisionomia d’impresa e un ruolo di tutto rispetto nel mercato automobilistico italiano. Quali le ragioni di questa capacità di resistenza e di consolidamento e quali, invece, quelle di un inesorabile declino che, a partire dal secondo dopoguerra avrebbe condotto la società, priva di una vera guida imprenditoriale, sotto il controllo della Fiat? Ed è proprio quella della capacità imprenditoriale la prospettiva analitica che, soffermandosi sulle strategie dell’impresa, sugli aspetti del mercato, sulle politiche statali nei confronti dell’automobile, ripercorre le vicende aziendali di oltre mezzo secolo. -
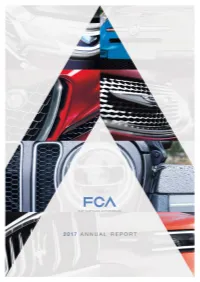
2017 Annual Report
2017 ANNUAL REPORT 2017 | ANNUAL REPORT 3 Table of contents Table of contents Board of Directors and Auditor ...................... 5 Consolidated Financial Statements at December 31, 2017 ................................ 135 Letter from the Chairman and the CEO ......... 7 Consolidated Income Statement ...................... 136 Consolidated Statement Board Report ................................................ 11 of Comprehensive Income/(Loss) ..................... 137 Certain Defined Terms ....................................... 12 Consolidated Statement of Financial Position ... 138 Selected Financial Data ..................................... 13 Consolidated Statement of Cash Flows ............ 139 Risk Factors ...................................................... 16 Consolidated Statement of Changes in Equity .. 140 Overview ........................................................... 32 Notes to the Consolidated Financial Statements .. 141 Our Business Plan ............................................. 34 Company Financial Statements ................ 233 Overview of Our Business .................................. 35 Income Statement ............................................ 234 Operating Results .............................................. 44 Statement of Financial Position ......................... 235 Subsequent Events and 2018 Guidance ............ 76 Notes to the Company Financial Statements .... 236 Other Information ............................................. 246 Major Shareholders .......................................... -

Pier Ugo E Ugo Gobbato Due Vite Per L'automobile
Pier Ugo e Ugo Gobbato Due vite per l’automobile AISA - Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile con il patrocinio del Comune di Volpago del Montello MONOGRAFIA AISA 86 1 Pier Ugo e Ugo Gobbato Due vite per l’automobile AISA - Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile con il patrocinio del Comune di Volpago del Montello 2 Prefazione Roberto Toffoletto 3 Ugo e Pier Ugo Gobbato, attori di un’epoca Lorenzo Boscarelli 4 90 anni nella vita di Pier Ugo Gobbato (curriculum vitae e decorazioni al valor militare) 6 Pier Ugo Gobbato. A futura memoria Intervista di Lorenzo Boscarelli e Angelo Ruffini, Torino 4 marzo 2008 13 Lancia Stratos. Auto vincente contro tutto e contro tutti Pier Ugo Gobbato 17 Ricordo di Ugo Gobbato a 50 anni dalla morte Duccio Bigazzi 23 I Gobbato. Storia e valori ritrovati a Volpago del Montello Marino Parolin 26 Volpago del Montello MONOGRAFIA AISA 86 1 Prefazione Lorenzo Boscarelli per me un grande onore presentare questo do- quello non fosse altro che il primo di tanti omaggi E’ cumento in ricordo di due grandi uomini, Pier rivolti a una così importante figura. Indipendente e Ugo e Ugo Gobbato. dinamico, la sua spiccata intelligenza gli ha consentito, Il Comune di Volpago del Montello rende omaggio seguendo la tradizione del padre, di distinguersi come oramai da tempo all’ingegner Ugo Gobbato con l’in- uno dei massimi dirigenti industriali del settore auto- titolazione della sala consiliare in suo onore, quale il- mobilistico, non solo grazie alla sua dedizione totale lustre cittadino distintosi nel mondo automobilistico al lavoro, ma anche grazie a una concezione moderna italiano e internazionale per le sue capacità professio- della produzione, che lo rese aperto alle novità e ri- nali e umane. -

Vehicle to Transmission Index
Vehicle to Transmission Index ACURA Model Model Year Engine Size Trans Type Transmission Model CL 1996-97 L4 2.2L 4 Spd FWD A6VA CL 1998-99 L4 2.3L 4 Spd FWD B6VA CL 1996-99 V6 3.0L 4 Spd FWD M7ZA CL 2001-03 V6 3.2L 5 Spd FWD MGFA,BGFA CSX 2005-11 L4 2.0L 5 Spd F/AWD TBA EL 2000-05 L4 1.6L, 1.7L 4 Spd FWD TBA Integra 1986-87 L4 1.6L 4 Spd FWD CA Integra 1988-89 L4 1.6L 4 Spd FWD P1 Integra 1994-99 L4 1.8L 4 Spd FWD MP7A, S4XA, SP7A Integra 1991-93 L4 1.8L 4 Spd FWD MPRA Integra 1990 L4 1.8L 4 Spd FWD RO Integra 2000-01 L4 1.8L 4 Spd FWD SKWA Legend 1986-87 V6 2.5L 4 Spd FWD G4 Legend 1987-90 V6 2.7L 4 Spd FWD L5, PL5X Legend 1991-95 V6 2.7L 3.2L 4 Spd FWD MPYA Legend - 1990 V6 - 2.7L 4 Spd FWD PL5X MDX 2001-02 V6 3.5L 5 Spd AWD MGHA, BGHA MDX 2003-04 V6 3.5L 5 Spd AWD MDKA MDX 2005-06 V6 3.7L 5 Spd AWD BDKA MDX 2007-11 V6 3.7L 5 Spd AWD BYFA NSX 1991-05 V6 3.0L 4 Spd RWD MR9A RDX 2007-11 L4 2.3L 5 Spd AWD BWEA RDX 2010-11 L4 2.3L 5 Spd FWD BT3A RL 2001-05 V6 3.2L 5 Spd FWD B7WA RL 1996-04 V6 3.5L 4 Spd FWD M5DA RL 2005-11 V6 3.5L 5 Spd FWD MJBA RSX 2002-06 L4 2.0L 5 Spd FWD MRMA SLX 1996-99 V6 3.2L 3.5L 4 Spd RWD 4L30E TL 1995-98 L5 2.5L 4 Spd FWD M1WA TL 1996-98 V6 3.2L 4 Spd FWD M5HA TL 1999 V6 3.2L 4 Spd FWD B7VA TL 2000 V6 3.2L 5 Spd FWD M7WA TL 2001-03 V6 3.2L 5 Spd FWD B7WA TL A 2004-08 V6 3.2L 5 Spd FWD BDGA TL 1996-04 V6 3.5L 5 Spd FWD M5DA TL TYPE S 2007-08 V6 3.2L 5 Spd FWD BDHA TL & TL TYPE S 2009-11 V6 3.5L, 3.7L 5 Spd A/FWD BK3A, BK4A TSX 2004-07 L4 2.4L 5 Spd FWD MCTA TSX 2010-11 V6 3.5L 5 Spd FWD MM2A Vigor 1991-94 L5 2.5L 4 Spd FWD MPWA ZDX 2009-11 V6 3.7L 6 Spd AWD TBA CRevision 08/2010 1 Vehicle to Transmission Index Cont.. -

Targhe Dell'aeronautica Militare
LE TARGHE E I VEICOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE di Guglielmo Evangelista Negli ormai lontani anni in cui iniziai le mie ricerche, le targhe dell’Aeronautica attirarono in modo particolare la mia attenzione a causa della bassissima numerazione che figurava su quelle delle autovetture. Anche se a quei tempi non l’avevo ancora capito, questa curiosità era semplicemente il risultato del sistema di targatura in uso e certamente non era un indice di estrema anzianità come invece sarebbe stato per le targhe civili, ma ad ogni modo una targa con sopra soli tre numeri rappresentò sempre una particolarità che si è perpetuata fino all’introduzione delle targhe interforze: alla fine degli anni ’90 (ma dato che molti veicoli che le portano sono recenti, questo può capitare ancora oggi e certamente per un po’ degli anni a venire) incontrare, ad esempio, una moderna Fiat Uno targata AM 1xx faceva una certa impressione al confronto non solo delle targhe alfanumeriche dell’Esercito, ma anche delle molto più alte 1xxxx dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa e perfino delle 6xx o 7xx del Vaticano. I veicoli dell’Aeronautica non sono rari ad incontrarsi, ma la loro presenza varia molto da zona a zona: ad ogni modo l’Arma non ha una diffusione capillare come l’Esercito e in certe regioni la sua presenza è limitatissima; tra l’altro, parlando di veicoli, vi sono due aspetti che vanno tenuti ben separati: sulle strade si trovano quasi esclusivamente autovetture e veicoli commerciali di serie, mentre esiste una nutrita schiera di mezzi che alla maggior parte degli osservatori è quasi sconosciuta poiché trascorrono tutta la loro vita negli aeroporti.