I Camion Italiani Dalle Origini Agli Anni Ottanta
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
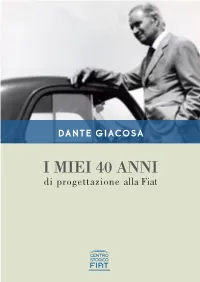
I MIEI 40 ANNI Di Progettazione Alla Fiat I Miei 40 Anni Di Progettazione Alla Fiat DANTE GIACOSA
DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat I miei 40 anni di progettazione alla Fiat DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat Editing e apparati a cura di: Angelo Tito Anselmi Progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino Due precedenti edizioni di questo volume, I miei 40 anni di progettazione alla Fiat e Progetti alla Fiat prima del computer, sono state pubblicate da Automobilia rispettivamente nel 1979 e nel 1988. Per volere della signora Mariella Zanon di Valgiurata, figlia di Dante Giacosa, questa pubblicazione ricalca fedelmente la prima edizione del 1979, anche per quanto riguarda le biografie dei protagonisti di questa storia (in cui l’unico aggiornamento è quello fornito tra parentesi quadre con la data della scomparsa laddove avve- nuta dopo il 1979). © Mariella Giacosa Zanon di Valgiurata, 1979 Ristampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. … ”Noi siamo ciò di cui ci inebriamo” dice Jerry Rubin in Do it! “In ogni caso nulla ci fa più felici che parlare di noi stessi, in bene o in male. La nostra esperienza, la nostra memoria è divenuta fonte di estasi. Ed eccomi qua, io pure” Saul Bellow, Gerusalemme andata e ritorno Desidero esprimere la mia gratitudine alle persone che mi hanno incoraggiato a scrivere questo libro della mia vita di lavoro e a quelle che con il loro aiuto ne hanno reso possibile la pubblicazione. Per la sua previdente iniziativa di prender nota di incontri e fatti significativi e conservare documenti, Wanda Vigliano Mundula che mi fu vicina come segretaria dal 1946 al 1975. -

RAPID Ceirano & C., Welleyes, F.Lli Ceirano
RAPID Ceirano & C., Welleyes, F.lli Ceirano, STAR Rapid, Matteo C. & C., Itala, Ceirano-Ansaldo, SPA, Junior, SCAT, S.A.Giovanni Ceirano: sono undici aziende, accomunate da due denominatori, sono tutte nate a Torino e sono tutte sorte per iniziativa di uno o dell'altro dei fratelli Ceirano. Addentrarsi nelle vite e nelle frenetiche attività dei quattro fratelli, distinguendo l'apporto di ciascuno, non è facile. I Ceirano sono una famiglia piemontese, originaria di Cuneo, composta da padre, madre e quattro fratelli: Giovanni Battista, nato nel 1860, Giovanni, nato nel 1865, Matteo, il viveur della famiglia, di cinque anni più giovane, ed Ernesto, nato dopo altri cinque anni. A questi si aggiunge in un secondo tempo il figlio di Giovanni che, con una certa mancanza di fantasia, è battezzato Giovanni e chiamato Ernesto. Come si vede, ci sono già i presupposti per una bella confusione, anche a prescindere dai rispettivi caratteri, che sicuramente devono essere stati piuttosto determinati, per non dire litigiosi e testardi, anche perché uno dopo l'altro si consacrano al medesimo mestiere: fondare aziende automobilistiche. Fondare, per poi andarsene, o fonderle con altre, o scioglierle, o rilevarle, in un caleidoscopio di società che vivacizzarono ed arricchirono molto il panorama industriale torinese ed italiano. Il primo a muoversi è naturalmente Giovanni Battista, il più anziano. Fonda la Ceirano & C. nel 1898 e la Welleyes nel 1899; quindi nel 1901, insieme a Matteo, la F.lli Ceirano, in corso Vittorio Emanuele 9. Liquidata questa nel 1903, nel 1904 trasforma la Ceirano & C. in STAR, Società Torinese Automobili Rapid, oggetto di questa breve indagine. -

2014 Kraftstoffförderung Fuel Supply and Control
Inklusive Dieselfahrzeuge Includes diesel-engine vehicles Véhicules diesel compris Veicoli diesel inclusi Включая дизельные автомобили de en fr it ru Sichere Diagnose. Reliable diagnosis. Diagnostic fiable. Diagnosi sicure. Ripara- Надежная диагностика. Zeitsparende Reparatur. Time-saving repairs. Réparation rapide. zioni rapide. Diagnostica, Экономящий время Bosch-Diagnostics und Bosch diagnostics and Diagnostics et pièces ricambi e formazione: tutto ремонт. Диагностическое Ersatzteile. service parts. de rechange Bosch. da un unico fornitore. оборудование и запчасти Bosch. Alles aus einer Hand. Everything from a single Un fournisseur unique. Bosch offre all’officina un Bosch bietet der Werkstatt source. Bosch offers a full Bosch propose aux pro- programma completo per Все из одних рук. ein Komplettprogramm range of products that boo- fessionnels une gamme una maggior efficienza e Bosch предлагает СТО zur Steigerung von Effizienz sts everyday efficiency and complète qui améliore qualità nel lavoro quotidia - полную программу, обе- und Qualität in der täglichen quality in the workshop. l’efficacité et la qualité du no d’autoriparazione. Con спечивающую повышение Arbeit. Service parts are available travail quotidien. il programma «Diagnostics», эффективности и качества Vom weltweit aktiven from the globally active En tant que concepteur Bosch mette a disposizione в повседневной ее работе. Entwickler und führenden developer and leading man- présent dans le monde en- dell’officina anche hard- Оригинальное качество Hersteller von Kfz-System- ufacturer of automotive sy- tier et leader dans la fabri- ware e software di diagnosi запчастей от мирового раз- technik kommen die Ersatz- stem technology in renow- cation de systèmes pour perfettamente in sintonia работчика и ведущего из- teile in bekannter Original- ned Bosch OE quality. -

San Salvario Il Quartiere Della Nascita Dell'auto a Torino
San Salvario Il quartiere della nascita dell'auto a Torino A cura di Enrico Miletto, Fondazione Vera Nocentini e Donatella Sasso, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini 1 Origini e topografia del quartiere Il quartiere deriva il proprio nome dalla chiesa di San Salvatore in Campagna (da qui la popolare denominazione di San Salvario), edificata da Amedeo di Castellamonte tra il 1646 e il 1653, per volontà della Madama Reale Cristina di Francia. Da un punto di vista topografico, l’area di San Salvario è delimitata dai corsi Massimo d’Azeglio, Vittorio Emanuele II, Bramante e dalla via Nizza. Il borgo vero e proprio inizia a prendere forma soltanto a partire dalla metà dell’Ottocento, quando sorgono i primi insediamenti urbani, attigui alla campagna circostante. Orti, giardini, campi e vivai definiscono la porzione di territorio che dalla strada reale di Nizza (l’attuale via Nizza) arriva fino al Valentino. 2 Porta Nuova e commercio 1848-1852 Viene inaugurato il primo tratto ferroviario che collega Torino a Moncalieri seguito, nel 1853, da quello con Genova. Lo sviluppo dello scalo ferroviario di Porta Nuova, la cui direttrice divide San Salvario dai vicini rioni della Crocetta e di San Secondo, favorisce la crescita nel quartiere di attività commerciali. Sorgono così botteghe e aziende artigianali che contribuiscono a disegnare un’immagine di un quartiere dai ritmi concitati, una piccola city, operosa e indaffarata, le cui strade, ricche di negozi e botteghe, sono percorse, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, da carri trainati da cavalli, tramways e carretti. San Salvario conta all’epoca 50 isolati, circa 200 abitazioni ed è sede di una delle 10 preture cittadine. -

Combined VSCC Index - Car Marques - Revised Alphabetical Sequence
Code: File 2 - Excel - Combined VSCC Index - Car Marques - Revised Alphabetical Sequence. - 28.5.20. Vintage Sports Car-Club Ltd. - Bulletin Index 1935 to 2009 Bulletin No.264 Combined Car Marques - plus Aeroplanes, Bicycles, Motorcycles, Odds and Ends. Go to the Miscellaneous Section after the Z entries Code Marque Details No.87-3-65-35 A. B. C. 1922 front & offside views JS 1478 Cameron's car No.176-4-87-69 ABC 1923 offside and front views KB 7084 Aston Clinton No.215-2-97-77 A B C offside and front view - Hakan Sandberg car No.220-3-98-77 ABC Rally 1928 leads cars through the chicane at Montlhery - Yves Millot No.71-2-61-35 A. C. Anzani two seater Peter Spreadbury No.71-2-61-38 A. C. Six front and side view Roger McDonald No.88-4-65-21 A. C. nearside view of Pollard's car at Silverstone No.116-4-72-64 AC offside view of broken con rod and crankcase No.119-3-73-16 AC front & nearside view at Shelsley Walsh, Willoughby & Mays up No.119-3-73-64 AC Nash BMX 72 and Delahaye behind, offside views No.123-3-74-26 AC front view of car with Jenks driving at Brooklands No.139-3-78-13 AC front and offside view pursues Mann's Monza Alfa No.141-1-79-13 A.C. front aerial view of BM 6678 with Hamish Moffat visible No.143-3-79-11 A.C Cognac front view out of Cascades No.154-2-82-10 AC front & offside view 373 PPG with Bowyer driving No.154-2-82-27 AC replica 200 Mile Race Car front & nearside views No.158-2-83-24 AC in the water Northern Rally 373 PPO No.169-1-86-25 AC 16/80 1935 front view with David Hescroff No.173-1-87-78 AC 16/80 DPD 40 David Hescroff rear offside view No.176-4-87-65 AC single seater, o.h.c. -

La Storia Del Logo Fiat
La storia del logo Fiat Fiat Automobiles Nazione Italia Tipologia Società per azioni Fondazione 1899 a Torino Sede principale Torino Gruppo Fiat SpA (tramite Fiat Group Automobiles) Persone chiave Olivier François, Direttore operativo Settore Metalmeccanica (Autoveicoli) Prodotti autovetture Slogan Life is best when driven Sito web www.fiat.it La FIAT (nata come acronimo di Fabbrica Italiana Automobili Torino), nota come Fiat Automobiles negli Stati Uniti, è stata fondata l'11 luglio 1899 a Torino come casa produttrice di automobili, per poi sviluppare la propria attività in numerosi altri settori, dando vita al più importante gruppo finanziario e industriale privato italiano. Dal 1º febbraio 2007 fa parte, insieme ai marchi Alfa Romeo, Lancia, Abarth e Fiat Professional, di Fiat Group Automobiles (abbreviato in FGA) che rappresenta una delle diramazioni del gruppo industriale Fiat SpA. Storia e direzione aziendale L'azienda nacque dalla comune volontà di una decina tra aristocratici, possidenti, imprenditori e professionisti torinesi di impiantare una fabbrica per la produzione di automobili. L'idea di produrre automobili su scala industriale era venuta agli amici Emanuele Cacherano di Bricherasio e Cesare Goria Gatti (già fondatori dell'ACI Automobile Club d'Italia) che avevano precedentemente costituito e finanziato la "Accomandita Ceirano & C.", finalizzata alla costruzione della "Welleyes", un'automobile progettata dall'ing. Aristide Faccioli e costruita artigianalmente da Giovanni Battista Ceirano. Visto il successo ottenuto dalla "Welleyes" alla sua presentazione, Bricherasio e Gatti proposero ad un gruppo di conoscenti di acquisire le esperienze, le maestranze e la competenza della "Accomandita Ceirano & C." per trasferirle su scala industriale, come già avveniva nella fabbriche dell'Europa settentrionale. -
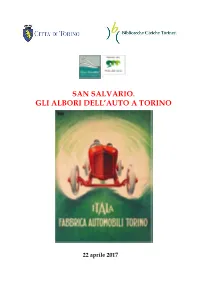
San Salvario. Gli Albori Dell'auto a Torino
SAN SALVARIO. GLI ALBORI DELL’AUTO A TORINO 22 aprile 2017 Il testo e le immagini derivano dal progetto didattico “ Torino e le fabbriche ” che si rivolge alle scuole secondarie di primo e secondo grado torinesi ed è mirato alla lettura della storia industriale del territorio e a una riflessione sull’evoluzione industriale e sociale della città. Il progetto è realizzato dall’ISMEL (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali). San Salvario: gli albori dell’auto a Torino. A cura di Enrico Miletto TORINO E L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA. DA FINE OTTOCENTO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE Le principali tappe dello sviluppo dell’industria automobilistica torinese e italiana, con un riferimento costante al contesto internazionale. Conferenze a cura di Aldo Enrietti, volontario del progetto Senior civico . SAN SALVARIO. GLI ALBORI DELL’AUTO A TORINO Sabato 22 aprile, ore 10.30 Una camminata nel quartiere avvia un percorso in più tappe sulla storia dell’industria automobilistica a Torino da fine Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, in programma presso la Biblioteca centrale a partire dal 26 aprile. A cura di Enrico Miletto ( Fondazione Nocentini – Polo del ‘900) e Aldo Enrietti , volontario del progetto Senior civico. INCONTRI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE Mercoledì 26 aprile, ore 17.30 Dalla carrozza all’automobile Storia del progressivo passaggio da un mezzo di trasporto all’altro, con particolare attenzione all’industria automobilistica torinese dalla fine dell’Ottocento alla Prima Guerra Mondiale. Mercoledì 10 maggio, ore 17.30 I protagonisti dell’automobile a Torino Le imprese storiche in città: i fratelli Ceirano, Giovanni Agnelli, Vincenzo Lancia. -

Filtros De Combustible 26.652.00
FILTROS DE COMBUSTIBLE 26.652.00 IMAGEN INDICATIVA Dimensiones (mm) A: 62.0 B: 14.0 C: 14.0 D: E: F: G: H: 50.0 bar: R: 8003453080546 DISPONIBLE EN NUESTRA GAMA Unidades por caja:1 Cantidad por paquete:10 Caja (largo x ancho x alto):65x65x70 Cantidad por palet:2730 Palet (ancho x largo x alto):800x1200x1100 Peso filtro:60 Peso filtro con la caja:69 FICHA DEL FILTRO página 1/9 FILTROS DE COMBUSTIBLE 26.652.00 APLICACIONES AGRIP 23 23 26 26 ALFA ROMEO A15 A15 01/67 → 12/71 A19 A19 01/67 → 12/71 A38 A38 01/67 → 12/71 F20 F20 01/71 → 12/74 ARNOUX GENERIC GENERIC 01/70 → GENERIC GENERIC → 12/69 GENERIC GENERIC ARO 240 D 2.1 Diesel (Peugeot XD4/90) 01/71 → 12/03 240 D 2.5 Diesel (Peugeot XD3P) 10/81 → 12/03 240 D 2.5 Diesel (Peugeot XD3P) 01/77 → 09/81 241 D 2.5 Diesel (Peugeot XD3P) 10/81 → 12/03 241 D 2.5 Diesel (Peugeot XD3P) 01/77 → 09/81 243 D 2.1 Diesel (Peugeot XD4/90) 01/72 → 12/96 243 D 2.5 Diesel (Peugeot XD3P) 10/81 → 12/96 243 D 2.5 Diesel (Peugeot XD3P) 01/77 → 09/81 244 D 2.1 Diesel (Peugeot XD4/90) 01/72 → 12/96 244 D 2.3 Diesel (Peugeot XD2) 01/72 → 12/96 244 D 2.5 Diesel (Peugeot XD3P) 10/81 → 12/96 244 D 2.5 Diesel (Peugeot XD3P) 01/77 → 09/81 AVIA 1000 Serie 1000 (Perkins 4.128) 09/76 → 12/80 1000 Serie 1000 (Perkins 4.128) 09/76 → 12/80 1000 Serie 1250 (Perkins 4.128) 09/76 → 10/84 1000 Serie 1500 (Perkins 4.192) 01/72 → 10/84 20 Serie 20 (Perkins 4.203) 01/63 → 12/80 20 Serie 26 (Perkins 4.203) 01/63 → 12/80 2000 Serie 2500 (Perkins 4.203) 01/63 → 12/80 2000 Serie 2500 (Perkins 4.203) 01/72 → 10/84 2000 Serie 2500 (Perkins -

EMILIO PUGNO” CGIL Regionale Del Piemonte Camera Del Lavoro Di Torino FIOM CGIL Del Piemonte
1 ASSOCIAZIONE “EMILIO PUGNO” CGIL Regionale del Piemonte Camera del Lavoro di Torino FIOM CGIL del Piemonte Il racconto della memoria Storia della SCA a cura di Ruggero Pugno Dopo la fase decisiva di crescita degli anni ’60, il Sindacato si rinnova nei Consigli. Ma nei Consigli stessi, e, a maggior ragione, nelle strutture esterne ai luoghi di lavoro, la CGIL, e il Sindacato nella sua fase unitaria, rimane strutturalmente ambiguo. A Torino, un nucleo dirigente fondamentale attraversa queste contraddizioni mantenendo a lungo un equilibrio organizzativo e politico di forte carattere progressivo …… il cui fondamento è il potere contrattuale sui luoghi di lavoro ed una estensione dell’intervento del movimento sindacale sui temi delle riforme sociali e della programmazione economica…… su un indirizzo strategico nel quale lo sviluppo del potere contrattuale si associ, si integri con la politica delle riforme, il cui successo è legato precisamente a questa associazione e integrazione Sergio Garavini 2 Questo libro è dedicato: all’amico Michele Giannatempo, all’amico Valentino Formaggi, all’amico Franco Isnardi, ad Alessandro Tarzariol, al Signor Oddone e alla Signora Oddone Un ringraziamento a quelli che hanno contribuito e creduto alla sua realizzazione ed uno in particolare all’amico e storico Donato Antoniello 3 PREFAZIONE Il lavoro del disegnatore tecnico di carrozzeria è un’attività che nasce e si costruisce con una buona dose di perseveranza e di volontà. Deve piacere; poiché è molto selettivo ti può far stare al palo o diventare un progettista. Non esiste una laurea per il progettista di carrozzeria, esiste quella da ingegnere di meccanica, motorista, aeronautica, architettura, per cui, in carrozzeria, ti devi creare il mestiere e perfezionarlo sempre più da solo. -

Bentley Speed Six the Ultimate in Power, Luxury and Competition Pedigree
FORD MODEL T MAZDA COSMO FORD XR6 TF R47.00 incl VAT May 2017 BENTLEY SPEED SIX THE ULTIMATE IN POWER, LUXURY AND COMPETITION PEDIGREE STYLE & SUBSTANCE COMMEMORATING ENZO RENAULT’S CARAVELLE AND R8/10 FERRARI ENZO – FRENCH FLAIR THE MAN AND THE CAR DICKON DAGGITT | BMW 2002 RESTORED | DENNIS GUSCOTT PCC_Porsche Classic_210x276.qxp_Porsche 210x275 2017/04/05 11:46 AM Page 1 www.porschecapetown.com The first Porsche built boasted exceptional everyday practicality. Nothing has changed. Porsche Centre Cape Town. As a Porsche Classic Partner, our goal is the maintenance and care of historic Porsche vehicles. With expertise on site, Porsche Centre Cape Town is dedicated to ensuring your vehicle continues to be what it has always been: 100% Porsche. Our services include: • Classic Sales • Classic Body Repair • Genuine Classic Parts • Classic Service Porsche Centre Cape Town Corner Century Avenue and Summer Greens Drive, Century City Tel: 021 555 6800 CONTENTS — CARS BIKES PEOPLE AFRICA — MAY 2017 WORK & PLAY THE ROTARY CLUB 03 Editor’s point of view 64 Mazda Cosmo turns 50 CLASSIC CALENDAR DYNAMIC BEST-SELLER 06 Upcoming events for 2017 70 A modern classic – Mazda MX-5 NEWS & EVENTS PADKOS 08 All the latest from the classic scene 72 Backseat Driver – a female perspective THE MAGIC FORMULA 18 50 years of Formula Ford racing A CLASSIC RACER 74 Bike racer and tuner Dennis Guscott CARBS & COFFEE 22 All the ingredients THE FAMOUS FELINE’S FOUNDER 78 Sir William Lyons COMMEMORATING ENZO 24 Celebrating Ferrari’s 70th THE PERFECT CLASSIC with an Enzo -

Feisty Fiats! Trofeo Racer in Action
ABARTH ● ALFA ROMEO ● FERRARI ● FIAT ● LANCIA ● MASERATI Issue 292 June 2020 £4.99 ALFASUD FEISTY FIATS! TROFEO RACER IN ACTION ALFA 6C GILCO GHIA 500 ZAGATO 131 ABARTH PININFARINA 90 years of design LOST LAMBORGHINIS I I Prototypes revealed I RALLIES & EVENTS Reports in detail FERRARI 225 S 1952 Vignale www.auto-italia.co.uk www.auto-italia.co.uk £80,000 FERRARI FF – SHOULD YOU TAKE THE PLUNGE? Alfa Romeo GTV Cup Alfa Romeo 147 V6 24V GTA 53,854 miles. One owner for the last 16 years. GTV Cup number 79. Full Just completed a major service including cambelts, service history and is completely original. Last serviced in September 2019 and water pump and brakes. 127,598 miles. had a new timing belt in September 2017. £11,995 Price: £9,490 * No 1 out of 180 Fiat, Alfa Romeo and Chrysler Jeep dealers for customer satisfaction in the UK. Oct-Dec 2018 * No 1 out of 165 Fiat, Alfa Romeo and Chrysler Jeep dealers for customer satisfaction in the UK. July-Sep 2018 * No 1 out of 165 Fiat, Alfa Romeo and Chrysler Jeep dealers for customer satisfaction in the UK. April–June 2018 * No 1 out of 165 Fiat, Alfa Romeo and Chrysler Jeep dealers for customer satisfaction in the UK. Jan-Mar 2018 WELCOME www.auto-italia.net Editor Chris Rees [email protected] Photographic Editor Michael Ward [email protected] Events Director Phil Ward [email protected] Editor at Large Peter Collins Contributors Peter Collins, Richard Heseltine, Andy Heywood, Martin Buckley, Peter Nunn, Simon Park, Steve Berry, Simon Charlesworth, Mike Rysiecki, Tim Pitt, Richard Dredge, Bryan McCarthy, and Phil Ward Art Editor Michael Ward Tel: 01462 811115 Back Issues Tel: 01462 811115 Subscriptions www.auto-italia.net [email protected] Managing Director Michael Ward General Manager Claire Prior [email protected] Advertisement Managers David Lerpiniere [email protected] Simon Hyland o here I sit, like millions of us, working from home. -

Hornby Railways
Vectis Auctions, Vectis Auctions, Fleck Way, Thornaby, Oxford Office, Stockton-on-Tees, TS17 9JZ. Unit 5a, West End Industrial Estate, Telephone: 0044 (0)1642 750616 Witney, Oxon, OX28 1UB. Fax: 0044 (0)1642 769478 Telephone: 0044 (0)1993 709424 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Website: www.vectis.co.uk TWO DAY SALE Specialist & General Toy Sale Thursday 18th January 2018 - 10.00am Model Train Sale Friday 19th January 2018 - 10.30am Room and Live On-Line Auctions at Thornaby, Stockton-on-Tees, TS17 9JZ. Viewing available on the day of the Sale from 8.00am. Bidding can be made using the following methods: Commission Bids, Postal/Fax Bids, Telephone Bidding - If you intend to bid by telephone please contact our office for further information on 0044 (0)1642 750616. Internet Bidding - you can bid live on-line with www.vectis.co.uk or www.invaluable.com. You can also leave proxy bids at www.vectis.co.uk. If you require any further information please contact our office. FORTHCOMING AUCTIONS Model Train Sale Friday 16th February 2018 Specialist Sale Tuesday 20th February 2018 Specialist Sale Wednesday 21st February 2018 General Toy Sale Thursday 22nd February 2018 TV & Film Related Toy Sale Wednesday 28th February 2018 Details correct at time of print but may be subject to change, please check www.vectis.co.uk for updates. Managing Director Vicky Weall Cataloguers Michael Bond, Mike Delaney, Ian Main, David Bowers, Sean Moloney & Matthew Cotton Photography Paul Beverley & Andrew Wilson Data Input Patricia McKnight & Andrea Rowntree Layout & Design Andrew Wilson & Simon Smith A subsidiary of The Hambleton Group Ltd - VAT Reg No.