Il Benaco: Una “Spina” Nel Cuore Di D'annunzio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

September 02
בסייד THE GRAND HOTEL, PRESOLANA, ITALY Enjoy a Family Friendly Summer Experience in the Magnificent Italian Alps! Family Packages with Affordable Prices for 7 nights Weekly Sunday June 26 – July 17, 2016 Weekly Tuesday August 16 – September 6, 2016 From your room be delighted by the panoramic view of the majestic Orobie Alps guaranteeing you the intimacy of a relaxing vacation! Under 2hrs drive from Milan Airport; the Presolana Pass is at 1300M altitude Large social lounge, piano bar and billiards room and more Wellness Centre with private massage rooms, 2 indoor pools, sauna & Turkish Bath Activities for all ages & kids club. biking, hiking, golf, horse riding, shopping & more Daily Minyanim, Shabbat atmosphere and thought provoking lectures The Haute Gourmet Italian Cuisine will be freshly prepared by Executive Italian chefs of Elite Kosher Events, Minkowitz family, Milan, creating a world class culinary experience drawing the best of Italian, continental and traditional Jewish fare. The gourmet culinary delicacies will be under the Kosher supervision of Rabbi G.M. Garelik of Milan. Glatt Mehadrin & Cholov Yisrael Exciting optional tour package to Brescia, Bergamo & Sirimone, Gardaland, Iseo Town and more will round out a truly unique Italian summer experience for your Family Personally hosted by our experienced Eddie’s Kosher Travel staff 1. POST: EDDIE’S KOSHER TRAVEL & TOURISM LTD; P.O. BOX 568, MODIIN, 7171801, ISRAEL ISRAEL: +972 2 992 9801 USA: +1 646 240 4118 EUROPE: +44 207 048 6168 FAX: +972 2 992 9802 Email [email protected] WWW.KOSHERTRAVELERS.COM בסייד Enjoy our Amazing Full Day Optional Tours & Activities Package!!! Day 1: Magical Bergamo & Gromo Bergamo is a beautiful Italian town nestled in the foothills of the Alps. -

Giardini D'autore
GIARDINI stiche particolari presenti nel solo bacino Insubrico. Poi le incredibili limonaie del lago di Garda… lo storico Domenico Fava scrive: “...si D’AUTORE attribuisce la prima introduzione dei limoni, nel sec. XIII, dalla Riviera genovese sul Garda, ai frati del convento di San Francesco di Gargnano. Per proteggere piante e HEAVEN GREEN E I SUOI GIARDINI D’AUTORE, frutti dagli occasionali freddi invernali, a partire dal sec. XVII si costruirono le prime DOVE LA TRADIZIONE DELLE DOLCI COLLINE limonaie, con muraglie, pilastri, scale, portali, travi su cui, da novembre a marzo, si MORENICHE INCONTRA “SPAZI VERDI” IN SINTONIA fissavano assi e vetrate. Fu durante la prima metà del Settecento che si ebbero gli CON L’AMBIENTE MEDITERRANEO DEL LAGO DI GARDA. interventi più consistenti. Da allora il Benaco fu “il paese dei limoni” più a nord d’Europa. Tutto l'arco del golfo restò segnato dalle nuove imponenti strutture, Attorno alle luminose rive del lago di Garda, perla azzurra delle Insubrie Orientali immortalate nelle stampe, decantate nelle pagine di scrittori e poeti. Fu la zona di come nomina lo svizzero Christ, la vegetazione meridionale dei parchi costituisce produzione d'agrumi per scopo commerciale più settentrionale al mondo; i limoni un indice assai probante di un clima a temperatura elevata e di spiccata bassa umi- venivano esportati a centinaia di migliaia soprattutto in Germania, in Polonia, in dità. La notevole presenza di piante d’Olivo, largamente coltivato lungo le sponde Russia, garantendo lavoro e profitti non indifferenti.” del Benaco e sulle dolci colline moreniche e dell’Alloro, le cui gradazioni trovano Oggi rimangono “Giardini” visitati dal turismo internazionale, come la “Limonaia del contrappunto nell’elegante slancio dei numerosi Cipressi, confermano come que- Castel” a Limone sul Garda, la limonaia del “Pra de la Fam” e le limonaie di sti territori si presentino con caratteristiche proprie di un lembo a nord di mediter- Gargnano. -

International Chamber Music Festival 2016 - XX Iª Edizione
Riva del Garda - Limone sul Garda - Tremosine sul Garda - Tignale Gargnano - Gardone Riviera - Toscolano Maderno - Isola del Garda International Chamber Music Festival 2016 - XX Iª Edizione Associazione Cultura In Musica Limes Alba a Toscolano. Foto Riccardo Podavini. Patrocinio con Contributo XXIª EDIZIONE International Chamber Music Festival Alla scoperta degli antichi luoghi del Garda Riva d/Garda - Limone s/Garda - Tremosine s/Garda Tignale - Gargnano - Toscolano Maderno Gardone Riviera - Isola del Garda 2016 Con il contributo del Con il contributo del Con il contributo del Con il contributo del Con il contributo del COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI TIGNALE TREMOSINE SUL GARDA GARGNANO TOSCOLANO MADERNO GARDONE RIVIERA Calendario concerti 2016 XXIª Edizione International Chamber Music Festival B - Venerdì 6 Maggio Pieve di Tremosine s/G Chiesa San Giovanni ore 20.30 Pag. 29 ENSEMBLE NOVALIS Musiche dedicate all’alba di Haydn - Grieg - Strauss - Respighi B - Sabato 28 Maggio Gargnano Convento San Tommaso ore 17.00 Pag. 51 ORCHESTRA ACCENTO JUNIOR (Austria) Musiche di Händel - Bach - Telemann - Bruckner - Grieg B - Domenica 19 Giugno Gargnano Marina di Bogliaco ore 21.00 Pag. 61 DUO Christian Elin, Sassofono e Clarinetto basso - Maruan Sakas, Pianoforte Musiche per l’alba di Frescobaldi - Bach - Jarret/Gabarek - Elin B - Sabato 25 Giugno Limone s/G Chiesa San Benedetto ore 21.00 Pag. 24 RECITAL Frieder Berthold, Violoncello - Carlo Levi Minzi, Pianoforte Musiche di Zemlinsky - Beethoven - Strauss C - Domenica 3 Luglio Isola del Garda ore 18.30 Pag. 88 ENSEMBLE GAGGIA Lars Grünwoldt, Baritono Musiche di Beethoven - Conci - Brahms B - Domenica 10 Luglio Toscolano Maderno Museo della Carta ore 17.30 Pag. -

Gardasee! Entwickelt Vom Touren-Spezialisten Seit 1902 Gardasee Der Romantik
Rille 5,25 10 mm 5,25 Rille Umschlag Außen 1 mm 1 mm on tour Kulinarik, Kunst und Kultur Erleben & Entdecken. Die schönsten Touren in den Hauptstädten Alle Touren. am Gardasee! Entwickelt vom Touren-Spezialisten seit 1902 Gardasee der Romantik. und Erfinder des kompakten Reiseführers Region Dauer Seite Stressfrei ankommen, ganz ohne Auto. Mit Muße um den 7 Tage › S. 10 Gardasee Fliegen Sie mit Der Gardasee für Aktive 7 Tage › S. 12 Air Dolomiti! Gardasee Kulturelle Höhepunkte 6 Tage › S. 14 Mittelalter an der Das Nord- & 2 Tage › S. 44 Riviera degli Olivi Ostufer Bild © Shout / DB agency Tageswanderung auf Das Nord- & 6½ Std. › S. 45 dem Monte Baldo Ostufer Erleben Sie auf 14 besonderen Touren die schönsten Seiten des Gardasees und seines reizvollen Hinterlands, zauberhafte Orte wie Sirmione, Malcesine Das Nord- & und Salò und kulturelle Höhepunkte wie in Verona und Brescia. Genießen Auf Goethes Spuren 1 Tag › S. 45 Ostufer Sie italienisches Lebensgefühl vor hinreißenden See-Panoramen in herrlich gelegenen Hotels und Restaurants rund um den See. Landwirtschaft und Das Westufer 1 Tag › S. 72 altes Gewerbe MÜNCHEN VERONA Auf der Hochebene Die POLYGLOTT-Versprechen Das Westufer 1 Tag › S. 73 von Tremosine 3 MAL PRO TAG Verfügbarkeit in Kombination mit einem Rückflug. Gebühren und Abgaben inklusive. Gebühren Stand von 01/02/2014 und Abgaben inklusive. Gebühren in Kombination mit einem Rückflug. Gebühren Verfügbarkeit Unvergessliche Momente erleben mit unseren TOP 12 * Der mondäne Gardasee Das Westufer 1 Tag › S. 74 Reise-Highlights mit flipmap mit Zielsicher versteckte Ecken entdecken mit den MÜNCHEN Wo Italiens Einheit MÜNCHEN VENEDIG Das Südufer 1 Tag › S. -

Rootstrada Dei Vini - Cartina2018.Pdf
Riva PERCORSI IN BICICLETTA/ BIKE TOURS 1° percorso 32 km | 2,5 ore Sirmione - Lugana I Un giro godereccio tra i vigneti della Lugana. Inizio e fine del percorso è la penisola di Sirmione, che può essere raggiunta anche in battello. Non ci sono particolari difficoltà durante il tragitto di 32 km. 7 15 D Genießer-Rundtour durch die Weinberge der Lugana. Start- Limone und Zielpunkt ist Sirmione, das auch mit der Fähre angefahren 4° percorso werden kann. Die 32 km lange Strecke weist keine besonderen 33 km | 3,5 - 4 ore Salò - Rocca di Manerba Schwierigkeiten auf. 1 I La Valtènesi si mostra dal suo dolce lato lacustre. E A round-tour for pleasure-lovers through the vineyards Attraversando ampi oliveti scopriamo la maestosa Rocca di of Lugana. Starting point and finish is Sirmione, which can Manerba. be reached by ferry. This route of 32 km does not present any particular difficulties. D Das Valtènesi zeigt sich von seiner sanften, dem Gardasee zugewandten, Seite. Der Rundweg führt durch Olivenhaine - und 8 vorbei am imposanten Felsen Rocca di Manerba. 2° percorso Tremosine 30 km | 2,5 - 3 ore Bedizzole - Valtènesi E The Valtènesi region presents itself from its soft side, the one facing Lake Garda. The round tour takes us through olive groves - Pieve I Un percorso variegato attraverso l’entroterra della Valtènesi. and past the impressive rock Rocca di Manerba. La pista ciclabile si snoda attraverso un dolce paesaggio collinare intorno al paese di Bedizzole. Qui domina la calma assoluta, 5° percorso lontano dai grossi movimenti turistici. 19 km | ca. -

Rassegna 2015 Menù Pesce Di Lago Dal 5 Settembre Al 18 Dicembre La Strada Dei Vini E Dei Sapori Del Garda
I NOSTRI PRODOTTI CON RASSEGNA 2015 MENÙ PESCE DI LAGO DAL 5 SETTEMBRE AL 18 DICEMBRE LA STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, fra le più antiche d‘Italia, si estende lungo le suggestive rive bresciane del Lago di Garda: dalle ripide montagne di Limone e Tremosine, nell‘estremo nordovest, passando dalla Riviera mondana di Gardone e Salò, fino alla Valtènesi e alla dolce riva meridionale, sotto la penisola di Sirmione. Una Strada che unisce la natura e la gente che ci abita e che invita l‘ospite attento ad intraprendere una gita alla scoperta delle particolarità di questo territorio. Vi aspettano delizie culinarie, culturali e paesaggistiche. Percorrere queste strade è la perfetta occasione per godersi una sosta lontano dai sentieri più battuti di una regione turistica che è tra le più amate di tutta l‘Italia. The Lake Garda Wine and Food Road, one of Italy’s oldest, follows the western side of Lake Garda, from the steep mountains of Tremosine and Limone in the extreme north-west to the tourist riviera of Gardone and Salò, and on to Valtenesi and the gently rolling hills to the south of the Sirmione peninsula. The Wine and Food Road combines the beauty of nature with the friendliness of the local inhabitants, inviting visitors to take time out to discover what this area has to offer. Culinary delights, cultural attractions and stunning landscapes are there to be enjoyed, the ideal opportunity to explore places off the beaten track in one of Italy’s best loved tourist regions. -

ART and CULTURE INDEX CITY of ART
ART and CULTURE INDEX CITY OF ART . pag. 4 SANTA GIULIA CITY MUSEUM . pag. 6 The Monumental Complex of San Salvatore-Santa Giulia THE ROMAN AGE . pag. 8 DISCOVERING BRESCIA . pag. 10 Piazza del Foro and Capitolium (Capitolium temple) The Castle, Arms Museum and Risorgimento Museum Teatro Grande and the International Piano Festival Duomo Nuovo Duomo Vecchio Tosio Martinengo Art Gallery Diocesan Museum AROUND BRESCIA . pag. 14 Musil Pinac – Aldo Cibaldi International Children At Gallery Mazzucchelli Museums Mille Miglia Museum National Museum of Photography Marble Route LAKE GARDA . .. pag. 18 Vittoriale degli Italiani Rocca and Ugo Da Como House-Museum Isola del Garda Prehistorical pile-dwellings in the alps Catullus’ Grotto and Sirmione Castle Rome and the middle ages on the shores of the lake The places of the Republic of Salò Tower of St. Martino The paper valley CAMONICA VALLEY . pag. 22 Archeopark Cerveno Via Crucis Romanino route Adamello White War Museum TROMPIA VALLEY . pag. 26 Paul VI Collection of contemporary art Iron and Mine Route Sacred Art Route The forest narrates Other museums SABBIA VALLEY . pag. 30 The sacred and the profane Bagolino Carnival Rocca d’Anfo LAKE ISEO AND FRANCIACORTA . pag. 32 Monastery of San Pietro in Lamosa Rodengo Saiano Olivetan abbey Via Valeriana, between the Lake and the valley Ome forge BRESCIA PLAIN . pag. 34 Tiepolo in Verolanuova Padernello Castle PHOTO CREDITS: Thanks to: Assessorato al Turismo - Comune di Brescia, Archivio fotografico Musei Civici d’Arte e Storia, Fondazione Brescia Musei, Fondazione Pinac, Musei Mazzucchelli, Fondazione Ugo Da Como, Fondazione Il Vittoriale degli italiani, Centro camuno di studi preistorici, Bresciainvetrina, Mediateca del SIBCA di Valle Trompia. -
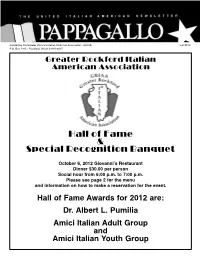
40569 Fall 2012 29056GRIAA Papfall07 9/4/12 8:05 AM Page 1
40569 fall 2012_29056GRIAA_PapFall07 9/4/12 8:05 AM Page 1 Funded by the Greater Rockford Italian American Association - GRIAA Fall 2012 P.O. Box 1915 • Rockford, Illinois 61110-0415 Greater Rockford Italian American Association Hall of Fame & Special Recognition Banquet October 6, 2012 Giovanniʼs Restaurant Dinner $30.00 per person Social hour from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Please see page 2 for the menu and information on how to make a reservation for the event. Hall of Fame Awards for 2012 are: Dr. Albert L. Pumilia Amici Italian Adult Group and Amici Italian Youth Group 40569 fall 2012_29056GRIAA_PapFall07 9/4/12 8:05 AM Page 2 Pappagallo ’12 Pappagallo ’12 2 continued on next page 40569 fall 2012_29056GRIAA_PapFall07 9/4/12 8:05 AM Page 3 Pappagallo ’12 Pappagallo ’12 Italian Hall of Fame Awardees for 2012 Dr. Albert L. Pumilia father into dentistry. Dr. Pumilia continues to teach at the Dental Careers Foundations where he has trained more than 300 dental assistants. He recently published an e-book “Your Travel Companion: A Chapbook of Short Stories”, where he depicts several historical incidences in the Rockford Italian Community. Dr. Albert L. Pumilia, a retired Rockford dentist, will also be inducted into the Hall of Fame. Over the years he has and continues to significantly impact the Italian-American community. Dr. Pumilia is a longtime Festa Italiana volunteer, and active in parish activities at St. Anthony of Padua Church. He has positively impacted the community by play- ing integral roles in the formation of the local Head Start Program and in the establishment of Crusader Dental Clinic. -

Gourmet Tours in Valtènesi with the Strada Dei Vini E Dei Sapori Del Garda
Gourmet Tours in Valtènesi with the Strada dei Vini e dei Sapori del Garda Gourmet Tours in Valtènesi with the Strada dei Vini e Sapori del Garda www.gardasee.de/stradadeiviniedeisaporidelgarda www.stradadeivini.it www.gardaexpo.com Notes Information regarding to the tours NEW: Integration into Google Maps Do you have a Google account? Then you can integrate the gourmet tours to your smartphone with the Google Maps App and make them available offline. Simply click on the following link from a computer: https://drive.google.com/open?id=1kNHI3ipc6KPp3s8D0hsDsqgE-yI&usp=sharing If you are not signed in to Google, sign in by clicking on "Login". Then add our „gourmet tour Valtènesi“ to your favorites clicking on the star . Now you can open the app on your smartphone and click in the menu on „your places“ . You can see the Strada dei Vini routes in „Maps“. In the side panel you can see or hide individual tours and by clicking on the letters on the card you can see the individual nodes. By clicking on the dots on the map you can see the names of the wineries, restaurants and specialties shops along the route that may be interesting for a stop on the road. Select and click the relevant maps section on Menu , offline maps , add and download. Abb.1: Calvagese della Riviera Tour 1 Valtènesi hills Abb.2: Tour 1 A discovery tour which leads us through the hilly and lush countryside of the south-western Garda Lake. From Bedizzole to Calvagese the tour is accompanied by colourful fields, small woods and vineyards which invite to take a rest tasting some glasses and just enjoying the splendid buildings of the wine cellars. -

Holiday Luxuryservices Guide
HOLIDAYGARDA HOLIDAYGARDA Fabulous villas | Luxury Service Holiday LuxuryServices Guide www.holiday-garda.com HOLIDAYGARDA Special Services and Activities Guide At Holiday Garda we know that a truly fabulous holiday means more than just an amazing place to stay. It means great food, fun activities, and extraordinary and unique experiences. It means creating memories to take home and cherish for years to come. In this guide we have collected a wide array of vetted and recommended services and activities to make the most of your holiday and the local area. Organising and booking these services for you is all part of our concierge service, included in the price of the villa. (we do not mark up the prices) You can order the services directly with the service provider (numbers at the back of the book), or you can ask Novella Battani (co-owner of Holiday Garda and the Guest Services Director) to organise it all for you. Novella Battani Holiday Garda Co-Owner and Guest Services Director +39 331 383 0506. Table of Contents Chef & Food Services Food, the best reason to have a holiday in Italy! Enjoy the best of Italian dining with our private chef services including catered meals, delivered meals, and Apericena pages 4-5 Breakfast Delivery Let us bring you breakfast, fresh and local, delivered to your door every morning. We can also deliver Nespresso capsules for the Nespresso machine pages 6-7 Wine Tastings and Tours Experience the best of Garda wines with tours of local wineries, tastings with buffet with the local vintner and even wine tasting courses in the villa with an expert sommelier pages 8-9 Massage & Beauty Treat yourself, you're are worth it! Our experts provide luxurious spa treatments in the comfort of your villa: personalised massage, mani / pedi, waxing and more! page 10-11 Private Boat Tours The best way to truly experience Lake Garda. -
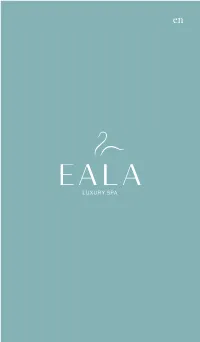
Spa Menu Click Here
en “…in the continuous and uninterrupted search of BALANCE it is sometimes necessary to LISTEN to oneself… in order to create the basis for a complete act of FREEDOM and LOVE versus body, soul and mind.” Veronika Miotto Spa Manager BALANCE LISTEN FREEDOM LOVE Welcome to EALA Luxury SPA, 1’500 qm of Wellness thought exclusively for you. Our professional staff will take care of all your needs with a unique range of treatments to awaken your most sensitive yourself with a holistic, sensorial and natural approach using raw material from our territory. We commit ourselves and we dedicate you our passion and know-how in terms of Wellness and well-being. Looking forward to your visit at EALA Luxury Spa we thank you very much for your trust. Your EALA LUXURY SPA TEAM Index 2. TERRITORIAL EXPERIENCES 7. VITALIS DR. JOSEPH 12. MASSAGES 16. AESTHETICS 18. SCRUB 20. BODY WRAP 22. HAIRSTYLIST 24. EALA BOX TREATMENT 26. MISCELLANEOUS EALA LUXURY SPA 1 Countless are the places which leave you an emotion. But it is exactly here, at Lake Garda where Veronika Miotto Spa Manager of EALA Luxury Spa draws inspiration to create 8 exclusive sensorial experiences. TERRITORIAL EXPERIENCES An alternative journey in middle of the scents of Lake Garda, will allow you to get to the most famous locations our territory has to offer. N W E LAKE GARDA S RIVA DEL GARDA LIMONE SUL GARDA MONTE BALDO SALÒ ISOLA DEL GARDA BARDOLINO SIRMIONE COLLINE MORENICHE DEL GARDA 2 Countless are the places which leave you an emotion. But it is exactly here, at Lake Garda where Veronika Miotto Spa Manager of EALA Luxury Spa draws inspiration to create 8 exclusive sensorial experiences. -

Gargnano - Gardone Riviera - Toscolano Maderno - Isola Del Garda Meandro International Chamber Music Festival 2015 - XX ª Edizione
Riva del Garda - Limone sul Garda - Tremosine sul Garda - Tignale Gargnano - Gardone Riviera - Toscolano Maderno - Isola del Garda Meandro International Chamber Music Festival 2015 - XX ª Edizione Associazione Cultura In Musica Limes Grafico consuntivo lavori Strada Gargnano - Riva, Meandro Da: Giancarlo Cavallini, La strada nella roccia, Fondazione Negri, 2005, pag. 89 XXª EDIZIONE International Chamber Music Festival Alla scoperta degli antichi luoghi del Garda Riva d/Garda - Limone s/Garda - Tremosine s/Garda Tignale - Gargnano - Toscolano Maderno Gardone Riviera - Isola del Garda 2015 Con il contributo del Con il contributo del Con il contributo del Con il contributo del COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI TIGNALE TREMOSINE SUL GARDA GARGNANO TOSCOLANO MADERNO GARDONE RIVIERA Calendario concerti 2015 XXª Edizione International Chamber Music Festival B - Domenica 5 Aprile Limone s/G, Chiesa San Benedetto ore 21.00 (pag. 28) CONCERTO DI PASQUA B - Domenica 24 Maggio Navazzo di Gargnano, Hotel Tre Punte/Villa Sostaga ore 17.00 (pag. 71) ENSEMBLE CONCELLI B - Venerdì 29 Maggio Pieve di Tremosine s/G, Chiesa San Giovanni ore 21.00 (pag. 38) KARIM SAID, Pianoforte B - Giovedi 11 Giugno Limone s/G, Chiesa San Benedetto ore 21.00 (pag. 29) CHOPIN PIANO QUINTET (Polonia) B - Domenica 14 Giugno Tignale, Santuario di Montecastello ore 20.30 (pag. 49) ENSEMBLE NOVALIS Paola Leggeri, Soprano; Aurhelia Varak, Mezzo-Soprano; Elisa La Marca, Tiorba C - Domenica 5 Luglio Isola del Garda ore 18.30 (pag. 95) RECITAL Frieder Berthold, Violoncello; Daniela Manusardi, Pianoforte B - Sabato 11 Luglio Limone s/G, Chiesa San Benedetto ore 21.00 (pag.