Seminario Internazionale, Torino Maggio 2008
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
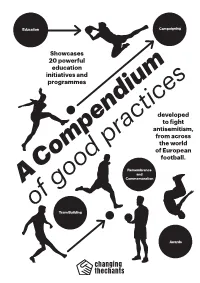
A Compendium of Good Practices
1 Education Campaigning Showcases 20 powerful education initiatives and programmes developed to fight antisemitism, from across the world of European football. CompendiumRemembrance and A Commemoration of good practices Team Building Awards 2 What are you reading ? This Compendium of good practices showcases 20 power- ful education initiatives and programmes, developed to fight antisemitism, from across the world of European football. The Compendium is not the definitive list of all noteworthy initiatives, nor is it an evaluation of a selection of programmes which are considered to be the best which exist; its aim is, rather, to highlight some of the existing practices - from workshops to commemoration plaques and remembrance trips to online campaigns – in the hope they might spark interest and motivate clubs, associations, fan groups and other stakeholders within or associated with the football community to develop their own practices. The initiatives were selected as a result of research conducted by a group of eight researchers and experts from across Europe who were all part of the Changing the Chants project. They conducted desk research and interviewed stake- holders connected to these initiatives. As a result, for every initiative the Compendium provides project background and context and an overview of what took place. Due to the limited scope of this Compendium, it has not been possible to analyse all these good practices in great depth and, as such, readers of this Compendium are invited and encouraged to seek out further information where further detail has not been provided. Categorization The practices have been categorised against five overarching themes: Campaigning (1), Education (2), Remembrance and com- memoration (3), Network building (4) and Awards (5). -

Sustainability Report 2012
Sustainability Report 2012 On the cover: Umberto Boccioni (Reggio Calabria 1882 - Verona 1916) Officine a Porta Romana, (Workshops at Porta Romana), 1910 oil on canvas, 75 x 145 cm Intesa Sanpaolo Collection Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Milan BOARDS, MANAGEMENT, AUDITORS SUPERVISORY BOARD MANAGEMENT BOARD Chairman Giovanni Bazoli Chairman Andrea Beltratti Senior Deputy Chairman Marcello Sala Deputy Chairmen Mario Bertolissi Pietro Garibaldi Deputy Chairman Giovanni Costa Managing Director Members Luigi Arturo Bianchi and Chief Executive Officer Enrico Tommaso Cucchiani Gianfranco Carbonato Rosalba Casiraghi Members Aureliano Benedetti Franco Dalla Sega Paolo Campaioli Jean-Paul Fitoussi Elio Catania Guido Ghisolfi Roberto Firpo Giulio Stefano Lubatti Emilio Ottolenghi Marco Mangiagalli Gianni Marchesini GENERAL MANAGERS Enrico Tommaso Cucchiani Fabio Pasquini Giuseppe Castagna Eugenio Pavarani Carlo Messina Gaetano Miccichè Gianluca Ponzellini Gian Guido Sacchi Morsiani MANAGER RESPONSIBLE FOR Marco Spadacini PREPARING THE COMPANY’S Livio Torio FINANCIAL REPORTS Ernesto Riva Riccardo Varaldo INDEPENDENT AUDITORS KPMG S.p.A. LEGEND Link to Sustainability V Report 2012 Link to Website Link to topics of interest also to other stakeholders MPLOYEES CUSTOMERS E SHAREHOLDERS SUPPLIERS ENVIRONMENT COMMUNITY Key ï ï Back Key alt + ï ï CONTENTS Letter to the stakeholders 6 V Sustainability report 24 V Introduction and Methodology 8 V Stakeholder map 25 V Customers 26 V Identity and governance 10 V Employees 36 V Mission and values 11 V Shareholders 48 V Strategies 12 V Suppliers 50 V The profile of the Intesa Sanpaolo Group 13 V Environment 52 V Governance 14 V Community 64 V CSR management model 16 V Global Compact 18 V Improvement objectives 74 V Stakeholder Engagement 19 V Indicators 76 V Materiality analysis 20 V GRI Content Index 99 V Our achievements in 2012 21 V KPMG assurance statement 111 V Economic report 22 V Contacts 112 V LETTER TO THE STAKEHOLDERS The past five years have been severely hit by an unprecedented crisis. -

Professional Lighting for the Performing Arts Portfolio Showbook (Abstract) Light Illuminates; but It Does a Lot More Than This
professional lighting for the performing arts Portfolio Showbook (abstract) Light illuminates; but it does a lot more than this. Light is like a building material; it models shapes, it transforms space without moving it, it allows the space to be designed and it defines functions without changing the architectural structure. Light is a means of communication; the intensity, the colour, the shades, the transparencies, the movements, the effects and the reflections. It directs attention to objects, to people and to their movements. Skilful use of light can highlight and enhance and a scenography and enrich the expressive dialogue, in architecture, on stage, in TV and Cinema studios. The following pages highlight a selection of Spotlight installations from around the world. Thank you to the many lighting designers, theatre consultants, architects, distributors, and installers who have chosen Spotlight as a partner for these and many other lighting projects. Since 1969 Spotlight has been committed to quality and innovation. We are all so very proud that our technology has proven to be a valuable asset in realizing your creative vision. [email protected] www.spotlight.it [email protected] www.spotlight.it Jardin des Tuileries Museum, Paris (France) Rembrandt Museum, Amsterdam (Netherlands) Hyperactive South Korean artist, entrepreneur and environmentalist Ahae collected for the exhibition “Through my window” a selection The house where Rembrandt lived between 1639 and 1658 of his photographs, which range from 10 meters long to a more is nowadays a museum: Museum het Rembrandthuis or the modest size and reveal various perspectives, taken over a period of Rembrandt House Museum. -

COMMUNITY SUPPORT 103-2 Society
201-1; 203-1; COMMUNITY SUPPORT 103-2 Society Community support COMPANY POLICIES The Group plays an active role in the areas in which it operates. The Code of Ethics draws attention to the requirements and needs of the community: this commitment consists of various activities which tangibly contribute to achieving sustainable development goals at a global level, such as the promotion RIVROLGDULW\LQLWLDWLYHVZLWKSURMHFWVVHWXSWKURXJKSDUWQHUVKLSVGRQDWLRQVWKHVSRQVRUVKLSRILPSRUWDQW cultural and social initiatives, and the protection and promotion of the historical, artistic and cultural KHULWDJHRIERWK,WDO\DQGWKH*URXSVRWKDWLWFDQEHHQMR\HGE\WKHSXEOLFDVZHOO With the 2018-2021 Business Plan, the Group intends to become an increasingly important exemplary PRGHOIRUVRFLHW\GHYHORSLQJNH\SURMHFWVVXFKDV ,QWHVD6DQSDRORIRUGLVDGYDQWDJHGSHRSOHZKLFKHQWDLOVWKHH[WHQVLRQRIWKH³&LERH5LSDURSHUOH SHUVRQHLQGLI¿FROWj´ )RRGDQG6KHOWHUIRUGLVDGYDQWDJHGSHRSOH LQLWLDWLYHWRJXDUDQWHHPHDOV a day (3.6 million a year), 6,000 beds a month (72,000 a year), 3,000 medicines and 3,000 clothing items a month (36,000 drugs and 36,000 items of clothing a year) to people in need; Intesa Sanpaolo for culture, with the creation of a specialist unit for the promotion and proactive ma- nagement of artistic, cultural and historical heritage to champion art and culture in Italy and abroad. 3URMHFWVDQGDFWLYLWLHVDUHSURPRWHGE\WKH*URXSLQRUGHUWRUHVSRQGHIIHFWLYHO\WRWKHPRVWLPSRUWDQW QHHGVRIFRPPXQLWLHVWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHREMHFWLYHVRIWKHPDMRULQWHUQDWLRQDODQGQDWLRQDOSXEOLF and private institutions that -

Dipartimento Di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” 2018 04 Il Centro di Ricerca Coordinato in Information Society Law (ISLC) The Information Society Law Research Center (ISLC) 08 Le linee di ricerca del Centro Research lines of the Center 12 L’attività congressuale nel 2018 Conferences in 2018 16 L’osservatorio Internazionale sul Cyberbullismo e il Memoriale della Shoah Information Society Law Center International Cyberbullying Observatory and Shoah Memorial Direttore responsabile Editor in chief Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” Giovanni Ziccardi 20 Le pubblicazioni Publications Hanno collaborato In collaboration with Barbara G. Bello 24 I contratti di ricerca, le convenzioni con privati, Pierluigi Perri i progetti europei e i rapporti internazionali Alessandra Salluce Research contracts, agreements with private associations, Andrea Scirpa Samanta Stanco European projects and International relations Gabriele Suffia Adriano Zambon Il Comitato di Indirizzo del Centro, i legami con l’Ateneo, 28 Progetto grafico con il Dipartimento “Beccaria” e con le Cattedre Art director e la didattica di Informatica Giuridica Cristina Menotti The Center’s Steering Committee, the links with the University of Milan, Stampa with the Department “Cesare Beccaria”, with the University Chairs, Printing and with the teaching of Legal Informatics Tipografia Verderio CHI SIAMO TECNOLOGIA E TUTELA DEI DIRITTI UMANI protezione dei dati INTELLIGENZA ARTIFICIALE odio politico e propaganda online Il Centro di Ricerca Coordinato numerosi: tecnologia e tutela dei diritti umani, protezione dei dati, intelligenza artificiale, odio DIRITTO ALL’OBLIO in Information Society Law (ISLC) politico e propaganda online, diritto all’oblio, negazionismo in rete negazionismo in rete, cyberbullismo, discriminazioni, CYBERBULLISMO sorveglianza di massa, terrorismo e radicalizzazione, discriminazioni Il 26 luglio 2017 il Magnifico Rettore diritto, e tra il diritto e le più nuove tecnologie. -

Jahrbuch 2015
Bundesministerium für Inneres, Andreas Kranebitter (Hg): FORSCHUNG | DOKUMENTATION | INFORMATION Justiz, Polizei und das KZ Mauthausen Jahrbuch 2015 der KZ-Gedenkstätte Mauthausen | Mauthausen Memorial Forschung – Dokumentation – Information ISBN: 978-3-7003-1952-8 JAHRBUCH MAUTHAUSEN Erscheinungsdatum: 02.05.2016 KZ- GEDENKSTÄTTE MAUTHAUSEN | MAUTHAUSEN MEMORIAL JAHRBUCH 2015 2015 Mit den nationalsozialistischen Konzentrationslagern werden meist SS und Gestapo in Ver- Justiz, Polizei und bindung gebracht. Andere Institutionen wie Justiz oder Kriminalpolizei assoziiert man in der Öffentlichkeit weitaus seltener mit ihnen. In der NS-Forschung werden seit einiger Zeit das KZ Mauthausen verstärkt Konflikte und Kooperationen ins Blickfeld gerückt, die zwischen Instanzen wie Justiz und Polizei im NS-Staat bestanden haben. Im „Forschungsteil“ des vorliegenden Jahr- buchs werden deshalb die vielfältigen Verbindungen zwischen Judikative und Exekutive im Hinblick auf die teils sehr rege Kooperation der beiden Einrichtungen, auf Maßnahmen wie die „Sicherungsverwahrung“ von StraftäterInnen oder kriminalpolizeiliche Ermittlungen in Bezug zur Geschichte des KZ Mauthausen gesetzt. Der „Dokumentationsteil“ des Jahrbuchs ist einem der umfangreichsten Projekte der KZ-Ge- denkstätte Mauthausen der letzten Jahre gewidmet – dem Gedenkbuch für die Toten des KZ Mauthausen und seiner Außenlager. Mehrere Artikel erläutern Entstehungsgeschichte und Hintergründe des Gedenkbuchs; zudem werden ausgewählte Biografien von Verstorbenen als integraler Bestandteil des -

Memorie Fragili Da Conservare: Testimonianze Dell'olocausto E Della Resistenza in Italia
POLITECNICO DI TORINO Repository ISTITUZIONALE Memorie fragili da conservare: testimonianze dell'Olocausto e della Resistenza in Italia Original Memorie fragili da conservare: testimonianze dell'Olocausto e della Resistenza in Italia / Giacomini, MARIA VITTORIA. - (2012). Availability: This version is available at: 11583/2501639 since: Publisher: Politecnico di Torino Published DOI:10.6092/polito/porto/2501639 Terms of use: openAccess This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository Publisher copyright (Article begins on next page) 11 October 2021 POLITECNICO DI TORINO SCUOLA DI DOTTORATO Dottorato di Ricerca in Beni Culturali Ciclo XXIII Tesi di Dottorato Memorie fragili da conservare: testimonianze dell’Olocausto e della Resistenza in Italia Coordinatore: Prof.ssa Costanza Roggero Tutors: Prof.ssa Carla Bartolozzi, Prof. Guido Montanari Candidata: Maria Vittoria Giacomini a.a. 2011-12 POLITECNICO DI TORINO SCUOLA DI DOTTORATO Dottorato di Ricerca in Beni Culturali Ciclo XXIII Tesi di Dottorato Memorie fragili da conservare: testimonianze dell’Olocausto e della Resistenza in Italia Coordinatore: Prof.ssa Costanza Roggero Tutors: Prof.ssa Carla Bartolozzi, Prof. Guido Montanari Candidata: Maria Vittoria Giacomini a.a. 2011-12 DIPARTIMENTO CASA-CITTÀ Castello del Valentino - Viale Mattioli 39 - 10125 Torino Tel. (39) 011.5646453 Fax (39) 011.5646450 E-mail [email protected] A nonno Carlo Boccassi INDICE: Introduzione p. i I: Le coordinate e i temi della ricerca 1 Per le memorie del Novecento p. 3 1.1 Memoria e architettura p. 3 1.2 Documenti fragili p. 10 2 La memoria della Deportazione p. 22 2.1 Testimonianze materiali p. -

Memoriale Della Shoah Di Milano
Fondazione Memoriale della Shoah Guides Che cos’è il Memoriale Per consentire anche ad altri di vivere questa esperienza, La Fondazione Memoriale della Shoah nasce nel 2007 suggerisci la visita a tutti sui social network e con una con l’obiettivo di realizzare a Milano un “laboratorio della recensione su TripAdvisor memoria”. Il progetto defi nitivo, fi rmato Morpurgo de MEMORIALE Curtis Architetti Associati, viene presentato nel 2008 in occasione dell’accordo siglato tra Ferrovie dello Stato Questa pubblicazione è stata resa possibile grazie al contributo di DELLA SHOAH e la Fondazione Memoriale della Shoah. La posa della prima pietra del Memoriale ha luogo il 26 gennaio 2010 e il 27 gennaio 2013 ne viene inaugurato il “cuore”: atrio DI MILANO d’ingresso, Muro dell’Indifferenza, rampa di accesso e L’Associazione senza scopo di lucro Milano Loves You Luogo di Rifl essione, quattro vagoni originali restaurati a nasce nel 2012 su iniziativa degli editori di “Where® Milan”, cura del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani – sezione di con lo scopo di far conoscere e promuovere nel mondo Il Memoriale della Shoah di Milano sorge in un’area della Milano, targhe che ricordano i convogli delle deportazioni, le eccellenze in ambito turistico, culturale e commerciale Stazione Centrale cui si aveva accesso diretto da via Ferrante scala circolare di collegamento col piano interrato, dove del territorio di Milano. Aporti (oggi piazza Edmond J. Safra), situata al di sotto dei binari è stato realizzato l’auditorium e completato il sistema del www.milanolovesyou.com ferroviari ordinari e originariamente adibita al carico e scarico foyer e dei servizi per il pubblico. -

IL DOVERE DELLA PAROLA La Shoah Nelle Testimonianze Di Liliana Segre E Di Goti Herskovitz Bauer MARINA RICCUCCI – LAURA RICOTTI
IL DOVERE DELLA PAROLA La Shoah nelle testimonianze di Liliana Segre e di Goti Herskovitz Bauer MARINA RICCUCCI – LAURA RICOTTI È il 1944 quando Goti Bauer e Liliana Segre vengono deportate ad Auschwitz: hanno rispettivamente 19 e 13 anni. Sopravvivono: i loro cari, insieme a milioni di altri esseri umani, in Lager trovano la morte. Quando le due donne si incontreranno, molti anni dopo il ritorno dall’inferno dei Lager, sarà Goti a spingere Liliana a parlare, a farsi testimone. Per entrambe la parola diviene un dovere da rendere alla verità e alla giustizia. Contro ogni negazionismo, contro ogni tentativo di relativizzare e minimizzare, contro ogni banalizzazione. Il racconto di Goti e di Liliana occupa le pagi- ne di questo libro: le parole di Goti conducono a tante vite e a tante storie altrui; quelle di Liliana dentro l’universo del Lager sulla scorta dell’Inferno dantesco. Insieme, fanno la voce sola che svela l’orrore indicibile e abbatte il muro dell’indifferenza. Marina Riccucci insegna Letteratura Italiana presso l’Università di Pisa. Ha pub- blicato volumi su autori e opere del Quattrocento e contributi sul Settecento e sul Novecento. Ha lavorato presso il Consorzio ICoN (Italian Culture on the Net) e da anni si occupa anche di Scrittura Professionale. Attualmente dirige e coordina il progetto Voci dall’Inferno il cui scopo è quello di creare un database digitale delle testimonianze non letterarie dei sopravvissuti ai Lager nazisti e di censire la presen- za, in quelle testimonianze, del lessico dantesco. È membro del CISE di Pisa (Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici). -
Anne Frank: Scuole
ubtkhnc ,hsuvhv vkvev iutyc DA 74 ANNI L’INFORMAZIONE EBRAICA IN ITALIA www.mosaico-cem.it MAGAZINE Marzo/2019 n.03 BollettinocDELLA COMUNITÀB EBRAICA DI MILANO Manipolazioni di un simbolo Mistificata e banalizzata. Trasformata in una icona pop, buona per tutte le stagioni, dal pacifismo, alla new age, dal negazionismo alla politica, allo sport. Sfruttata da razzisti e antisemiti. Un simbolo pret-a-porter. La sua immagine tutto sembra essere meno quella di una ragazzina vera, morta in un lager nazista. Ecco un’inchiesta-denuncia Anne Frank: contro l’uso strumentale di un’icona della Shoah Anno 74° • n. 3 • Marzo 2019 • Adar I - Adar II 5779 • Poste italiane Spa • Spedizione in abbonamento • D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1, DCB com.1, allegati Milano - Contiene 353/2003 (conv. • D.L. • Spedizione in abbonamento Spa italiane II 5779 • Poste I - Adar 2019 • Adar 74° • n. 3 Marzo Anno @MosaicoCEM ATTUALITÀ/ISRAELE CULTURA/MEMORIA E FUTURO COMUNITÀ Elezioni: Netanyahu contro tutti. Didattica, formazione, mostre, impegno nelle Dopo 10 anni in Comunità, un bilancio. Un voto considerato decisivo, il 9 aprile scuole. L’Associazione Figli della Shoah fa il punto Intervista al Segretario, Alfonso Sassun Bollettino n.3 cB Marzo/2019 aro lettore, cara lettrice, 04 pochi di noi conoscono il nome IL FUTURO di Rona Ramon, morta all’età di 54 anni un paio di mesi fa, mo- Cglie e madre coraggio di Israele. Ed è curio- so che la prima impresa aerospaziale israeliana e lo sbarco sulla Luna della navicella Bereshit, previsto per l’11 aprile, quasi coincida con la scomparsa di questa figura femminile. -

Shoah Memorial of Milan
Fondazione Memoriale This publication has been made possible thanks to the contribution of della Shoah Guides What the Memorial is Fondazione Memoriale della Shoah was founded in 2007 with the objective of creating a “workshop of memory” in Milan. The final plans, by Morpurgo de Curtis Architetti The nonprofit organization Milano Loves You was founded SHOAH Associati, were presented in 2008 on the occasion of in 2012 by the publishers of “Where® Milan” with the the agreement signed between the Ferrovie dello Stato purpose of publicizing and promoting on the international MEMORIAL (Italian State Railways) and the Fondazione Memoriale level the excellence of the Milan area in tourism, culture della Shoah. The first stone was laid on 26 January 2010 and commerce. and the “heart” of the Memorial was inaugurated on 27 OF MILAN January 2013: entrance hall, Wall of Indifference, access www.milanolovesyou.com ramp, Place of Reflection, four original railcars restored by the Milan section of the Italian Railway Engineers, stone The Memorial to the Shoah of Milan has been created in a plaques recording the dates and destinations of the hidden part of the Central Station, beneath the main track level, deportation trains, and the spiral stairway to the sublevel originally designed for loading and unloading the mail with where the auditorium and public facilities are located. “Where® Milan” is an integrated communication tool for direct access from Via Ferrante Aporti. Between 1943 and 1945, Work is still in progress on the library, the permanent reaching international visitors in Milan. far from prying eyes, this was where hundreds of deportees – installations, the support facilities and the north entrance. -

“Qualità, Una Garanzia”
SHABBAT BAMIDBAR 22 MAGGIO 2020 MILANO 19.46 21.54 | FIRENZE 20.23 21.32 | ROMA 20.12 21.21 | VENEZIA 20.24 21.33 5780 אייר | n. 5 - maggio 2020 Pagine Ebraiche – mensile di attualità e cultura dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane - Anno 12 | Redazione: Lungotevere Sanzio 9 – Roma 00153 – [email protected] – www.paginebraiche.it | Direttore responsabile: Guido Vitale Reg. Tribunale di Roma – numero 218/2009 – ISSN 2037-1543 | Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale D.L.353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46) Art.1 Comma 1, DCB MILANO | Distribuzione: Pieroni distribuzione - v.le Vittorio Veneto, 28 - 20124 Milano - Tel. +39 02 632461 euro 3,00 www.moked.it La fase due delle sinagoghe Si avvicina la riapertura: sfide e speranze dei rabbini italiani pagg. 2-3 DOSSIER Il ritorno dei giornalisti Il mondo si è svegliato nel pieno di una crisi devastante senza precedenti, oggi sanitaria, domani sociale ed economica, con una certa voglia di capirci qualcosa. Chi si beava delle panzane disseminate ad arte dai professionisti dell’inganno e della distorsione, “mipiace” venduti e comprati, ha cominciato a rendersi conto che è forse meglio affidarsi a professionisti affidabili, che certo possono sbagliare, che certo potrebbero spesso essere migliori, ma che almeno in quello che fanno ci mettono la faccia e rispondono in prima persona delle loro azioni. / pagg. 15-21 pagg. Il futuro dell’informazione per il direttore del Corriere 6-7 “Qualità, una garanzia” Premier a turno OPINIONI CULTURA / ARTE / SPETTACOLO pag. A CONFRONTO 28-33 ------------------------------------ PAGG. 23-25 --------------------------------- PREGIUDIZI Enzo Campelli PROMESSE Michael Ascoli MEMORIA Silvia Guetta LA CULTURA RIPARTE Diciotto mesi ciascuno per guidare Israele.