Andrea Castagnetti Guelfi Ed Estensi Nei Secoli XI E XII
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
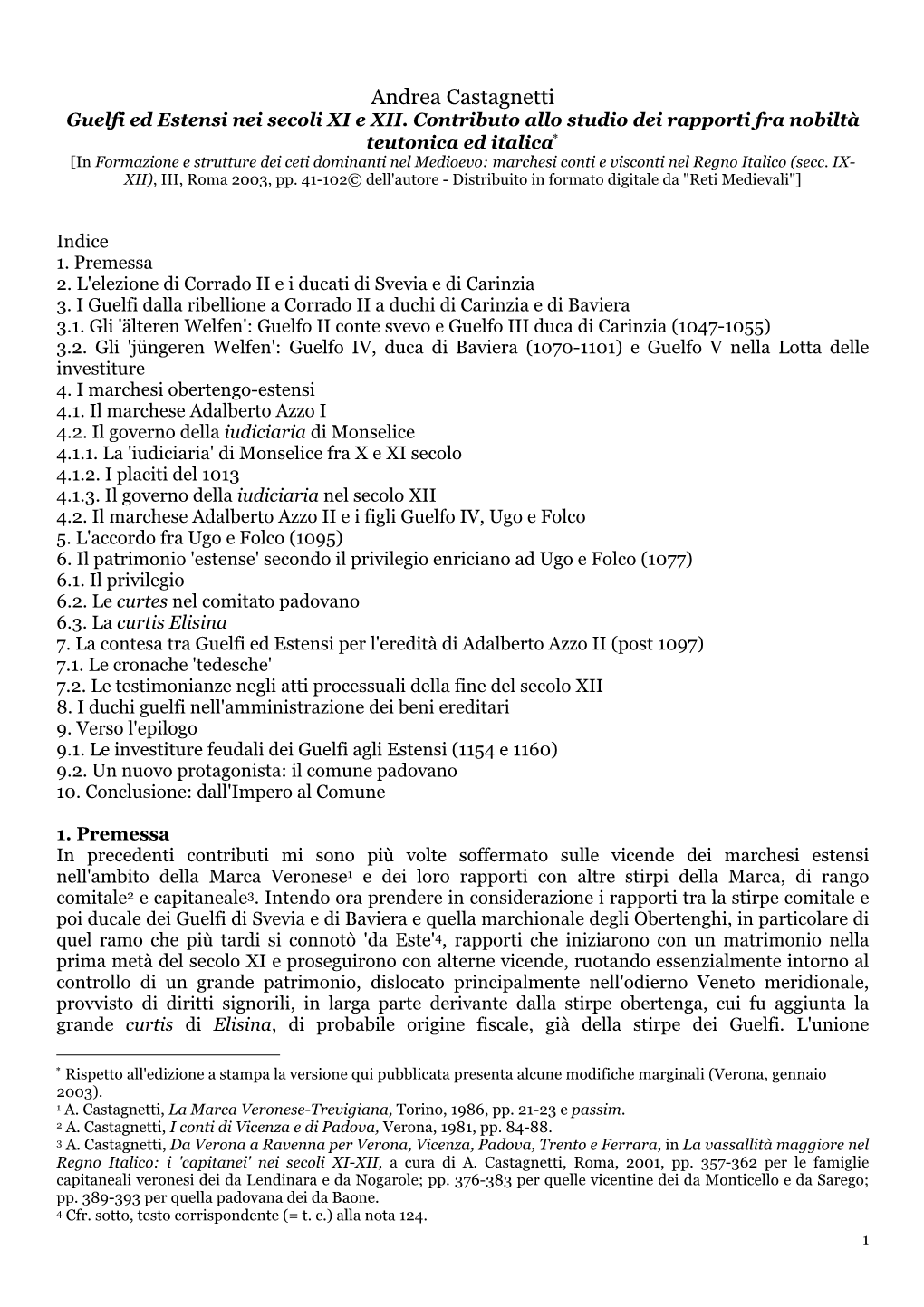
Load more
Recommended publications
-

Università Degli Studi Di Milano Corso Di Dottorato
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO CORSO DI DOTTORATO in STORIA, CULTURE E TEORIE DELLA SOCIETÀ E DELLE ISTITUZIONI XXXI CICLO DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI LE SIGNORIE DI OBERTO PELAVICINO (1249-1266) M-STO/01 MADDALENA MOGLIA matricola: R11270 TUTOR: Chiar.mo Prof. Paolo GRILLO COORDINATORE DEL DOTTORATO: Chiar. ma Prof.ssa Daniela SARESELLA A.A. 2017-2018 ! SOMMARIO INTRODUZIONE ....................................................................................................................................4 1. La signoria cittadina nel dibattito storiografico .......................................................................4 2. Le signorie di Oberto Pelavicino: panorama documentario e fonti .................................. 12 CAPITOLO I I FONDAMENTI DEL POTERE ........................................................................................................... 18 1.1 Geografia del potere marchionale: i Pelavicini tra Impero e città ................................... 18 1.2 La carriera imperiale................................................................................................................ 32 CAPITOLO II UN DOMINIO MULTIFORME: TEMPI E SPAZI DELL’EGEMONIA DI OBERTO PELAVICINO..... 48 2.1 Verso la signoria: gli eventi .................................................................................................... 48 2.2 La pace e l’Impero: Cremona, Piacenza, Pavia, Vercelli (e Parma) ................................. 55 2.3 Prassi di governo: i podestà .................................................................................................. -

NOBILTÀ E CHIESE NEL MEDIOEVO E Altri Saggi
NOBILTÀ E CHIESE NEL MEDIOEVO e altri saggi Scritti in onore di GERD G. TELLENBACH a cura di C. VIOLANTE ]OUVENCE MARIO NOBILI FORMARSI E DEFINIRSI DEI NOMI DI FAMIGLIA NELLE STIRPI MARCHIONALI DELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE: IL CASO DEGLI OBERTENGHI Il collettivo Obertenghi viene comunemente usato nella letteratura storio- grafica italiana per designare i dicendenti di Oberto I - marchese della marca cosiddetta della «Liguria orientale» e conte del Sacro Palazzo con Berengario II ed Ottone I, attestato come vivente fra il 945 ed il 972 -, considerato come capostipite, fino alla VII generazione (primo quarto del secolo XII) l. È opportuno subito notare che sfogliare i documenti del periodo alla ricerca del termine è fatica vana. Iltermine infatti è una creazione erudita dei genealogi- sti del secolo XIX 2. Probabilmente esso fu esemplato - in conformità e ad imitazione di collettivi designanti stirpi regie e nobiliari notissime (ad esempio, Merovingi, Carolingi ecc.) - sull'aggettivo obertingus: aggettivo ilcui uso è atte- stato nella documentazione del secolo XI per indicare luoghi o beni o complessi di beni della famiglia ubicati in Toscana (contee di Pisa, Lucca, Volterra e Arez- zo), o anche, nella espressione Terra abertinga, l'intero complesso dei beni posse- duti dalla famiglia nella regione 3. Non fu dunque in uso - o almeno la documentazione giunta fino a noi non ne ha lasciato traccia - un termine, trasmissibile di generazione in genera- zione, che valesse per tutti gli appartenenti alla fascia genealogica che siamo soli- ti definire come Obertenghi: vale a dire un cognome. 1 Cfr. la tavola genealogica. In essa compaiono tutti gli obertenghi maschi che al- lo stato attuale delle ricerche sono stati identificati. -

Anthia Cultura, Territorio, Ospitalità
AVoce dell’associazionen t Amici hdi Peagna Anno i 2014 -a numero 17 POSTE ITALIANE – Spedizione in abbonamento postale – 70% aut. DCB/Savona nr. 588 anno 2006 Cinque nuove opere per Nicolò Traverso Un paesaggio da tutelare: il ruolo della Soprintendenza Il mare di Giuseppe Conte Giono e Biamonti: autori a confronto Thomas Grünfeld a Villa Croce Poteri feudali tra Liguria e pianura 2 Anthia Cultura, territorio, ospitalità A nVoce dell’associazione t Amicih di Peagna i Anno 2013a - numero 15 Esattamente dodici mesi fa, raccontavo in questo spazio di un viaggio attraverso la Liguria meno conosciuta. Avevo avuto l’incaricato di pre- numero 17 - agosto 2014 parare una guida sui borghi della Liguria per un pubblico piemontese e lombardo: da lì la straordinaria opportunità di percorrere strade e Registrazione del Tribunale di Savona n. 565/06 paesi con il tempo necessario e la curiosità del cronista. In quel breve Direttore responsabile resoconto, parlavo di bellezza e di persone: la bellezza che nella nostra Andrea Carpi regione ha trovato terra fertile per crescere e germogliare e le persone, quasi sempre privati, volontari, associazioni, che tra mille difficoltà Caporedattore quella bellezza provano a difenderla e valorizzarla. Gian Carlo Ascoli A distanza di un anno, lo stesso editore mi ha offerto una nuova sfi- da: raccontare i borghi della Costa Azzurra. Nel mio bagaglio, devo Redazione ammetterlo, ho messo molte buone intenzioni, il tempo necessario, Mauro Bico, Ferdinanda Fantini, la curiosità del cronista, ma anche un paio di remore preventive. Im- Graziella Frasca Gallo, maginavo di andare a sbattere contro gli stessi problemi trovati in Massimiliano Guido, Stefano Roascio Liguria (difficoltà a trovare informazioni, uffici, chiese e musei siste- maticamente chiusi, scarso livello di professionalità degli operatori del Hanno collaborato a questo numero settore), acuiti questa volta dalla presunta arroganza dei cugini e dalla Monica Bruzzone, Simona Caleca, loro presunta indisponibilità ad aiutare chi il francese lo parla poco. -

Roberto Ricci La Lunigiana Nel Secolo Di Ferro (900-999)
Roberto Ricci La Lunigiana nel secolo di ferro (900-999). Istituzioni e società in un territorio di confine [A stampa in “Studi Medievali”, s. III, I (2002), pp. 287 -336 © dell’autore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”] La percezione della Lunigiana storica medioevale è incentrata sulla focalizzazione di un sistema giunzione-confine. A questo paradigma si può aggiungere, almeno per l’XI secolo, ma forse con prodromi nel secolo precedente, il concetto di area polarizzatrice1 . Altro paradigma in cui si condensa l’immagine storiografica di questa terra di confine in quell’epoca che va dall’alto medioevo al medioevo centrale è quella dell’egemonia vescovile2 . Gli studi locali, intesi sia nel senso di saggistica prodotta da studiosi del luogo ma pure da alcuni maestri della storiografia italiana quali il Volpe, fino a giungere a Mario Nobili3 , hanno potuto mettere a fuoco molti aspetti delle età lunigianesi che vanno dall’XI secolo al XIII. Per questi periodi non mancano le fonti documentarie. Per il X secolo esistono solo passaggi episodici in molta parte della saggistica classica lunigianese. Indubbiamente la povertà della documentazione e la sua frammentarietà non rendono possibile una limpida messa a punto. Ciò nonostante, sia attraverso la rimeditazione e concatenazione delle fonti in nostro possesso, sia con l’ausilio ponderato dei metodi indiziari, è possibile delineare almeno in parte i caratteri del tessuto politico sociale della regione nel secolo di ferro, un sistema territoriale che per il X secolo trova esemplificazione in alcune tematiche storiografiche interdipendenti: i presupposti dell’egemonia vescovile e dell’incastellamento, il passaggio della Lunigiana dalla marca di Tuscia alla nuova manca obertenga della Liguria Orientale. -

Los Aujòls D'elisabèt De Brandoin
Joan Francés Blanc LOS AUJÒLS D'ELISABÈT DE BRANDOIN LES ANCÊTRES D'ÉLISABETH DE BRANDOUIN ELISABÈT DE BRANDOIN’S ANCESTRY 11. NÒTAS (6: SOSAS 5 136 952 A 20 780 049) 2012 Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 11 Joan Francés Blanc, Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin. 11 – Nòtas (6: Sosas 5 136 952 a 20 780 049), <http://blanc.mfoudi.online.fr>, 2012 ©2012 Joan Francés Blanc / Jean-François Blanc 2 Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 11 ENSENHADOR DEL METEIS AUTOR........................................................................................................................................4 NÒTAS (6: SOSAS 5 136 952 A 20 780 049).....................................................................................................5 3 Los aujòls d'Elisabèt de Brandoin - 11 DEL METEIS AUTOR Jean Lafitte, Jean-François Blanc (eds.), Louis Alibert, Lexique français-occitan des gallicismes corrigés, online 1992 Joan Francés Blanc, Lexic occitan-chèc, Courbevoie, 1992 Joan Francés Blanc, Pichon lexic sorabe bas-occitan/Maly delnjoserbsko-okcitanski slownik, Courbevoie, 1993 Joan Francés Blanc,"Nueit de junh" in De quan panèren un peishic de pais, Editorial Pagès, Lleida, 1994, ISBN 84-7935-231-0. Joan Francés Blanc, Lexic anglés-occitan, En linha, 1996 Joan Francés Blanc, Lexic basco-occitan, En linha, 1996 Joan Francés Blanc,Pichon lexic d'informatica anglés-occitan (little english-occitan lexic of computer science), En linha, 1996 Joan Francés Blanc,"Onzadas" in Paraules dera tèrra, Editorial Pagès, Lleida, 1997, . ISBN 84-7935- 415-1 Joan Francés Blanc,"Extrach de cronica negra e blava dels jorns de Praga" dins Escrituras descobertistas : presentacion d'una jove literatura occitana, Lo Gai Saber, Tolosa, 1996 Joan Francés Blanc,Heisei, Princi Negre, Pau, 1999, ISBN 2-905007-42-7 Joan Francés Blanc,Enciclopedia dels drapèls, En linha, 2002 Joan Francés Blanc,Enciclopèdia dels drapèls, Segonda edicion, En linha, 2008 Joan Francés Blanc,(Collaboracion) Lexique thématique français-occitan. -

The History of the Estes Family Traces Back Through Several Generations in Italy
Coat of Arms Coat of Arms for Coat of Arms Nicholas De Estes, early Italy Nicolas III d'Este born in 1495 in Ringwould, Kent (1383 - 1441 County, England. The History of the Estes family traces back through several generations in Italy. Below are basic details of those generations with some links for more info. GAELTRAMN DUX Birth estimated between 520 and 580 married to Onbekend Dux AMALGAR de DIJON Birth circa 585 Dijon, Côte-d'Or, Burgundy, France Death circa 643 (50-66)Dijon, Côte-d'Or, Burgundy, France Husband of Aquilina LENDIFIUS(Alsatia) of ALSATIA Birth circa 610 Lorraine, France Death 680 (66-74)Brittany, France Husband of Hultrude of Burgundy ETICHO VON ELSASS, DUC d'ALSACE Birth circa 645 Alsace, Bas-Rhin, France (Frankrijk) Death February 20, 689 (40-48)Alsace, Lorraine, France Husband of Berswinde d'Austrasie ADALBERT Birth circa 675 Alsace, France Death December 5, 741 (62-70)Alsace, France COUNT RICHBALD de LUCCA Birth 690 Lucca, Toscana, Italy Death January 15, 761 (71)Bayern, Germany . BONIFACIO I a FRANK d' LUCCA Birth 725 Lucca, Toscana, Italy Death 785 (60)Bayern, Germany BONIFACIO II LIGURA d' LUCCA Birth 775 Bayern, Germany Death October 5, 823 (48)Lucca, Tuscany, Italy BONIFACIO III MARGRAVE DE TUSCANY Birth 810 Lucca, Toscana, Italy Death circa 865 (51-59)Florence, Firenze, Toscana, Italy Husband of Bertha d' Lucca MARQUIS ADABERT d'ESTE, I Birth 820 Lucca, Toscana, Italy Death May 27, 886 (66)Luccq, Lucca, Toscana, Italy Husband of Rothilde Rohaut of Spoleto born 837, Spoleto, Umbria, Italy She died around 27 May 884 Her parents were: Father Guido I Duke of Spoleto (~815-858) Mother Angiltrude DUKE ADALBERTO d'ESTE, II Birth 860 Lucca, Tuscany, Italy Death August 17, 915 (55)Lucca, Tuscany, Italy Husband of Berthe P d'Este ADALBERTO III MARGRAVE of ESTE Birth 894 Este, Padua, Veneto, Italy Death 955 Padova, Padua, Veneto, Italy "Este, one of the oldest of the former reigning houses of Italy. -

Licciana E I Suoi Sette Castelli Fotografie Di A
MEMORIE di LUNIGIANA di ADRIANA G. HOLLETT Licciana e i suoi sette castelli Fotografie di A. G. Hollett© 2 a mio marito Reginald che condivide l’amore per la mia terra. 3 Mappa planimetrica della Lunigiana ricordata da Almagia’: ”Monumenta Italiae Cartographica”, pag. 60 Acquerello su carta - Piante antiche dei confini del 1643 - rappresentante i vari feudi lunigianesi. 4 Cenni sulla storia della Lunigiana Per riassumere brevemente la storia delle origini della Lunigiana sara’ necessario, a causa della carente documentazione, ricorrere all’opera di Eugenio Branchi “ Storia della Lunigiana feudale”, unica fonte autorevole assieme a quella di Gioachino Volpe; ebbe a osservare quest’ultimo che, “ per la storia della Lunigiana, avanti il XII secolo, e’ poco meno che tenebre e tenuissima luce di alba lontana.” Concordando con loro, possiamo partire da Oberto, conte di Luni, di probabile origine longobarda e unico superstite della famiglia dei Marchesi di Toscana. Luni divenne colonia romana nel 177 a.C., prospero’ col nome di Provincia Maritima Italorum, subi’ dapprima l’invasione longobarda e in seguito, unita a tutta la Lunigiana venne aggregata al ducato longobardo di Lucca. Con i Franchi entro’ nella marca carolingia, Oberto ne fu il primo conte e, in seguito, quando i Vescovi contrastarono il dominio obertengo ottenendo da Federico I di veder sanciti i loro diritti su tutto il territorio, divenne sede vescovile. Il Volpe, concordemente ad altri storici e genealogisti, individua in Oberto (945), di origine longobarda, il primo ad essere nominato conte di Luni. L’essere conte di Luni aveva una certa rilevanza poiche’il paese, collocato tra Liguria e Toscana, testimoniava attraverso i resti dell’anfiteatro romano e quelli di antichi insediamenti paleolitici il suo notevole passato. -

Fosdinovo E Il Suo Castello a Mio Marito Reginald Che Condivide L’Amore Per La Mia Terra
MEMORIE di LUNIGIANA di ADRIANA G. HOLLETT Fosdinovo e il suo castello a mio marito Reginald che condivide l’amore per la mia terra. 2 ...Se novella vera di Lunigiana o di parte vicina sai, dillo a me che gia' grande la' era. Dante Purgatorio canto VIII 3 4 Cenni sulla storia della Lunigiana Per riassumere brevemente la storia delle origini della Lunigiana sara’ necessario, a causa della carente documentazione, ricorrere all’opera di Eugenio Branchi “ Storia della Lunigiana feudale”, unica fonte autorevole assieme a quella di Gioachino Volpe; ebbe a osservare quest’ultimo che, “ per la storia della Lunigiana, avanti il XII secolo, e’ poco meno che tenebre e tenuissima luce di alba lontana.” Concordando con loro, possiamo partire da Oberto, conte di Luni, di probabile origine longobarda e unico superstite della famiglia dei Marchesi di Toscana. Luni divenne colonia romana nel 177 a.C., prospero’ col nome di Provincia Maritima Italorum, subi’ dapprima l’invasione longobarda e in seguito, unita a tutta la Lunigiana venne aggregata al ducato longobardo di Lucca. Con i Franchi entro’ nella marca carolingia, Oberto ne fu il primo conte e, in seguito, quando i Vescovi contrastarono il dominio obertengo ottenendo da Federico I di veder sanciti i loro diritti su tutto il territorio, divenne sede vescovile. Il Volpe, concordemente ad altri storici e genealogisti, individua in Oberto (945), di origine longobarda, il primo ad essere nominato conte di Luni. L’essere conte di Luni aveva una certa rilevanza poiche’il paese, collocato tra Liguria e Toscana, testimoniava attraverso i resti dell’anfiteatro romano e quelli di antichi insediamenti paleolitici il suo notevole passato. -

Faye Final 27 April
MIRACULA, SAINTS’ CULTS AND SOCIO-POLITICAL LANDSCAPES BOBBIO, CONQUES AND POST-CAROLINGIAN SOCIETY Faye Taylor, MA Thesis submitted for examination to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy JULY 2012 ii ABSTRACT Despite the centrality of monastic sources to debates about social and political transformation in post-Carolingian Europe, few studies have approached the political and economic status of monasteries and their saints’ cults in this context, to which this thesis offers a comparative approach. Hagiography provides an interesting point of analysis with respect to the proposition of mutation féodale, and more importantly to that of the mutation documentaire and its relation to monastic ‘reform’, which Part I discusses. Parts II and III consider Bobbio and Conques, and their miracula (dedicated to San Colombano and Sainte Foy) within their respective socio-political environments, since the best of the recent scholarship concerning the millennial period has emphasized the specificity of regional experience. At Bobbio the closeness of the king physically and some continuity in royal practices between the tenth and eleventh centuries shaped monastic experience. It directed and sometimes restricted monastic discourse, which maintained an older tradition of general service to the kingdom, although innovations in relic usage helped monastic negotiations with the sovereign. At Conques, the waning of royal control created space for literary and cultic advances that served to bolster the monastery’s position within local power structures. In this landscape older forms of public authority were purposefully minimized and hierarchy and landownership were negotiated between aristocrats, including Sainte Foy at the head of Conques. -
Rinaldo Merlone La Discendenza Aleramica “Qui Dicitur De Seciago*” (Secoli XI-XII)
Rinaldo Merlone La discendenza aleramica “qui dicitur de Seciago*” (secoli XI-XII). I marchesi di Sezzadio, signiferi del regno italico** [A stampa in Il tempo di san Guido Vescovo e Signore di Acqui (Atti del convegno di studi, Acqui Terme, 9-10 settembre 1995), a cura di G. Sergi - G. Carità, Acqui 2003 (Storia locale religiosa ed ecclesiale. Collana di studi e ricerche a cura dell’Archivio Vescovile della Diocesi di Acqui), pp. 103-133 © dell’autore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”] Introduzione Nella seconda metà del X secolo il marchese Aleramo (933-967) aveva dato un notevole impulso al radicamento territoriale della sua stirpe, che operava in quell’area subalpina, denominata solo successivamente e in maniera non ben definita marca aleramica. Il termine “marca”, riferito al territorio aleramico, compare infatti la prima volta in un diploma del 1014 e poi ancora in un documento del 1162 ma limitatamente alla marchia Saonensis1 e quindi nel significato di comitato. Nel 1156 anche Guglielmo il Vecchio, marchese di Monferrato, aveva definito Aleramo “primaevo antecessore nostro in marchia”, ma qui il termine marchia era oramai riferito al marchesato2. Dalla linea oddoniana discesero i marchesi di Monferrato e di Occimiano, mentre da quella anselmiana i marchesi del Vasto, del Bosco, di Albisola, di Ponzone e quelli detti de Seciago, ossia di Sezzadio. Nel corso del secolo XI3 queste stirpi individuarono varie aree di radicamento adeguate ai nuovi sviluppi signorili. Tra i rami si verificò dunque una lenta trasformazione signorile, con insediamenti in territori diversi e talvolta lontani tra loro, ma senza eccessivi frazionamenti patrimoniali, tant’è che ancora nel 1035 si parlava della “terra de eredes quondam Anselmi et Oddoni que fuerunt marchiones”4. -
(Bagnaja Sul Frigido) - Vescovati Della Toscana (Massa Ducale) - Zecche Diverse (Massa Di Carrara) - Cave Di Marmi
Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana (E. Repetti) http://193.205.4.99/repetti/ Massa Ducale, Massa di Carrara, Massa Lunense, Massa del Marchese, Massa Cybea - (Bagnaja sul Frigido) - Vescovati della Toscana (Massa Ducale) - Zecche Diverse (Massa di Carrara) - Cave di Marmi ID: 2652 N. scheda: 30450 Volume: 3; 5; 6S; 6A Pagina: 115 - 138; 705, 838 - 839; 140 - 145; 78 - 79 ______________________________________Riferimenti: 53410, 56490 Toponimo IGM: Massa Comune: MASSA Provincia: MS Quadrante IGM: 096-3 Coordinate (long., lat.) Gauss Boaga: 1591783, 4876309 WGS 1984: 10.14628, 44.03577 ______________________________________ UTM (32N): 591846, 4876484 Denominazione: Massa Ducale, Massa di Carrara, Massa Lunense, Massa del Marchese, Massa Cybea - (Bagnaja sul Frigido) - Vescovati della Toscana (Massa Ducale) - Zecche Diverse (Massa di Carrara) - Cave di Marmi Popolo: S. Pietro in S. Francesco a Massa Ducale Piviere: S. Pietro in S. Francesco a Massa Ducale Comunità: Massa Ducale Giurisdizione: Massa Ducale Diocesi: Massa Ducale Compartimento: x Stato: Ducato di Modena ______________________________________ MASSA DUCALE, o MASSA DI CARRARA, già Massa Lunense, Massa del Marchese e Massa Cyeba, nella vallecola del Frigido. - Città che fu per più secoli residenza dei suoi principi, ora di un governatore ducale, sede di un nuovo vescovado, capoluogo di tribunale di prima e seconda istanza civile e criminale e di comunità, sotto il Duca di Modena. Page 1/44 Dizionario Geografico, Fisico e Storico della Toscana (E. Repetti) http://193.205.4.99/repetti/ Trovasi la città di Massa ducale sull-attuale strada Regia postale di Genova, nel grado 27° 48- di longitudine e 44° 2- 6-- di latitudine circa miglia toscane 2 e 1/2 lungi dal mare, miglia toscane 3 e 1/2 a scirocco di Carrara e circa 6 e 1/2 a maestrale di Pietrasanta; 12 miglia toscane a scirocco levante di Sarzana, 24 a maestrale ponente di Lucca, e 26 miglia toscane a scirocco di Pisa per la via del littorale. -
Scuole DI DOTTORATO — 34 — Dottorato Di Ricerca in Storia Medievale Collana Digitale
SCUOLE DI DOTTORATO — 34 — Dottorato di Ricerca in Storia Medievale Collana Digitale Comitato scientifico Giuliano Pinto, Università degli Studi di Firenze (Coordinatore) Michele Ansani, Università di Pavia Margherita Azzari, Università di Firenze Giulia Barone, Università di Roma “La Sapienza” Anna Benvenuti, Università degli Studi di Firenze Silvia Cantelli, Università degli Studi di Firenze Sandro Carocci, Università di Roma Tor Vergata Giovanni Cherubini, Università degli Studi di Firenze Laura De Angelis, Università degli Studi di Firenze Paolo Delogu, Università di Roma “La Sapienza” Carla Frova, Università di Roma “La Sapienza” Isabella Gagliardi, Università degli Studi di Firenze Antonella Ghignoli, Università degli Studi di Firenze Oretta Muzzi, Università degli Studi di Firenze Paolo Pirillo, Università di Bologna Francesco Salvestrini, Università degli Studi di Firenze Franek Sznura, Università degli Studi di Firenze Andrea Zorzi, Università degli Studi di Firenze Titoli in collana A. Zorzi (a cura di), Storia di un dottorato: Storia Medievale nell’Università di Firenze. Attività, ricerche, pubblicazioni (1983-2003) L. Pubblici, Dal Caucaso al Mar d’Azov. L’impatto dell’invasione mongola in Caucasia fra nomadismo e società sedentaria (1204-1295) Patrizia Meli GabriELE MalaspiNA marcHESE di FosdiNOVO CONdoTTE, poliTica E diplomazia NElla LUNigiaNA DEL RINascimENTO presentazione di Jean-Claude Maire Vigueur FirENZE UNIVErsiTY PREss 2008 Gabriele Malaspina marchese di Fosdinovo : condotte, politica e diplomazia nella Lunigiana del Rinascimento / Patrizia Meli. – Firenze : Firenze University Press, 2008. Scuole di dottorato ; 34) http://digital.casalini.it/9788884538604 ISBN 978-88-8453-859-8 (print) ISBN 978-88-8453-860-4 (online) Per la realizzazione di questo volume si ringrazia il Comune di Fosdinovo (MS).