Milano Anni ‘50 - ‘60 Crocevia Della Cultura
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Milano Di Luigi Granelli Di Maria Chiara Mattesini
1960-1969: la Milano di Luigi Granelli di Maria Chiara Mattesini Introduzione Con questo saggio si è voluto dare conto dell'importante e intensa attività di Luigi Granelli, svolta nella città di Milano, dal '60 al '69, attraverso gli innumerevoli incarichi ricoperti. Un'analisi che certo non ha potuto prescindere da incursioni nella politica nazionale. Questo per ovvi motivi di contestualizzazione ed anche perchè, nel caso di Granelli, sarebbe stato impossibile scindere la vicenda locale da quella nazionale. Milano rappresenta in questo decennio un interessante spazio di sperimentazione politica e culturale: con notevole anticipo vi si elaborano soluzioni adottate, poi, anche dai governi nazionali. Ed è al comune di Milano, infatti, che Granelli riserva in questi anni le maggiori energie. 1) Un autodidatta al Comune di Milano. È lo stesso Luigi Granelli a fornirci alcuni dati salienti della sua biografia e della sua formazione culturale e politica, quando, dovendo compilare un questionario per i dirigenti nazionali, così scriveva di se stesso: alla voce “titolo di studio” si autodefinisce un «autodidatta». E poi, sulle esperienze formative e sui primi incarichi politici a livello locale: «Dopo un'esperienza di lavoro in fabbrica, dirigente di ente pubblico e di società a partecipazione statale. Iscritto al partito dal 1945». Alla domanda: «Ha partecipato alla Resistenza?» rispondeva: «Sì, nei primi mesi della liberazione nel circolo di Azione cattolica di Lovere soprattutto come opera di opinione e di sostegno dei partigiani». Di seguito si legge: «Ho fatto parte dell'Azione cattolica in qualità di dirigente diocesano, dal '45 al '49, dirigente provinciale delle Acli dal '46 al '48, iscritto alla Cisl dal '46 al '49 e dirigente provinciale della Coltivatori diretti dal '46 al '49».1 Dai primi anni degli anni Cinquanta l'impegno di Granelli in politica è stato in continua ascesa con incarichi nel partito e nella compagine ministeriale. -

Archivio Centrale Dello Stato Inventario Del Fondo Ugo La Malfa Sala Studio
Archivio centrale dello Stato Inventario del fondo Ugo La Malfa Sala Studio INVENTARIO DEL FONDO UGO LA MALFA (1910 circa – 1982) a cura di Cristina Farnetti e Francesca Garello Roma 2004-2005 Il fondo Ugo La Malfa è di proprietà della Fondazione Ugo La Malfa, via S.Anna 13 – 00186 Roma www.fondazionelamalfa.org [email protected] Depositato in Archivio centrale dello Stato dal 1981 Il riordino e l’inventariazione è stato finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi II INDICE GENERALE INTRODUZIONE .................................................................................................V INVENTARIO DEL FONDO ............................................................................ XI SERIE I. ATTI E CORRISPONDENZA...............................................................1 SERIE II ATTIVITÀ POLITICA .........................................................................13 SOTTOSERIE 1. APPUNTI RISERVATI 50 SERIE III. CARICHE DI GOVERNO ................................................................59 SOTTOSERIE 1. GOVERNI CON ORDINAMENTO PROVVISORIO (GOVERNO PARRI E I GOVERNO DE GASPERI) 61 SOTTOSERIE 2. MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO (VI GOVERNO DE GASPERI) 63 SOTTOSERIE 3. MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO (VI E VII GOVERNO DE GASPERI) 64 SOTTOSERIE 4. MINISTRO DEL BILANCIO (IV GOVERNO FANFANI) 73 SOTTOSERIE 5. MINISTRO DEL TESORO (IV GOVERNO RUMOR) 83 SOTTOSERIE 6. VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO (IV GOVERNO MORO) 103 SOTTOSERIE 7. FORMAZIONE DEL GOVERNO E VICEPRESIDENTE -

Quando L'amministrazione Comunale Di Milano Produceva Documentari A
Quando l’Amministrazione comunale di Milano produceva documentari a tutto campo Palazzo Marino presenta... di Pierfranco Bianchetti Nei primi anni Cinquanta quando non ci sono i computer, i cellulari, il web e la televisione italiana deve ancora entrare nelle case degli italiani, i mezzi di comunicazioni più popolari sono la radio, la carta stampata e il cinema. Milano è una città in ricostruzione, che studia per diventare metropoli in tempi brevi. Il Comune è guidato prima dal mitico sindaco della Liberazione, Antonio Greppi, cui si deve la rinascita del Teatro alla Scala, della Galleria Vittorio Emanuele, della Biblioteca Ambrosiana e di molti altri edifici storici distrutti da bombardamenti, e poi dal 1951 dall’ottimo Virgilio Ferrari, artefice dell’aeroporto Forlanini e della Metropolitana. Sono anni nei quali le pubbliche relazioni necessarie a diffondere la conoscenza dei problemi che riguardano la cittadinanza, sono affidati allo strumento più tradizionale, ma efficace: il documentario. Nel 1953 a cura dell’Ufficio Stampa di Palazzo Marino, la sede del Comune in piazza Scala, nasce una vera e propria Cineteca Comunale specializzata nella raccolta di film capaci di incuriosire l’opinione pubblica, come ricorda “Il cinema a Milano”, la bella pubblicazione uscita nel marzo 1966 per volere dell’Amministrazione civica realizzata da Walter Alberti e Gianni Comencini della Cineteca Italiana. A Guido Guerrasio per primo è affidato il compito di raccontare alcuni momenti più significativi della “storia milanese”. Il regista gira nel 1953 il pregevole “Il Sindaco di ferro” dedicato a Gaetano Negri, illustre primo cittadino in carica dal 1884 al 1889, padre del moderno piano regolare della città e poi il suggestivo e pittorico “Gente dei navigli”. -

UN SOCIALISTA CRISTIANO | Carlo Tognoli
<http://www.arcipelagomilano.org/wp3 content/plugins/adrotate/adrotate3 out.php? track=MTk4LDAsMCxodHRwOi8vd3d3LmFyY2lwZWxhZ29taWxhbm8ub3JnL2xhLWJ1b25hLWdvdmVybmFuY2U> Mi piace 584 Segui anno VI n° 2 - on line il mercoledì [#gf_1] INSERISCI LA MAIL PER RICEVERE LA NEWSLETTER <http://www.arcipelagomilano.org/wp3 content/plugins/adrotate/adrotate3 GREPPI: UN SOCIALISTA CRISTIANO out.php? track=MTk4LDAsMCxodHRwOi8vd3d3LmFyY2lwZWxhZ29taWxhbm8ub3JnL2xhLWJ1b25hLWdvdmVybmFuY2U> 15#gennaio#2014(2014301315T06:00:49+00:00)]Di#Carlo&Tognoli<http://www.arcipelagomilano.org/archives/author/carlo6tognoli> Mi piace 2 Tweet 0 Share 2 0 Share A#A#A (Send In occasione della presentazione dei volumi dedicati (*) ad Antonio Greppi, primo sindaco di Milano nel dopoguerra, pubblichiamo alcune parti dell’introduzione di this Carlo Tognoli. article to]a In Antonio Greppi il suo socialismo cristiano metteva doppiamente l’uomo al centro delle sue attenzioni e delle sue cure. Mi riferisco al socialismo inteso come friend!) aiuto ai meno abbienti e come emancipazione dei lavoratori per l’affermazione dei loro diritti – come conquista di una società più libera e più giusta attraverso la formazione e l’educazione del popolo alle idee socialiste con la democrazia, senza violenza e senza prevaricazioni – come fiducia nella libertà accompagnata dalla tolleranza verso chi sbaglia. Questi sono i principi che ispirano Antonio Greppi e lo orientano verso l’impegno politico e sociale e anche in quello professionale. <http://www.arcipelagomilano.org/wp-content/uploads/2014/01/02tognoli02FB.gif>Dopo gli studi egli, già con l’animo socialista, si era avvicinato a Filippo Turati, ad Anna Kuliscioff, a Claudio Treves, a Giacomo Matteotti, stimolato anche dagli insegnamenti liceali del professor Ugo Guido Mondolfo che a quei maestri era molto legato. -

L'arte Di Fare Teatro Fra Intuizione E Ragione
GIORGIO STREHLER ..................................................................................................................................................................................................................... L’arte di fare teatro fra intuizione e ragione testi di Alberto Bentoglio, Marco Blaser e Claudio Magris introduzione di Rita Levi Montalcini L’arte di fare teatro fra intuizione e ragione ..................................................................................................................................................................................................................... «Il teatro è l’attiva riflessione dell’uomo su se stesso»: una riflessione questa che un mae- stro, un regista quale Giorgio Strehler ha saputo conciliare al meglio con la sua vita. È riuscito, infatti, a contrapporre la vita alla scena, dove tutte le libertà sono possibili. La sua imponente produzione artistica è la testimonianza di una crescita culturale che vede unito il teatro italiano a quello della scena europea. La sua attività di cinquanta anni lo ha visto impegnato alla direzione del “Piccolo” di Milano da lui fondato nel 1947 con Paolo Grassi. Strehler è riuscito a sviluppare un lavoro teatrale legato al realismo poetico attraverso le opere di grandi autori, quali Shakespeare, Goldoni, Pirandello, Brecht, Bertolazzi, Cechov. Ha percorso non sol- tanto la strada del teatro con l’apporto di regista anche all’opera lirica, ma la sua conoscenza della musica ha fatto eccellere la sua “abilità” nell’aver saputo “svecchia- re” le arretrate tradizioni teatrali creando l’epifania di un metodo teatrale del tutto nuovo, offrendo agli spettatori di ogni estrazione sociale la proiezione di un calei- doscopio fantastico del mondo dell’arte, della poesia e della musica. Parole e musica hanno diretto la vita di A pagina I: Ritratto di Giorgio Giorgio Strehler così come egli stesso ha Strehler nel 1974. diretto la musica e il teatro. A sinistra: Una scena del Faust. -
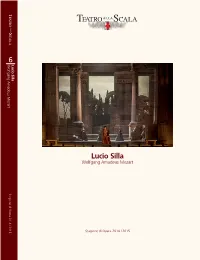
Lucio Silla Wolfgang Amadeus Mozart S T a G I O N E D I O P E R a 2 0 1 4 / 2 0 1
6 W L u o c l i f o g a S n i l g l a A m a d e u s M o z a r t Lucio Silla Wolfgang Amadeus Mozart S t a g i o n e d i O p e r a 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Stagione di Opera 2014 / 2015 Lucio Silla Dramma in musica in tre atti Libretto di Giovanni De Gamerra Musica di Wolfgang Amadeus Mozart Nuova produzione In coproduzione con Mozartwoche Salzburg/Fondazione Mozarteum e Festival di Salisburgo EDIZIONI DEL TEATRO ALLA SCALA TEATRO ALLA SCALA PRIMA RAPPRESENTAZIONE Giovedì 26 febbraio 2015, ore 20 - Turno E REPLICHE febbraio Sabato 28 Ore 20 – Turno D marzo Martedì 3 Ore 20 – ScalAperta Giovedì 12 Ore 20 – Turno B Sabato 14 Ore 20 – Turno A Martedì 17 Ore 20 – Turno C SOMMARIO 4 Lucio Silla . Il libretto 28 Il soggetto Argument – Synopsis – Die Handlung – ࠶ࡽࡍࡌ – Сюжет Cesare Fertonani 40 L’opera in breve Cesare Fertonani 42 La musica Giancarlo Landini 45 Luci del crepuscolo Il Lucio Silla di Mozart per Milano Raffaele Mellace 79 Modernità in veste storica Marc Minkowski parla di Mozart e di Lucio Silla 85 Wolfgang A. Mozart - Lucio Silla Ronny Dietrich 104 Lucio Silla alla Scala Luca Chierici 113 Marc Minkowski 115 Marshall Pynkoski 116 Antoine Fontaine 117 Jeannette Lajeunesse Zingg 118 Hervé Gary 119 Lucio Silla . I personaggi e gli interpreti 121 Wolfgang Amadeus Mozart. Cesare Fertonani Cronologia della vita e delle opere 128 Letture Cesare Fertonani 130 Ascolti Luigi Bellingardi 133 Coro del Teatro alla Scala 134 Orchestra del Teatro alla Scala 135 Corpo di Ballo del Teatro alla Scala 136 Teatro alla Scala Wolfgang Amadeus Mozart . -

Il Piccolo Teatro Di Milano E L'esperienza Del Decentramento
Il PIccolo TeaTro dI MIlano e l’esPerIenza del decenTraMenTo TeaTrale (1968-1972) Il Piccolo, teatro brechtiano, non può parlare di «arte del teatro», ma di «lavoro teatrale» e, quindi, non può indicare una via di democratizzazione che non sia una via che guardi a tutti indistintamente i lavoratori. Paolo Grassi, 13 settembre 1968 a bstract – after Giorgio strehler’s leaving from the Piccolo Teatro di Milano, Paolo Grassi was appointed with the role of main director of the theatre (1968-1972). during these four years – dramatically complex from a social point of view – he launched various initiatives, marking a deep change in the cultural policy of the Piccolo Teatro. The most relevant initiative is considered to be the so-called “decentramento” (delo- calization) bringing the cultural offer of the theatre not only in Milan but also toward the Province of Milan and, further, the whole regione lombardia. The Piccolo Teatro productions were brought out of the theatre’s house and shown in unusual places, thus reaching a huge and completely new kind of audience. This initiative reached extraor- dinary outcomes. Though, when Grassi became managing director of la scala, strehler took his role back at the Piccolo but he broke up with that kind of cultural policy. He preferred to give the role of high quality “teatro d’arte” to the Piccolo Teatro. c ’è un periodo nella storia del Piccolo Teatro di Milano guardato spes- so con diffidenza da coloro che si sono occupati delle vicende artisti- che e organizzative del primo teatro stabile pubblico italiano. si tratta di un arco di tempo, in realtà assai breve, che va dal luglio 1968, quando Giorgio strehler lasciò il Piccolo per trasferirsi a roma, all’aprile 1972, quando Paolo Grassi lasciò il Piccolo per dedicarsi alla scala e strehler vi fece ritorno in veste di direttore unico. -

FESTA DEI NONNI Non Dimenticate Di Guardare Indietro All’Eredità Che Avete Ricevuto Dai Vostri Avi, Dai Vostri Nonni, Dai Vostri Genitori…
124 anni Medaglia della Presidenza della Repubblica Medaglia d’Oro di Benemerenza del Comune di Milano, della Provincia, della Regione Lombardia e della Camera di Commercio di Milano Associazione al servizio degli anziani e delle famiglie indigenti che vivono nella povertà e nella solitudine notiziario sociale trimestrale anno LXVIII 2°-3° trimestre 2017 Milano - via Marcona 34 (ang. via Mameli) - tel. 02.761.133.07 - fax 02.710.928.39 - www.tazzinettabeneficaonlus.it 2 Ottobre “FESTA DEGLI ANGELI… FESTA DEI NONNI Non dimenticate di guardare indietro all’eredità che avete ricevuto dai vostri avi, dai vostri nonni, dai vostri genitori….. (Papa Francesco) Ma essi, i nostri nonni, i nostri padri, purtroppo, sono costretti a fuggire all’estero perché con la tanto attesa e sudata pensione non riescono a sopravvivere nel nostro Paese e i giovani non possono aspirare a quell’eredità! DOMENICA 21 MAGGIO NEL PRESTIGIOSO AUDITORIUM GABER DEL GRATTACIELO PIRELLI DELLA REGIONE LOMBARDIA SI E’ CELEBRATA LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL 13° CONCORSO LETTERARIO REGIONALE DI TAZZINETTA BENEFICA PREMIATA CON BEN 8 MEDAGLIE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 14° CONCORSO LETTERARIO REGIONALE 2017 – 2018 FORZA RAGAZZI... CI SIAMO! SIETE PRONTI PER LA NUOVA SFIDA? VI ASPETTIAMO SEMPRE PIU’ NUMEROSI! (servizio da pag. 21 a 36) SOMMARIO Medaglia d’oro 3 • Vita Sociale di benemerenza del Comune di Milano 7 • Assemblea dei Soci della Provincia della Regione Lombardia Prima guerra ai giovani e della Camera 12 • ... poi guerra ai vecchi di Commercio di Milano 18 • La collana della bontà Medaglia della Presidenza della Repubblica 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 20 • Un nuovo Arcivescovo 13° Concorso Letterario 21 • Presidente Capo Redattore Premiazioni e foto Matteo F. -

La Biblioteca Di Alessandria Di Alfredo Pizzo Greco Alla Biblioteca Sormani
Settore Biblioteche Servizio Biblioteca Centrale CASA MUSEO ALFREDO PIZZO GRECO La Biblioteca di Alessandria di Alfredo Pizzo Greco alla Biblioteca Sormani In occasione delle celebrazioni dei 60 anni nella sede di Palazzo Sormani, la Biblioteca Centrale propone ai lettori un’opera d’arte che rievoca un archetipo bimillenario, custode di uno dei più antichi tesori del sapere umano. La Biblioteca di Alessandria di Alfredo Pizzo Greco si compone di 2063 volumi tra libri combusti e libri rossi, realizzati dal 1922 al 2013, e sarà allestita nella sala Cataloghi al primo piano con progetto dell’Architetto Rosmary Pirotta. L’opera sarà inaugurata domenica 13 marzo alle ore 17.00 e sarà visitabile fino al 4 giugno 2016 . Così l’artista motiva la sua poetica ed esprime l’energia che si effonde dalla sua opera: Corso di Porta Vittoria, 6 – 20122 Milano tel. +39 02 88463372 – fax +39 02 88463616 www.comune.milano.it/biblioteche La Biblioteca di Alessandria di Alfredo Pizzo Greco Biblioteca Sormani 13 marzo-4 giugno 2016 “Qui si consuma il tempo nella polvere degli eventi, ove non si custodisce l’incubo dei percorsi ma bensì l’affascinante culla della bellezza, dell’energia vitale e vitalizzante da liberare nel presente … e ciò, è per chi lo voglia e per chi necessita di scoprire la passione nel “segno e nel “simbolo” dell’umanità tutta!” I libri sono stati realizzati con il fuoco, con il colore acrilico, con la pece bruna, legati dalla juta, sigillati con cera lacca ed esaltati dalle foglie dell’oro. L’opera li espone nella condizione intonsa, come classificati dall’artista, per lasciare inviolata la loro traccia emotiva attraverso la forza cromatica del colore rosso lacca, dell’odore di fumo e del colore opacizzante della polvere che incide il segno del suo tempo. -

Teatro Dal Verme
SIRBeC scheda ARL - MI220-00097 Teatro Dal Verme Milano (MI) Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI220-00097/ Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI220-00097/ SIRBeC scheda ARL - MI220-00097 CODICI Unità operativa: MI220 Numero scheda: 97 Codice scheda: MI220-00097 Visibilità scheda: 3 Utilizzo scheda per diffusione: 03 Tipo scheda: A Livello ricerca: P CODICE UNIVOCO Codice regione: 03 Numero catalogo generale: 00101584 Ente schedatore: S26 Ente competente: S26 Data del sopralluogo: 2011 OGGETTO OGGETTO Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi Definizione tipologica: teatro Denominazione: Teatro Dal Verme Fonte della denominazione: bibliografia Specifica della fonte della denominazione: Bibliografica "Milano nell'arte e nella storia" LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA Stato: Italia Regione: Lombardia Provincia: MI Nome provincia: Milano Codice ISTAT comune: 015146 Pagina 2/11 SIRBeC scheda ARL - MI220-00097 Comune: Milano CAP: 20121 Indirizzo: Via San Giovanni sul Muro Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 3]: Affaccio: secondario Indirizzo: Largo Maria Callas Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 3]: Affaccio: secondario Indirizzo: Foro Buonaparte Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [3 / 3]: Affaccio: secondario Indirizzo: Via Giacomo Puccini CENTRO STORICO Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale ZONA URBANA Denominazione: -

Istituto Storico Toscano Della Resistenza E Dell'età Contemporanea (ISRT)
ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA BARILE, PAOLO 1939 - 2000, La grande maggioranza dei documenti copre l'arco cronologico 1960-2000. Inventario a cura di Marta Bonsanti (2019) Biografia. Nasce a Bologna il 10 settembre 1917. Nel 1939 si laurea in giurisprudenza a Roma con il pro- fessor Salvatore Messina e diviene assistente ordinario per gli anni accademici successivi, che peraltro trascorre in servizio militare essendo stato chiamato alle armi nel 1939. Nel 1941 vince il primo posto del concorso in Magistratura ordinaria e prende servizio nel 1943 presso il Tribunale militare di Trieste e successivamente presso il Tribunale di Firenze e poi quello di Pistoia. Dopo aver aderito nel 1941 al movimento liberal-socialista, nel gruppo romano di Federico Comandini, nel 1943 entra nel Partito d'a- zione e nelle file di questo, in seguito al suo rientro a Firenze dopo l'8 settembre, partecipa attivamente alla Resistenza. Tra i dirigenti del Comitato militare del Comitato toscano di liberazione nazionale, nel novembre è catturato insieme ad Adone Zoli ed altri dalla polizia del famigerato Mario Carità; torturato a Villa Triste e portato in ospedale per una pugnalata alla testa, insieme agli altri prigionieri è reclamato dal comando tedesco e trasferito nel carcere militare della Fortezza da Basso. Nonostante le insistenti richieste di fucilazione avanzate dai fascisti come rappresaglia per l'attentato al tenente colonnello Gobbi, Barile e gli altri membri del Comitato militare sono rilasciati con l'obbligo di presentarsi settimanalmente. A Barile si dà alla macchia e riprende la sua attività nella Resistenza fiorentina a fianco degli azionisti. -

The Original Documents Are Located in Box 16, Folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R
The original documents are located in Box 16, folder “6/3/75 - Rome” of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library. Copyright Notice The copyright law of the United States (Title 17, United States Code) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material. Gerald R. Ford donated to the United States of America his copyrights in all of his unpublished writings in National Archives collections. Works prepared by U.S. Government employees as part of their official duties are in the public domain. The copyrights to materials written by other individuals or organizations are presumed to remain with them. If you think any of the information displayed in the PDF is subject to a valid copyright claim, please contact the Gerald R. Ford Presidential Library. Digitized from Box 16 of the Sheila Weidenfeld Files at the Gerald R. Ford Presidential Library 792 F TO C TATE WA HOC 1233 1 °"'I:::: N ,, I 0 II N ' I . ... ROME 7 480 PA S Ml TE HOUSE l'O, MS • · !? ENFELD E. • lt6~2: AO • E ~4SSIFY 11111~ TA, : ~ IP CFO D, GERALD R~) SJ 1 C I P E 10 NTIA~ VISIT REF& BRU SE 4532 UI INAl.E PAL.ACE U I A PA' ACE, TME FFtCIA~ RESIDENCE OF THE PR!S%D~NT !TA y, T ND 0 1 TH HIGHEST OF THE SEVEN HtL.~S OF ~OME, A CTENT OMA TtM , TH TEMPLES OF QUIRl US AND TME s E E ~oc T 0 ON THIS SITE. I THE CE TER OF THE PR!SENT QU?RINA~ IAZZA OR QUARE A~E ROMAN STATUES OF C~STOR ....