La Scala Tra Il 1972 E Il 1997 Alberto Bentoglio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'arte Di Fare Teatro Fra Intuizione E Ragione
GIORGIO STREHLER ..................................................................................................................................................................................................................... L’arte di fare teatro fra intuizione e ragione testi di Alberto Bentoglio, Marco Blaser e Claudio Magris introduzione di Rita Levi Montalcini L’arte di fare teatro fra intuizione e ragione ..................................................................................................................................................................................................................... «Il teatro è l’attiva riflessione dell’uomo su se stesso»: una riflessione questa che un mae- stro, un regista quale Giorgio Strehler ha saputo conciliare al meglio con la sua vita. È riuscito, infatti, a contrapporre la vita alla scena, dove tutte le libertà sono possibili. La sua imponente produzione artistica è la testimonianza di una crescita culturale che vede unito il teatro italiano a quello della scena europea. La sua attività di cinquanta anni lo ha visto impegnato alla direzione del “Piccolo” di Milano da lui fondato nel 1947 con Paolo Grassi. Strehler è riuscito a sviluppare un lavoro teatrale legato al realismo poetico attraverso le opere di grandi autori, quali Shakespeare, Goldoni, Pirandello, Brecht, Bertolazzi, Cechov. Ha percorso non sol- tanto la strada del teatro con l’apporto di regista anche all’opera lirica, ma la sua conoscenza della musica ha fatto eccellere la sua “abilità” nell’aver saputo “svecchia- re” le arretrate tradizioni teatrali creando l’epifania di un metodo teatrale del tutto nuovo, offrendo agli spettatori di ogni estrazione sociale la proiezione di un calei- doscopio fantastico del mondo dell’arte, della poesia e della musica. Parole e musica hanno diretto la vita di A pagina I: Ritratto di Giorgio Giorgio Strehler così come egli stesso ha Strehler nel 1974. diretto la musica e il teatro. A sinistra: Una scena del Faust. -
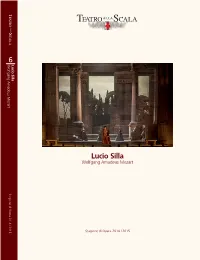
Lucio Silla Wolfgang Amadeus Mozart S T a G I O N E D I O P E R a 2 0 1 4 / 2 0 1
6 W L u o c l i f o g a S n i l g l a A m a d e u s M o z a r t Lucio Silla Wolfgang Amadeus Mozart S t a g i o n e d i O p e r a 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Stagione di Opera 2014 / 2015 Lucio Silla Dramma in musica in tre atti Libretto di Giovanni De Gamerra Musica di Wolfgang Amadeus Mozart Nuova produzione In coproduzione con Mozartwoche Salzburg/Fondazione Mozarteum e Festival di Salisburgo EDIZIONI DEL TEATRO ALLA SCALA TEATRO ALLA SCALA PRIMA RAPPRESENTAZIONE Giovedì 26 febbraio 2015, ore 20 - Turno E REPLICHE febbraio Sabato 28 Ore 20 – Turno D marzo Martedì 3 Ore 20 – ScalAperta Giovedì 12 Ore 20 – Turno B Sabato 14 Ore 20 – Turno A Martedì 17 Ore 20 – Turno C SOMMARIO 4 Lucio Silla . Il libretto 28 Il soggetto Argument – Synopsis – Die Handlung – ࠶ࡽࡍࡌ – Сюжет Cesare Fertonani 40 L’opera in breve Cesare Fertonani 42 La musica Giancarlo Landini 45 Luci del crepuscolo Il Lucio Silla di Mozart per Milano Raffaele Mellace 79 Modernità in veste storica Marc Minkowski parla di Mozart e di Lucio Silla 85 Wolfgang A. Mozart - Lucio Silla Ronny Dietrich 104 Lucio Silla alla Scala Luca Chierici 113 Marc Minkowski 115 Marshall Pynkoski 116 Antoine Fontaine 117 Jeannette Lajeunesse Zingg 118 Hervé Gary 119 Lucio Silla . I personaggi e gli interpreti 121 Wolfgang Amadeus Mozart. Cesare Fertonani Cronologia della vita e delle opere 128 Letture Cesare Fertonani 130 Ascolti Luigi Bellingardi 133 Coro del Teatro alla Scala 134 Orchestra del Teatro alla Scala 135 Corpo di Ballo del Teatro alla Scala 136 Teatro alla Scala Wolfgang Amadeus Mozart . -

Il Piccolo Teatro Di Milano E L'esperienza Del Decentramento
Il PIccolo TeaTro dI MIlano e l’esPerIenza del decenTraMenTo TeaTrale (1968-1972) Il Piccolo, teatro brechtiano, non può parlare di «arte del teatro», ma di «lavoro teatrale» e, quindi, non può indicare una via di democratizzazione che non sia una via che guardi a tutti indistintamente i lavoratori. Paolo Grassi, 13 settembre 1968 a bstract – after Giorgio strehler’s leaving from the Piccolo Teatro di Milano, Paolo Grassi was appointed with the role of main director of the theatre (1968-1972). during these four years – dramatically complex from a social point of view – he launched various initiatives, marking a deep change in the cultural policy of the Piccolo Teatro. The most relevant initiative is considered to be the so-called “decentramento” (delo- calization) bringing the cultural offer of the theatre not only in Milan but also toward the Province of Milan and, further, the whole regione lombardia. The Piccolo Teatro productions were brought out of the theatre’s house and shown in unusual places, thus reaching a huge and completely new kind of audience. This initiative reached extraor- dinary outcomes. Though, when Grassi became managing director of la scala, strehler took his role back at the Piccolo but he broke up with that kind of cultural policy. He preferred to give the role of high quality “teatro d’arte” to the Piccolo Teatro. c ’è un periodo nella storia del Piccolo Teatro di Milano guardato spes- so con diffidenza da coloro che si sono occupati delle vicende artisti- che e organizzative del primo teatro stabile pubblico italiano. si tratta di un arco di tempo, in realtà assai breve, che va dal luglio 1968, quando Giorgio strehler lasciò il Piccolo per trasferirsi a roma, all’aprile 1972, quando Paolo Grassi lasciò il Piccolo per dedicarsi alla scala e strehler vi fece ritorno in veste di direttore unico. -

La Biblioteca Di Alessandria Di Alfredo Pizzo Greco Alla Biblioteca Sormani
Settore Biblioteche Servizio Biblioteca Centrale CASA MUSEO ALFREDO PIZZO GRECO La Biblioteca di Alessandria di Alfredo Pizzo Greco alla Biblioteca Sormani In occasione delle celebrazioni dei 60 anni nella sede di Palazzo Sormani, la Biblioteca Centrale propone ai lettori un’opera d’arte che rievoca un archetipo bimillenario, custode di uno dei più antichi tesori del sapere umano. La Biblioteca di Alessandria di Alfredo Pizzo Greco si compone di 2063 volumi tra libri combusti e libri rossi, realizzati dal 1922 al 2013, e sarà allestita nella sala Cataloghi al primo piano con progetto dell’Architetto Rosmary Pirotta. L’opera sarà inaugurata domenica 13 marzo alle ore 17.00 e sarà visitabile fino al 4 giugno 2016 . Così l’artista motiva la sua poetica ed esprime l’energia che si effonde dalla sua opera: Corso di Porta Vittoria, 6 – 20122 Milano tel. +39 02 88463372 – fax +39 02 88463616 www.comune.milano.it/biblioteche La Biblioteca di Alessandria di Alfredo Pizzo Greco Biblioteca Sormani 13 marzo-4 giugno 2016 “Qui si consuma il tempo nella polvere degli eventi, ove non si custodisce l’incubo dei percorsi ma bensì l’affascinante culla della bellezza, dell’energia vitale e vitalizzante da liberare nel presente … e ciò, è per chi lo voglia e per chi necessita di scoprire la passione nel “segno e nel “simbolo” dell’umanità tutta!” I libri sono stati realizzati con il fuoco, con il colore acrilico, con la pece bruna, legati dalla juta, sigillati con cera lacca ed esaltati dalle foglie dell’oro. L’opera li espone nella condizione intonsa, come classificati dall’artista, per lasciare inviolata la loro traccia emotiva attraverso la forza cromatica del colore rosso lacca, dell’odore di fumo e del colore opacizzante della polvere che incide il segno del suo tempo. -

Teatro Dal Verme
SIRBeC scheda ARL - MI220-00097 Teatro Dal Verme Milano (MI) Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI220-00097/ Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI220-00097/ SIRBeC scheda ARL - MI220-00097 CODICI Unità operativa: MI220 Numero scheda: 97 Codice scheda: MI220-00097 Visibilità scheda: 3 Utilizzo scheda per diffusione: 03 Tipo scheda: A Livello ricerca: P CODICE UNIVOCO Codice regione: 03 Numero catalogo generale: 00101584 Ente schedatore: S26 Ente competente: S26 Data del sopralluogo: 2011 OGGETTO OGGETTO Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi Definizione tipologica: teatro Denominazione: Teatro Dal Verme Fonte della denominazione: bibliografia Specifica della fonte della denominazione: Bibliografica "Milano nell'arte e nella storia" LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA Stato: Italia Regione: Lombardia Provincia: MI Nome provincia: Milano Codice ISTAT comune: 015146 Pagina 2/11 SIRBeC scheda ARL - MI220-00097 Comune: Milano CAP: 20121 Indirizzo: Via San Giovanni sul Muro Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 3]: Affaccio: secondario Indirizzo: Largo Maria Callas Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 3]: Affaccio: secondario Indirizzo: Foro Buonaparte Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [3 / 3]: Affaccio: secondario Indirizzo: Via Giacomo Puccini CENTRO STORICO Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale ZONA URBANA Denominazione: -

È Un Piacere E Un Onore Poter Rappresentare E Presentare Milano Al Mondo
È un piacere e un onore poter rappresentare e presentare Milano al mondo. Milano e la sua storia millenaria; Milano e la sua cultura, le sue eccellenze scientifiche; Milano e la sua vocazione al nuovo, i sui progetti, il suo spirito internazionale. Milano è una città che unisce le sue antiche tradizioni con una sensibilità contemporanea. Il Museo del Novecento che sta nascendo dalla trasformazione del Palazzo dell’Arengario, nel cuore di Milano, rappresenta questo spirito milanese: sarà la sede dei capolavori italiani che sono patrimonio di Milano, di opere d’arte del Futurismo che il mondo ci ammira e che troveranno un luogo magico dove essere esposti e ammirati. Milano fu capitale dell’Impero Romano d’Occidente: le testimonianze di queste antiche radici sono conservate nel Museo Archeologico del Castello Sforzesco e nel Parco Archeologico. Milano è l’antica Mediolanum: un luogo di mezzo, un ponte tra culture, un centro di scambi commerciali, sociali, culturali. Tale è rimasta per sempre: nel Medioevoe poi soprattutto nel Rinascimento,quando Ludovico il Moro chiamò alla corte milaneseLeonardo Da Vinci ed egli fece di Milano il suo laboratorio di idee, producendo capolavori d’arte come il Cenacolo 1 Vinciano e opere di ingegneria idraulica come i Navigli. Milano è una capitale mondiale della cultura. Il Castello Sforzesco è con il Duomo il monumento simbolo di Milano. Vi è custodito un tesoro inestimabile:la Pietà Rondanini, l'ultima opera scolpita da Michelangelo, un capolavoro incompiuto, dove proprio il "non finito" rappresentail culmine dell'espressione drammatica del genio michelangiolesco. Tutto questo si integra con la Milano di oggi, centro culturale internazionale. -

TEATRO LIRICO D'europa L'elisir D'amore (THE ELIXIR of LOVE)By
2013-2014 TEATRO LIRICO D’EUROPA 62nd• SEASON Presents L'Elisir D'Amore (THE ELIXIR OF LOVE) by Gaetano Donizetti Libretto by Felice Romani after Eugene Scribes Libretto for Daniel Auber's LE PHILTRE FRIDAY, JANUARY 24 • 7PM Artistic director/Stage director Giorgio Lalov Musical director/Conductor Krassimir Topolov Choral Conductor Ivan Uzunov Sets/Costumes/Light designs Giorgio Lalov CHARACTERS Artists subject to change without notice NEMORINO Fabián Robles ADINA Stanislava Ivanova BELCORE Dobromir Momekov DR. DULCAMARA Hristo Sarafov GIANETTA Viara Zhelezova GUEST Margaret Yaeger Chorus of peasants, soldiers of Belcore's platoon Time and place: Basque country during the early 19th century There will be a 20 minute intermission after Act I Season Sponsor: Symphony Guild of Daytona Beach Associate Sponsors: Carrabba’s Italian Grill · Mary E. Duckett Hospitality Sponsor: Encore Catering Media Sponsors: AM1230 – AM1490 WSBB • Bright House Networks • Halifax Magazine Our Florida Magazine • Hometown News • Our Florida Magazine • WROD Radio 104.7FM Foundation and Public Support The Daytona Beach Symphony Society’s 2013-2014 Season is sponsored in part by grants from Florida Department of State, Division of Cultural Affairs; County of Volusia; City of Daytona Beach; Daytona Beach Racing and Recreational Facilities District. The photographing, video or sound recording of this concert is prohibited. Pre-Opera Talk – In Peabody Auditorium, 6 pm Tenor Earnest Murphy has led a varied career as a soloist in concerts, solo recital and oratorio performances. As a member of the Abby Singers, and the New York Musica, Murphy toured throughout the world. He received two Grammy Awards, The Abby Singers, and New York Pro Musica. -

Piccolo Teatro Della Città Di Milano / 1952, E. N. Rogers, M
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO Bp.202 /itinerari Piccolo Teatro della Città di Milano / 1952, E. N. Rogers, M. Zanuso / 1978-1997, M. Zanuso, P. Crescini Piccolo Teatro della Città di Milano / 1952, Rogers, Zanuso / 1978-1997, Zanuso, Crescini via Rovello e largo Greppi, Milano collocazione migliore (3), ma il nodo inizia fi gurazione esterna attraverso l’adozione a dipanarsi solo nel 1977, quando il sindaco di coperture a shed orientate in diagonale Il Piccolo Teatro nasce a Milano all’interno del quattrocentesco palazzo Tognoli offre l’ex Teatro Fossati. Valutando sopra i volumi di servizio ubicati a nord nell’immediato dopoguerra, per iniziativa Carmagnola. Sottoposto a un superfi ciale anche la disponibilità dell’area antistante della torre scenica. Sul lato opposto di Paolo Grassi e Giorgio Strehler, sulla restyling decorativo dall’architetto Renzo il Fossati, liberatasi per la completata dell’edifi cio, intorno al perimetro della scommessa di una formula nuova per l’Italia Mongiardino, il teatro è inaugurato nel demolizione dell’Istituto Tecnico sala, si dispiegano i foyer, articolati su che è quella del teatro “stabile”, del teatro maggio del 1947. Nel 1952, Ernesto Rogers Schiapparelli, Zanuso avanza l’ipotesi di tre livelli e gli ingressi, per gli addetti, a come “pubblico servizio”, sovvenzionato e Marco Zanuso “rivestono il gobbo”, realizzare un complesso articolato in due ovest, per il pubblico, a est, preceduti da e perciò sottratto ai condizionamenti come ebbe a commentare Gio Ponti (1), teatri complementari: uno sperimentale, da stretti e stilizzati portici binati a doppia dell’economia di mercato. -

Il Teatro Illustrato (1880-1892) Copyright © 1993 RIPM Consortium Ltd Répertoire International De La Presse Musicale (
Introduction to: Giovanni Mazzucchelli and Marco Capra, Il Teatro illustrato (1880-1892) Copyright © 1993 RIPM Consortium Ltd Répertoire international de la presse musicale (www.ripm.org) R Teatro illustrato A trial copy of R Teatro illustrato was published on 16 December 1880; it was pro duced by the Milanese publisher Edoardo Sonzogno whose offices were located at via Pasquirolo no. 14.1 The first "official" issue was printed in January 1881, with issues following monthly until December 1892. In all, 144 numbers plus the trial copy and a supplement to number 62 (February 1886) were produced.2 Concurrently, from 1882 to 1885, Sonzogno published La Musica popolare, first as a weekly then later as a monthly. In January 1886 La Musica popolare merged with R Teatro illustrato to form R Teatro illustrato e la Musica popolare. R Teatro illustrato appeared at a time when publishers began playing new roles: as intermediary between impresarios and composers; as impresarios themselves; and as commissioners of new operas. Means of disseminating information concerning these new activities were, for operational and creative reasons, indispensable for their success. In 1842 the appearance of Ricordi's Gazzetta musicale di Milano had re inforced· an embryonic tendency of the preceding decade; namely, the reversal of the relationship editor/publisher to the complete advantage of the latter. If in the past a journal wa& identified with the character of its editor, now the Gazzetta musicale was identified with Ricardi, the publisher; and, thus, L 'Italia musicale with Francesco Lucca; the Gazzetta musicale di Firenze, L 'Armonia and· Boccherini with Giovan Gualberto Guidi; and R Teatro illustrato, in the same way, with Edoardo Sonzogno, and not with Amintore Galli who assumed editorial responsibility. -

Il Teatro Lirico Internazionale
IL TEATRO LIRICO INTERNAZIONALE Le fiamme che in una notte dello scorso feb difetto di acustica che venne rilevato in questo braio divorarono il teatro Lirico di Milano susci teatro fino dalla prima sera della sua inaugu tano una vampata di ricordi e di memorie che il razione. vecchio teatro racchiudeva. Perchè esso non va La quale inaugurazione avvenne (un anno dopo considerato solo nel breve periodo della sua ul quella della Scala) la sera del 21 agosto 1779 con tima trasformazione, che data solo da poco più di l'opera « la Fiera di Venezia » del maestro Anto un quarantennio, ma in quello assai più lungo nio Salieri, opera che si ripetè nella stagione al e non meno glorioso in cui si chiamava teatro ternatamente a un corso di recite della compa della Cannobiana. gnia drammatica Merli. Questo nome - come molti sanno - veniva Il nuovo teatro fu subito lodato come uno dei al teatro dal fatto d'essere stato costruito sulla più belli e grandi d'Europa. Un cavalcavia, attra stessa area dove sorgevano le famose scuole di versando la via Rastrelli, ne univa il palco reale alle sale del palazzo dell'arciduca per la qual cosa e per trovarsi attigua a questo palazzo, la Canno biana era considerata teatro di Corte. Ma l'esi stenza in città di un altro nuovo gran teatro co me la Scala doveva necessariamente nuocere a questo suo minor fratello, da quella sopraffatto come gran teatro e d'altronde troppo vasto e lussuoso per essere considerato alla stregua dei teatri minori. Questo difetto d'origine la Canno biana portò poi sempre con sè. -

Central Opera Service Bulletin Volume 27, Number 4
CENTRAL OPERA SERVICE BULLETIN VOLUME 27, NUMBER 4 CONTENTS NEK OPERAS AND PREMIERES 1 NEWS FROM OPERA COMPANIES 18 GOVERNMENT ft NATIONAL ORGANIZATIONS 28 CONFERENCES 30 TAX FACTS 31 NEtf AND RENOVATED THEATERS 32 FORECAST 33 ARCHIVES AND COLLECTIONS 38 ATTENTION COMPOSERS AND LIBRETTISTS 40 MUSIC PUBLISHERS 42 ATTENTION CONDUCTORS 43 EDITIONS AND ADAPTATIONS 44 EOUCATION 45 APPOINTMENTS AND RESIGNATIONS 48 COS INSIDE INFORMATION 53 COS NATIONAL CONFERENCE PROGRAM 54 COS SALUTES... 56 WINNERS 58 CAREER GUIDE SUPPLEMENT 60 BOOKS AND PERIODICALS 68 OPERA HAS LOST... 76 PERFORMANCE LISTING, 1986-87 SEASON CONT. 84 FIRST PERFORMANCE LISTING. 1987-88 SEASON 110 COS NATIONAL CONFERENCE REGISTRATION FORM 125 Sponsored by the Metropolitan Opera National Council !>i>'i'h I it •'••'i1'. • I [! I • ' !lIN., i j f r f, I ;H ,',iK',"! " ', :\\i 1 ." Mi!', ! . ''Iii " ii1 ]• il. ;, [. i .1; inil ' ii\ 1 {''i i I fj i i i11 ,• ; ' ; i ii •> i i«i ;i •: III ,''. •,•!*.', V " ,>{',. ,'| ',|i,\l , I i : I! if-11., I ! '.i ' t*M hlfi •'ir, S'1 , M"-'1'1" ' (.'M " ''! Wl • ' ;,, t Mr '«• I i !> ,n 'I',''!1*! ,1 : I •i . H)-i -Jin ' vt - j'i Hi I !<! :il --iiiAi hi CENTRAL OPERA SERVICE BULLETIN Volume 27, Number 4 Spring/Summer 1987 CONTENTS New Operas and Premieres 1 News from Opera Companies 18 Government & National Organizations 28 Conferences 30 Tax Facts 31 New and Renovated Theaters 32 Forecast 33 Archives and Collections 38 Attention Composers and Librettists 40 Music Publishers 42 Attention Conductors 43 Editions and Adaptations 44 Education 45 Appointments and Resignations 48 COS Inside Information 53 COS National Conference Program 54 COS Salutes.. -

Le Canzoni a Milano Tra Il 1918 E Il 1950
Carlo Albertario Le canzoni a Milano tra il 1918 e il 1950 Quaderni della Antica Credenza di sant’Ambrogio Milano La canzone identifica una composizione breve e rappresenta un genere musicale che affonda le sue origini nella notte dei tempi. Il risvegliarsi dei nazionalismi risorgimentali ha sulla musica popolare l'ansia di riappropriarsi di valori culturali specifici. Si tende ad attribuire il termine canzone anche al repertorio "leggero". Nasce così la canzonetta. Con i primi anni del XXº Secolo le spinte vitali che avevano vivacizzato il teatro dialettale si affievoliscono con la scomparsa di Edoardo Ferravilla (Milano, 1946 - 1916). La canzone popolare sopravvive vivida ed espressiva grazie alla popolazione che ha ben poco a disposizione per divertirsi. Per comprendere la vita dei milanesi nel periodo che andiamo a considerare attraverso le canzoni non tratteremo soltanto quelle in dialetto, ma anche altre canzoni che i milanesi cantavano facendo propri i successi del repertorio nazionale. Anche nei periodi difficili la canzonetta (soprattutto quella con testi dal contenuto talvolta frivolo) è servita a lenire disagi e a far affrontare con il cuore meno pesante le difficoltà quotidiane dei milanesi (e non solo). Quanto esposto nel seguito non è una trattazione esaustiva, ma vengono considerati quei "pezzi" che maggiormente hanno accompagnato la vita dei nostri concittadini di allora. Lasciamo al lettore il piacere di ampliare o integrare questo lavoro. La canzone e il primo dopoguerra Anche se il periodo considerato inizia dalla conclusione della Prima Guerra Mondiale, va ricordata una canzone dialettale "La moglie di Cecco Beppe" che, nata durante la guerra, è diventata popolare anche dopo.