“'O Professore”: Raffaele Cutolo E La Nuova Camorra Organizzata
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ercolano, Naples
University of Bath PHD Civil society and the anti-pizzo movement: the case of Ercolano, Naples Bowkett, Chris Award date: 2017 Awarding institution: University of Bath Link to publication Alternative formats If you require this document in an alternative format, please contact: [email protected] General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 07. Oct. 2021 Civil society and the anti-pizzo movement: the case of Ercolano, Naples Christopher Bowkett A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of Bath Department of Politics, Languages & International Studies September 2017 COPYRIGHT Attention is drawn to the fact that copyright of this thesis/portfolio rests with the author and copyright of any previously published materials included may rest with third parties. A copy of this thesis/portfolio has been supplied on condition that anyone who consults it understands that they must not copy it or use material from it except as permitted by law or with the consent of the author or other copyright owners, as applicable. -

L'immaginario Devoto Tra Mafie E Antimafia
L’immaginario devoto tra mafie e antimafia 1. Riti, culti e santi a cura di Tommaso Caliò e Lucia Ceci viella sanctorum SANCTORUM. SCRITTURE, PRATICHE, IMMAGINI 1 collana diretta da Alessandra Bartolomei Romagnoli, Tommaso Caliò, Luigi Canetti, Umberto Longo, Raimondo Michetti, Francesca Sbardella, Elena Zocca L’immaginario devoto tra mafie e antimafia 1. Riti, culti e santi a cura di Tommaso Caliò e Lucia Ceci viella Copyright © 2017 - Viella s.r.l. Tutti i diritti riservati Prima edizione in pdf: aprile 2017 ISBN 978-88-6728-838-0 pdf In copertina: immagine tratta dalla graphic novel di Igort 5 è il numero perfetto (Coconino Press, 2002) per gentile concessione dell’autore. viella libreria editrice via delle Alpi, 32 I-00198 ROMA tel. 06 84 17 758 fax 06 85 35 39 60 www.viella.it Indice TOMMASO CALIÒ, LUCIA CECI Introduzione 9 PIETRO GRASSO Come può un mafioso dichiararsi cristiano? 13 LUIGI CIOTTI Da don Sturzo a papa Francesco. La Chiesa di fronte alla questione mafiosa 17 MANOELA PATTI Compari di san Giovanni. Matrimoni e battesimi nella mafia dell’agro palermitano negli anni Venti 29 GIANLUCA FULVETTI Sicilia inizio anni Sessanta. I frati di Mazzarino, la mafia, la Chiesa 43 ROSSELLA MERLINO «Papi, cupole e mandarini tardivi». Religiosità e identità nelle parole del boss Michele Greco 61 GIORGIO ADAMO Il rapporto tra gerarchie ecclesiastiche e devozione popolare in Calabria. Un resoconto etnografico e qualche considerazione 83 ROSSANA BARCELLONA, TERESA SARDELLA La festa di Sant’Agata tra devozione popolare, strumentalizzazioni criminali, ambiguità istituzionali e impegno civile (2008-2014) 99 6 L’immaginario devoto tra mafie e antimafia DEBORAH PUCCIO-DEN Di sangue e d’inchiostro. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

Contemporary Art Magazine Issue # Sixteen December | January Twothousandnine Spedizione in A.P
contemporary art magazine issue # sixteen december | january twothousandnine Spedizione in a.p. -70% _ DCB Milano NOVEMBER TO JANUARY, 2009 KAREN KILIMNIK NOVEMBER TO JANUARY, 2009 WadeGUYTON BLURRY CatherineSULLIVAN in collaboration with Sean Griffin, Dylan Skybrook and Kunle Afolayan Triangle of Need VibekeTANDBERG The hamburger turns in my stomach and I throw up on you. RENOIR Liquid hamburger. Then I hit you. After that we are both out of words. January - February 2009 DEBUSSY URS FISCHER GALERIE EVA PRESENHUBER WWW.PRESENHUBER.COM TEL: +41 (0) 43 444 70 50 / FAX: +41 (0) 43 444 70 60 LIMMATSTRASSE 270, P.O.BOX 1517, CH–8031 ZURICH GALLERY HOURS: TUE-FR 12-6, SA 11-5 DOUG AITKEN, EMMANUELLE ANTILLE, MONIKA BAER, MARTIN BOYCE, ANGELA BULLOCH, VALENTIN CARRON, VERNE DAWSON, TRISHA DONNELLY, MARIA EICHHORN, URS FISCHER, PETER FISCHLI/DAVID WEISS, SYLVIE FLEURY, LIAM GILLICK, DOUGLAS GORDON, MARK HANDFORTH, CANDIDA HÖFER, KAREN KILIMNIK, ANDREW LORD, HUGO MARKL, RICHARD PRINCE, GERWALD ROCKENSCHAUB, TIM ROLLINS AND K.O.S., UGO RONDINONE, DIETER ROTH, EVA ROTHSCHILD, JEAN-FRÉDÉRIC SCHNYDER, STEVEN SHEARER, JOSH SMITH, BEAT STREULI, FRANZ WEST, SUE WILLIAMS DOUBLESTANDARDS.NET 1012_MOUSSE_AD_Dec2008.indd 1 28.11.2008 16:55:12 Uhr Galleria Emi Fontana MICHAEL SMITH Viale Bligny 42 20136 Milano Opening 17 January 2009 T. +39 0258322237 18 January - 28 February F. +39 0258306855 [email protected] www.galleriaemifontana.com Photo General Idea, 1981 David Lamelas, The Violent Tapes of 1975, 1975 - courtesy: Galerie Kienzie & GmpH, Berlin L’allarme è generale. Iper e sovraproduzione, scialo e vacche grasse si sono tra- sformati di colpo in inflazione, deflazione e stagflazione. -

Analysis of Organized Crime: Camorra
PREGLEDNI ČLANCI UDK 343.974(450) Prihvaćeno: 12.9.2018. Elvio Ceci, PhD* The Constantinian University, New York ANALYSIS OF ORGANIZED CRIME: CAMORRA Abstract: Organized crime is a topic that deserves special attention, not just in criminal science. In this paper, the author analyzes Italian crime organizations in their origins, features and relationships between them. These organizations have similar patterns that we will show, but the main one is the division between government and governance. After the introductory part, the author gives a review of the genesis of the crime, but also of the main functions of criminal organizations: control of the territory, monopoly of violence, propensity for mediation and offensive capability. The author also described other organizations that act on the Italian soil (Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Napolitan Camora i Apulian Sacra Coroina Unita). The central focus of the paper is on the Napolitan mafia, Camorra, and its most famous representative – Cutolo. In this part of the paper, the author describes this organization from the following aspects: origin of Camorra, Cutulo and the New Organized Camorra, The decline of the New Organized Camorra and Cutolo: the figure of leader. Key words: mafia, governance, government, Camorra, smuggling. INTRODUCTION Referring to the “culturalist trend” in contemporary criminology, for which the “criminal issue” must include what people think about crime, certain analysts study- ing this trend, such as Benigno says, “it cannot be possible face independently to cultural processes which define it”.1 Concerning the birth of criminal organizations, a key break occured in 1876 when the left party won the election and the power of the State went to a new lead- ership. -

Retata Di Giudici E Politici Per Smantellare Il «Teorema Alemi», Poi Ritenuto Valido Da Una Sentenza Della Corte Di Appello
Martedì 8 marzo 1994 il Fatto J'Unitàpaginaj 4!««lwWAIA**iw*™(*ì'^-! ;C>U^Wi'f^V» * ^»^* '&A •> * * * w* <•>-•• CAMORRA E POLITICA. Due magistrati in carcere, altri che si ritrovano la casa perquisita Coinvolti imprenditori e giornalisti. Le confessioni del pentito Galasso «Toghe sporche» in galera per mafia Sono quattro I magistrati finiti dietro le sbarre perché sospettati di aver fatto parte di clan mafiosi o Il magistrato comunque di averli favoriti aggiustando processi o fornendo Informazioni su Inchieste In corso. Un'altra decina sono I magistrati raggiunti da avvisi di garanzia e il cronista (anche II direttore degli affari giudiziari del ministero della giustizia, Adriano Testi, Indagato per falsa testimonianza nell'Inchiesta sull'omicidio Pecorelli). Le toghe sospettate di collusione sulle quali indagano in carriera diverse procure della repubblica sarebbero complessivamente una trentina, sparse per gli uffici DAL NOSTRO INVIATO giudiziari di un pò tutt'ltalla. Detenuti, rispettivamente dal maggio e dal luglio '93, sono II magistrato napoletano Alfonso Lamberti e II suo collega ~ • NAPOLI Armando Cono Lancuba è stato per venti messinese Giuseppe Recupero. Sospesi dalle funzioni anni sostituto procuratore a Napoli. Si è occupato di e dallo stipendio, per decisione del Csm, In attesa casi importanti. Il suo debutto nelle grandi inchieste fu delle conclusioni delle Inchieste penali In corso, l'ex il caso De Martino, quando una banda di balordi rapi presidente della prima sezione della corte di Guido, figlio del professor Francesco. Gli esecutori Cassazione Corrado Carnevale e II procuratore di Vallo materiali del rapimento vennero arrestati e condanna della Lucania Nicola Bocassini. Diversamente ha - ti. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -

Dialecto Y Lengua Regional En Italia. Una Perspectiva Contemporánea
Universidad Pontifica Comillas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Grado en Traducción e Interpretación y Diploma en Comunicación Internacional Trabajo Fin de Grado Dialecto y lengua regional en Italia. Una perspectiva contemporánea. Estudiante: Inés Llavador Bulnes Director: Dr. José Luis Aja Sánchez Madrid, junio 2018 2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 5 1.1 Finalidad y motivos .......................................................................................................................... 5 1.2 Objetivos .......................................................................................................................................... 5 1.3 Metodología ..................................................................................................................................... 6 2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................ 8 2.1 Perspectiva histórica del italiano: el proceso de la unificación lingüística .............................................. 8 2.2 El concepto de variación lingüística ...................................................................................................... 14 2.3 Dialecto, lengua estándar y lengua regional: un punto de confrontación ............................................ 17 2.4 El napolitano. Perspectiva histórica ..................................................................................................... -

Luciano Violante
<pre> PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE indi DEL VICEPRESIDENTE PAOLO CABRAS indice</pre> <pre>Comunicazioni del presidente: Violante Luciano, Presidente 2657, 2658, 2659 2660, 2661, 2665, 2666, 2667 Brutti Massimo 2658, 2666 Buttitta Antonino 2663 Cabras Paolo 2661, 2666 D'Amato Carlo 2666 Frasca Salvatore 2659, 2660, 2661, 2666, 2667 Matteoli Altero 2661 Sorice Vincenzo 2664 Tripodi Girolamo 2664 Discussione della relazione sulla criminalità in Puglia: Violante Luciano, Presidente 2667, 2670, 2673, 2674 2675, 2676, 2677, 2678 Brutti Massimo 2677, 2678 Cafarelli Francesco 2670, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676 D'Amato Carlo 2676 Frasca Salvatore 2677, 2678 Matteoli Altero 2668 Robol Alberto, Relatore 2667, 2668, 2675 Sorice Vincenzo 2672, 2676 Allegati: Documenti prodotti dall'onorevole Francesco Cafarelli 2679 Pag.2656 Pag.2657 La seduta comincia alle19. (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente). Comunicazioni del presidente. PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei dare una informativa riguardante sia le date e l'organizzazione dei nostri lavori, sia il prosieguo della nostra attività in seguito all'audizione del dottor Parisi e del generale Mei. In ordine alle date, avverto che esiste un problema per la missione a Bologna della prossima settima. Il dottor Latini, procuratore della Repubblica di Bologna, dovendosi presentare dinanzi al Consiglio superiore della magistratura il 21 settembre avrebbe preferito partire un giorno prima. Personalmente il dottor Latini non mi ha detto nulla, tanto che il problema è stato sottolineato dal prefetto. Tra l'altro, anche il collega Cabras ha segnalato la sua impossibilità ad assicurare la sua presenza per il 20 settembre. Se i colleghi fossero d'accordo, si potrebbe spostare il sopralluogo in Emilia-Romagna al 27 e 28 settembre, anticipando la visita a Barcellona Pozzo di Gotto al 20 settembre: ciò consentirebbe al dottor Latini di superare le difficoltà incontrate. -

Copia Finale 06.03.2017
2 INDICE PREMESSA ………………………………………………………….…………………………. 9 INTRODUZIONE 1. Inquadramento del fenomeno mafioso ……………………………………....….. 11 1.1. Evoluzione storica. Dalla situazione post-unitaria all'azione del prefetto Mori ………………………………………………………………………. 12 1.2. Dagli anni '30 al secondo dopoguerra …………………….………….….. 13 1.3. Dalla prima alla seconda guerra di mafia ………………….……………. 14 1.4. L'omicidio di Pio La Torre e l'introduzione dell'art. 416-bis c.p. …. 15 1.5. La creazione del 'pool antimafia', il 'maxiprocesso' e gli attentati ai giudici Falcone e Borsellino ……………………………………………… 15 1.6. La decretazione d'emergenza ……………………………………………… 16 2. Rinvio ………………………………………………………………..…………….……….. 18 CAPITOLO 1 LA COLLABORAZIONE DI GIUSTIZIA 1. Inquadramento …………………………………………………...……………………… 21 2. Nascita ed evoluzione del fenomeno collaborativo………………..…….….. 23 3. Disciplina legislativa …………………………………………………………………… 27 3.1. Il d.l. 15 gennaio 1991, n. 8: l'introduzione del programma di protezione …………………………………………………………………………. 29 3.1.1. Il contenuto del programma di protezione …………………… 30 3.2. La prima fattispecie premiale: la circostanza attenuante prevista dall'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 …………………………….. 31 3.3. L'introduzione dell'art. 58-ter o.p. …………………………………………. 34 3.4. La collaborazione di giustizia nel vigore della l. 82/91 e della l. 203/91 ………………………………………………………………………………. 34 3.4.1. Dati statistici …………………………………………………………... 36 3.5. Il dibattito precedente all'emanazione della l. 13 febbraio 2001, n. 45 …………………………………………………………………………………. 38 3.6. Le principali modifiche apportate dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45 39 3 3.6.1. I benefici penitenziari ……………………………………………….. 46 4. Fotografia della situazione attuale ………………………………………………... 48 5. Il contributo della dottrina ……………………………………………………………. 50 5.1. Il dibattito precedente all'emanazione della l. 82/91 e della l. 203/91 …………………………………………………………………………….… 51 5.1.1. -
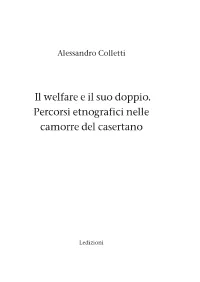
Il Welfare E Il Suo Doppio. Percorsi Etnografici Nelle Camorre Del Casertano
Alessandro Colletti Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Ledizioni © 2016 Ledizioni LediPublishing Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy www.ledizioni.it [email protected] Alessandro Colletti, Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Prima edizione: febbraio 2016 ISBN Cartaceo: 978-88-6705-426-8 Copertina e progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni I ricavi dai diritti d’autore saranno devoluti al Comitato Don Peppe Diana di Casal di Principe Indice Prefazione di Antonio La Spina 5 Introduzione 11 Metodi e fonti 17 Parte Prima. Un’analisi delle forme di egemonia delle mafie: tra controllo e assistenza 27 1. Il controllo territoriale nella storia delle camorre 29 Il riconoscimento istituzionale del potere camorrista 34 Il controllo territoriale nell’area campana 39 2. Forme organizzative e redistributive: la “cassa comune” 49 Le mafie come organizzazioni professionali 50 Il funzionamento della “cassa comune” 53 I capi cambiano, la struttura resta: dal “clan Bardellino-Iovine” al “clan dei casalesi” 63 3. La protezione sociale delle camorre casertane 73 Il clan La Torre 76 Il clan Belforte 82 I clan Schiavone e Bidognetti: alleati, federati, separati 89 Gerarchia e livelli stipendiali: il clan Schiavone 94 Forme di assistenza nei clan del casertano 101 Parte Seconda. Le politiche socio-assistenziali nella provincia di Caserta: un welfare (s)finito 113 1. Analisi delle forme di welfare pubblico: il sistema italiano 115 I territori del welfare: dallo Stato agli enti locali 118 Il livello territoriale dei servizi sociali 123 2. Zona di contatto: servizi alla persona nella provincia casertana 135 La dimensione territoriale dei servizi nella governance regionale 140 Uno sguardo alle pratiche locali di welfare nell’area casertana 143 Il welfare raccontato da chi lo dirige: le interviste ai coordinatori degli Uffici di Piano 148 3. -

Articolo: "L'ingiusta Detenzione E Il Suo Prezzo", Di Mario Iannucci (Pdf)
“L’ingiusta detenzione e il suo prezzo” Dr. Mario Iannucci Psichiatra psicoanalista, Responsabile Progetto Eracle Regione Toscana Consulente Psichiatra nel Carcere di Sollicciano [Propongo volentieri, in questo periodo in cui si torna a parlare della Responsabilità dei Magistrati, il testo dell’intervento che effettuai al Convegno I nuovi danni, che Persona & Danno e altri organizzarono a Pistoia il 13/10/2012] Parlando a un prevalente pubblico di Avvocati e di operatori della Giustizia, si potrebbe facilmente immaginare che mi debba occupare in modo precipuo delle norme che regolano i risarcimenti per “ingiusta detenzione”. Io però non sono avvocato e a dire il vero, dopo trentatre anni di presenza in carcere, comincio ad essere un po’ insofferente per le norme dei vari Codici. Meglio: comincio ad avere una certa motivata diffidenza nei confronti di queste norme che proliferano, si sovrappongono e talora si contraddicono (sì, talora si contraddicono!). Specie nel caso di certe questioni. Vedremo se questo accade anche per la “ingiusta detenzione”. Cercheremo inoltre di capire in che misura la “ingiusta detenzione” abbia a che fare con l’annosa e mai risolta questione della “responsabilità dei magistrati”. Illustrerò tre casi che a me paiono emblematici. Partirò da lontano. Da quel momento che l’immaginario collettivo, ma anche l’interpretazione storica di qualcuno, identificano come uno degli avvenimenti storici simbolici dell’abbattimento del potere oligarchico, del potere delle caste: la Presa della Bastiglia, avvenuta il 13 luglio 1789. Ai fini della questione che mi accingo a trattare, evocherò quell’eroico momento storico attraverso una stampa che Gemma Brandi tiene nello studiolo della nostra casa: la liberazione del Conte di Lorges dalla Bastiglia quel 13 luglio, dopo 32 anni di prigionia.