Dgr 539/2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
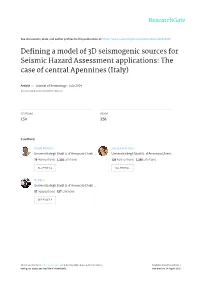
Defining a Model of 3D Seismogenic Sources for Seismic Hazard Assessment Applications: the Case of Central Apennines (Italy)
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/226266337 Defining a model of 3D seismogenic sources for Seismic Hazard Assessment applications: The case of central Apennines (Italy) Article in Journal of Seismology · July 2004 DOI: 10.1023/B:JOSE.0000038449.78801.05 CITATIONS READS 150 258 3 authors: Paolo Boncio Giusy Lavecchia Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti … Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti … 79 PUBLICATIONS 1,338 CITATIONS 138 PUBLICATIONS 2,385 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE B. Pace Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti … 57 PUBLICATIONS 537 CITATIONS SEE PROFILE All in-text references underlined in blue are linked to publications on ResearchGate, Available from: Paolo Boncio letting you access and read them immediately. Retrieved on: 24 August 2016 Journal of Seismology 8: 407–425, 2004. 407 C 2004 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Defining a model of 3D seismogenic sources for Seismic Hazard Assessment applications: The case of central Apennines (Italy) Paolo Boncio∗, Giusy Lavecchia & Bruno Pace Geodynamics and Seismogenesis Laboratory, Dipartimento di Scienze della Terra, Universita` “G. d’Annunzio” – Campus Universitario, 66013 Chieti, Italy ∗author for correspondence: e-mail: [email protected] Received 14 March 2003; accepted in revised form 13 January 2004 Key words: active fault, earthquake, maximum expected magnitude, rheology, seismic hazard, seismogenic source, segmentation, structural geology Abstract Geology-based methods for Probabilistic Seismic Hazard Assessment (PSHA) have been developing in Italy. These methods require information on the geometric, kinematic and energetic parameters of the major seismogenic faults. In this paper, we define a model of 3D seismogenic sources in the central Apennines of Italy. -

Boll. Soc. Entomol. 142-3-2 30-11-2010 10:51 Pagina 111
Boll. Soc. Entomol. 142-3-2 30-11-2010 10:51 Pagina 111 BOLL. SOC. ENTOMOL. ITAL., 142 (3): 111-120 30 NOVEMBRE 2010 Paolo NERI & Augusto VIGNA TAGLIANTI Note su Ocydromus alticola e O. incognitus, con descrizione di una nuova razza di O. alticola dei Monti della Laga, Appennino Centrale (Coleoptera Carabidae) Riassunto - Vengono discussi alcuni aspetti tassonomici e nomenclatoriali del genere Ocydromus Clairville, 1806, con particolare ri- ferimento alle specie italiane del “Gruppe des nitidulum” sensu Netolitzky (1943), Ocydromus alticola (A. Fiori, 1903) e O. incognitus (G. Müller, 1931), che presentano il medesimo schema di struttura dell’endofallo e che vengono assegnate al sottogenere Peryphus De- jean, 1821. Viene presentato uno schema di confronto tra la terminologia qui utilizzata e quelle adottate dai precedenti autori nella descrizione delle medesime strutture dell’endofallo dei vari sottogeneri. Viene infine descritto Ocydromus (Peryphus) alticola lagae n. ssp. dei Monti della Laga (Appennino Centrale), che differisce dalla forma tipica di Maiella, Monti della Meta, Marsicano e Greco per le antenne scure, la forma del pronoto, la microscultura e punteggiatura elitrale e la forma del lobo mediano dell’edeago. Abstract - Notes on Ocydromus alticola and O. incognitus, with description of a new subspecies of O. alticola from Monti della Laga, Central Apennine (Coleoptera Carabidae). Some taxonomical and nomenclatorial problems concerning the genus Ocydromus Clairville, 1806 are discussed with particular ref- erence to which subgenus the italian species of the “Gruppe des nitidulum” sensu Netolitzky (1943) are to be referred to. Ocydromus incognitus (G. Müller, 1931) and Ocydromus alticola (A. Fiori, 1903), characterized by a similar morphology of the endophallus, are included in the subgenus Peryphus Dejean, 1821. -

Programma Escursioni
CLUB ALPINO ITALIANO Programma escursioni Sezione di Palestrina Via Porta S.Martino 5 www.caipalestrina.it 13 Gennaio - Alpinismo invernale 27 - 28 aprile – Escursionismo (Alpinismo giovanile) Il Montagnone m. 1.880 e M. Serrone m. 1.974 (Monti Marsicani) Monte Guadagnolo (Monti Prenestini) Da Capo d’Acqua per il Vallone Carbonara e la “Cresta Est” 1° giorno (dalle ore 16,00): Anello di Monte Cerel la, cena e Ore di salita: 3,30 - dislivello: m 950 - difficoltà: P.D.+ pernottamento alla foresteria del santuario della Mentorella Occorrono ramponi piccozza e imbragatura 2° giorno: Sentiero Karol Wojtyla - Dal Santuario della Direttori di escursione: V. Abbate, A. Cianca Mentorella m.1016 ad Ara di Palazzo m. 561 e ritorno 20 Gennaio – Escursionismo Ore: 4.00 - Dislivello: m. 455 - Difficoltà: E Monte Gennaro m. 1.275 (Monti Lucretili) Direttori di escursione: A. Iori, E. Panci, G. Soro (ASE) Da Palombara Sabina per i ruderi del convento di S. Nicola, In collaborazione con la Pastorale Giovale Diocesana e il la funivia e la cresta ovest. Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra Ore 5 - Dislivello m. 790 – Difficolta: E - Dislivello m. 790 5 Maggio – Alpinismo invernale Direttori di escursione: G. Febbo, G. Soro (ASE), M. Avati Monte Sirente m. 2.348 per il Canale Majore 27 Gennaio – Ciaspole e Sci escursionismo Da Fonte dell'Acqua m.1.180 (Secinaro - AQ) Monte Cornacchia m. 2.118 (Gruppo del Velino) Ore: 6.00 – Dislivello in salita m. 1.170 - Difficoltà P.D.+ Dal Valico della Chiesola di Lucoli m. 1.668 Direttori di escursione: C. Febbo, G. -

The Campotosto Linkage Fault Zone Between the 2009 and 2016 Seismic Sequences of Central Italy: Implications for Seismic Hazard Analysis
The Campotosto linkage fault zone between the 2009 and 2016 seismic sequences of central Italy: Implications for seismic hazard analysis Emanuele Tondi1,2, Danica Jablonská1, Tiziano Volatili1, Maddalena Michele2, Stefano Mazzoli1, and Pietro Paolo Pierantoni1,† 1 School of Science and Technology, Geology Division, University of Camerino, Camerino, 62032 Macerata, Italy 2Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 00143 Rome, Italy ABSTRACT this fault has been considered as an active The CAFS is an interactive active fault sys- and silent structure (therefore representing a tem, extending along the central Apennines in In the last decade central Italy was struck seismic gap) able to generate an earthquake a north-south direction for a length of ∼100 km by devastating seismic sequences resulting in of Mw max = 6.5–7.0. However, the geologi- and ∼50 km of width (Cello et al., 1997). This hundreds of casualties (i.e., 2009-L′Aquila cal evidence provided with this study sug- system includes several active and capable moment magnitude [Mw] = 6.3, and gests that the MGF is of early (i.e., pre- to faults (sensu IAEA, 2010), interpreted as the 2016-Amatrice-Visso-Norcia Mw max = 6.5). syn-thrusting) origin. Therefore, the evalua- surface expression of deep seismogenic faults These seismic events were caused by two tion of the seismic hazard in the Campotosto (Barchi et al., 2000; Galadini and Galli, 2000; NW-SE–striking, SW-dipping, seismogenic area should not be based on the geometrical Tondi, 2000). Many of the scientific papers on normal faults that were modeled based on the characteristics of the outcropping MGF. -

Brunnen Der Vatikani
Brunnen der Vatikani- x der Johannesturm schen Gärten x das Päpstliche Äthiopi- sche Kolleg Es gibt zahlreiche kunstvoll x der Governatoratspalast gestaltete Brunnen in den x Kirche Santo Stefano Gärten; vor allem während degli Abissini der Renaissance und des x Direktion Radio Vatikan Barock entstanden zahlrei- x der Vatikanische Bahn- che kunstvolle Brunnen in hof den Gärten, die den künstle- x der Vatikanische Ge- rischen Repräsentationsbe- richtshof darf der Päpste spiegeln: x Casina x Adlerbrunnen x Päpstliche Akademie der x Brunnen und Wasser- Wissenschaften spiele der Casina Pius’ x Kutschenpavillon IV. x Haus des Erzpriesters x Galeerenbrunnen (liegt außerhalb der Vatikani- x Palazzo San Carlo schen Gärten, am Piazza- x Gallinaro-Turm le della Galera in der x Turm der Winde Vatikanstadt) x Gärtnerhaus x Josefsbrunnen, 2010 errichtet und Papst Bene- Sonstiges dikt XVI. gewidmet x Muschelbrunnen Ein Teil der Vatikanischen x Puttenbrunnen Gärten kann innerhalb einer Führung (nur nach Voran- x Sakramentsbrunnen meldung) besichtigt werden. x Tritonenbrunnen, im Für die Pflege ist das Direk- Rosengarten torat Technikdienste des Governatorats der Vatikan- Gebäude in den Vatikani- stadt (Governatorato S.C.V. schen Gärten í Direzione dei Servizzi Technici í Servizio Giardi- x Leoninische Mauer ni) zuständig. x Sendezentrale Marconi - 121 - säure Schäden an den Farb- Stanzen des Raf- schichten verursachte. Die fael aktuelle Restaurierung durch Maurizio De Luca, Chefres- Die Stanzen des Raffael taurator der Vatikanischen (von ital. stanza für Zimmer) Museen, unter kunsthistori- sind Gemächer im Apostoli- scher Leitung durch Arnold schen Palast, die von Raffael Nesselrath, Direktor der und seiner Schule ausgemalt byzantinischen, mittelalterli- wurden. chen und modernen Abtei- lung der Vatikanischen Mu- Ursprünglich von Julius II. -

2201 Allegato1.Pdf
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO DIPARTIMENTO DI ECOLOGIA E SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE Coordinatore del Dottorato in Ecologia e Gestione delle Risorse Biologiche DECOS - Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico Sostenibile CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN ECOLOGIA E GESTIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE XXI CICLO. La LEPRE ITALICA e la LEPRE EUROPEA nel LAZIO: MODELLI di IDONEITA’ AMBIENTALE a CONFRONTO BIO/07 - Ecologia. Coordinatore: Prof.ssa Roberta Cimmaruta Firma ……………………… Tutor: Dott. Francesco Riga Firma……………………… Dottoranda: Silvia Properzi Firma ………………………….. Alla Passione, vero motore del mondo e alla ricerca scientifica, troppo spesso sottovalutata INDICE PREMESSA……………………………………………………………………………………1 1 INTRODUZIONE ............................................................................................................... 3 1.1 Scopi del progetto di ricerca ........................................................................................... 5 2 I LAGOMORFI ................................................................................................................... 7 2.1 I Lagomorfi ..................................................................................................................... 7 2.1.1 Origine dei Lagomorfi ............................................................................................. 8 2.1.2 Evoluzione del genere Lepus in Europa ................................................................ 10 2.1.2.1 Tassonomia e distribuzione ........................................................................... -

Central Apennines, Italy) During the Pleistocene
feart-08-00130 May 28, 2020 Time: 17:12 # 1 ORIGINAL RESEARCH published: 29 May 2020 doi: 10.3389/feart.2020.00130 Spatial-Temporal Evolution of Extensional Faulting and Fluid Circulation in the Amatrice Basin (Central Apennines, Italy) During the Pleistocene Gianluca Vignaroli1,2*, Marco Mancini2, Mauro Brilli2, Francesco Bucci3, Mauro Cardinali3, Francesca Giustini2, Mario Voltaggio2, Tsai-Luen Yu4,5 and Chuan-Chou Shen4,5,6 1 Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italy, 2 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Rome, Italy, 3 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, Perugia, Italy, 4 High-Precision Mass Spectrometry and Environment Change Laboratory, Department of Geosciences, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 5 Research Center for Future Earth, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 6 Global Change Research Center, National Taiwan University, Taipei, Taiwan In extensional continental settings, crustal-scale normal faults can accommodate Edited by: deformation and subsidence at their hanging wall via activation and deactivation of Alessandro Tibaldi, University of Milano-Bicocca, Italy subsidiary tectonic structures. Geological data obtained from subsidiary structures Reviewed by: are required to infer the position of the tectonic deformation during the spatial- Alessandro Maria Michetti, temporal evolution of the growth-fault system, with significant implications for structures University of Insubria, Italy Krzysztof Gaidzik, belonging to seismogenic settings. Here, we describe a subsidiary tectonic structure University of Silesia in Katowice, (the Amatrice Fault System) accommodating Quaternary extensional deformation in Poland the Amatrice Basin (central Apennines, Italy), which is an intermountain morpho- *Correspondence: structural depression involved by the 2016–2017 seismic sequence. -

Catalogue of Passes in Italy
CLUB DES CENT COLS Catalogo dei passi d’Italia Edizione dei Cent Cols Foto della copertina : Passo dello Stelvio Foto Dieter Drescher - Foto & Webdesign I-39012 Merano, Schallhofweg 4a Hanno collaborato a questo catalogo: Enrico ALBERINI Renato BACCANELLI Jean BERNAUER Gérard BIRELLI Graham CUTTING Alberto IADEROSA Luigi SPINA Ludger VORBERG E per l'edizione: Enrico ALBERINI, Gérard BIRELLI, Daniel BOSSARD, Graham CUTTING, Mario LABELLE, Patrick SCHLEPPI, Il catalogo è pubblicato in tre lingue: francese, inglese e italiano Prima Edizione 2016 Copyright © 2016 Edizione dei Cent Cols 965, Route du Chef Lieu 74330 CHOISY FRANCE Nota: questo catalogo copre l'insieme del territorio italiano comprese le isole. Annulla e sostituisce i cataloghi precedenti : ° Catalogo dei passi d’Italia Nord-Ovest (Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia) ° Catalogo dei passi d’Italia Nord Est (Trentino, Alto - Adige, Veneto), ° Catalogo dei passi del Friuli Venezia Giulia, ° Catalogo dei passi della Sardegna, Così come le differente liste che sono circolate in assenza dei cataloghi delle altre regioni d'Italia. Gli autori dei cataloghi erano: Fabrizio Lorenzini, Alberto Iaderosa, Monica Vicariotto, Paolo Falletti, Tullio Forelli, Carlo-Alberto Goria, Luigi Spina. 1. INTRODUZIONE Il presente catalogo ha avuto bisogno di una lunga maturazione a causa delle risorse limitate e delle fonti documentarie molto diverse, eterogenee, parzialmente legate alla specificità dell'Italia e all'ampiezza del compito di costituire una base completa d'analisi. Un primo lavoro è consistito nel riprendere tutti i cataloghi regionali pubblicati in precedenza, alla luce di una applicazione rigorosa della Regola del Gioco del Club des Cent Cols, con riferimento alle fonti ufficiali e delle mappe degli istituti cartografici affidabili. -

Piano Di Azione Per La Coturnice in Provincia Di Rieti.Pdf
Provincia di Rieti Assessorato alle Politiche Ambientali – Caccia e Pesca – Protezione Civile Assessore: Giacomo Marchioni [email protected] Università degli Studi della Tuscia - Viterbo Dipartimento di Produzioni Animali – Facoltà di Agraria Osservatorio per lo Studio e la Gestione delle Risorse Faunistiche [email protected] www.unitus.it/osservatorio_faunistico PRO AlectoRIs PIANO D’AZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA COTURNICE IN PROVINCIA DI RIETI A CURA DI: prof. Andrea Amici (Coordinatore) DIPA – Università della Tuscia (VT) dr. Settimio Adriani Tecnico Faunistico – Libero professionista prof. Lorenzo Boccia DAF – Università della Tuscia (VT) dr. Marco Bonanni Naturalista – Libero professionista dr.ssa Lodovica Fabiani Tecnico Faunistico – Libero professionista dr.ssa Valentina Fasciolo Tecnico Faunistico – Libero professionista dr. Raffaele Pelorosso DAF – Università della Tuscia (VT) dr. Riccardo Primi DIPA – Università della Tuscia (VT) dr. Fioravante Serrani DIPA – Università della Tuscia (VT) Provincia di Rieti – Assessorato alle Politiche Ambientali Università della Tuscia – Dip. Produzioni Animali . Ringraziamenti Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del volume, in particola- re il personale dell’Ufficio Caccia della Provincia di Rieti, ed i numerosi volontari che hanno partecipato alle operazioni di campo. Un sincero ringraziamento al Direttore ed al Personale della Riserva Naturale Parziale Montagne della Duchessa, per il sostegno logistico e tecnico e per aver messo a disposizione i dati disponibili. Piano d’Azione per la conservazione della Coturnice in Provincia di Rieti 2 Provincia di Rieti – Assessorato alle Politiche Ambientali Università della Tuscia – Dip. Produzioni Animali PRESENTAZIONE Il piano d’azione per la conservazione della coturnice è stato redatto per la salvaguardia, nel lungo periodo, della coturnice (Alectoris graeca) in provincia di Rieti. -

Distretto Idrografico Dell'appennino Meridionale
Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it __________________________________________________ PIANO DI GESTIONE ACQUE (Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09, D.L. 194/09) Relazione Generale Allegato 4 ANALISI DEL PAESAGGIO Febbraio 2010 Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it __________________________________________________ SOMMARIO 1 PREMESSA ____________________________________________________________________ 2 2 IL PAESAGGIO NELLA SUA VISIONE PERCETTIVO-FORMALE ED ESTETICA _____ 7 2.1 IL PAESAGGIO DELLA REGIONE ABRUZZO _________________________________________________________ 9 2.2 IL PAESAGGIO DELLA REGIONE BASILICATA ______________________________________________________ 12 2.3 IL PAESAGGIO DELLA REGIONE CALABRIA _______________________________________________________ 16 2.4 IL PAESAGGIO DELLA REGIONE CAMPANIA _______________________________________________________ 25 2.5 IL PAESAGGIO DELLA REGIONE LAZIO __________________________________________________________ 35 2.6 IL PAESAGGIO DELLA REGIONE MOLISE _________________________________________________________ -

Club Alpino Italiano SEZIONE RIETI 1933
Club Alpino Italiano SEZIONE RIETI 1933 2021 INDICE Saluto del Presidente della Sezione 1 Programma attività 2021 71 Organi della Sezione 5 gennaio 73 Iscrizione e quote 6 febbraio 74 Escursionismo 8 marzo 76 Titolati, Qualificati, Direttori di Escursione 12 aprile 78 Sentieristica 14 maggio 80 Rifugi della Sezione 17 giugno 84 Rifugio Massimo Rinaldi 17 luglio 87 Rifugio Angelo Sebastiani 19 agosto 89 Alpinismo Giovanile 21 settembre 90 MontagnAttiva 23 ottobre 94 MontagnaTerapia 24 novembre 97 Commissione Medica 29 dicembre 99 Tutela Ambiente Montano 31 Immagini 100 Speleologia 33 Seniores 35 Coro 38 Cultura 40 Il Sentiero dell’Inglese 42 Le bellezze della Sabina: Farfa, Fara in Sabina, Toffia 44 Alla scoperta delle bellezze dell’Umbria: Valle del Menotre 50 Arrampicata 55 Gruppo Territoriale Rascino 57 Sottosezione “Valle Gemini” Poggio Mirteto 59 Sottosezione “Cima d’Arme” Poggio Bustone 61 Corsi 63 Soccorso Alpino 65 GeoResQ 67 Carte Escursionistiche 70 “La montagna è scuola di carattere, di onestà, di solidarietà umana, di amore per la natura.” Luigi Bombardieri Ho accettato con responsabilità e umiltà l’invito del Presidente Onorario, Pietro Ratti, di quello uscente, Giuseppe “Pippi” Quadruccio, e degli altri Consiglieri a ri- coprire la carica di Presidente della Sezione di Rieti. Spero di essere all’altezza del compito da svolgere, compito che potrà contare sulla collaborazione del Consiglio Direttivo tutto, a partire dal Vice Presidente “Pippi” Quadruccio e dalla Segretaria Monica Festuccia, in quel gioco di squadra che, solo -

DISTRIBUZIONE E CONSISTENSA NUMERICA DEL CAPRIOLO (Capreolus Capreolus)
DISTRIBUZIONE E CONSISTENSA NUMERICA DEL CAPRIOLO (Capreolus capreolus) NEL PARCO NAZIONALE DEL GRANSASSO E MONTI DELLA LAGA Dicembre 2011 DISTRIBUZIONE E CONSISTENSA NUMERICA DipartimentoDEL di Scienze CAPRIOLO e Tecnologie per ( l’Agricoltura,Capreolus le capreolusForeste, la Natura) NEL e l’Energia (DAFNE) DISTRIBUZIONE E CONSISTENSA NUMERICA DEL CAPRIOLO (Capreolus capreolus) Nel PARCO NAZIONALE DEL GRANSASSO E MONTI DELLA LAGA Hanno collaborato: Andrea Amici (coordinatore) Marco Bonanni Silvano Porfirio Settimio Adriani Ringraziamenti per la loro cortese collaborazione a tutti quelli che hanno contribuito alla attuazione del progetto. Un particolare ringraziamento a Nicoletta Riganelli e Osvaldo Locasciulli per i preziosi consigli ed il costante supporto. Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura le Foreste, la Natura l’Energia (DAFNE), Università degli Studi della Tuscia - Osservatorio per lo Studio e la Gestione delle Risorse Faunistiche Via S. Camillo de Lellis, snc, 01100- Viterbo Tel. 0761357443 - Fax 0761357434 [email protected] - www.unitus.it/osservatorio_faunistico/ INDICE Premessa pag 1 Capitolo 1 pag 2 USO DEGLI HABITAT E STATUS DEL CAPRIOLO Capitolo 2 pag 9 SCELTA DELLA TECNICA DI MONITORAGGIO Capitolo 3 pag 13 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 3.1 Area di studio Campotosto pag 13 3.2 Area di studio Amatrice pag 17 3.3 Indici ambientali e di paesaggio pag 20 Capitolo 4 pag 21 INDIVIDUAZIONE DEI TRANSETTI E SEGNI DI PRESENZA 4.1 Area Campotosto pag 25 4.2 Area Amatrice pag 26 Capitolo 5 pag 28 ANALISI DEI DATI 5.1 Distribuzione del Capriolo nelle aree campione pag 28 5.2 Criteri e modalità per l’analisi dei dati del ‘pellet count’ pag 34 5.2.1 Densità pag 34 5.2.2 Indice chilometrico di abbondanza pag 37 CAPITOLO 6 pag 40 MODELLI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE CAPITOLO 7 pag 45 CRITICITÀ E MIGLIORAMENTI AMBIENTALI 7.1 Gestione forestale pag 45 7.2 Gestione agricola pag 46 7.3 Controllo dei cani vaganti pag 47 7.4 Altri interventi pag 48 FUTURE ATTIVITÀ DI STUDIO pag 50 Bibliografia pag 52 Allegati 1.