DISTRIBUZIONE E CONSISTENSA NUMERICA DEL CAPRIOLO (Capreolus Capreolus)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Abruzzo: Europe’S 2 Greenest Region
en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 1 Abruzzo: Europe’s 2 greenest region Gran Sasso e Monti della Laga 6 National Park 12 Majella National Park Abruzzo, Lazio e Molise 20 National Park Sirente-Velino 26 Regional Park Regional Reserves and 30 Oases en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 2 ABRUZZO In Abruzzo nature is a protected resource. With a third of its territory set aside as Park, the region not only holds a cultural and civil record for protection of the environment, but also stands as the biggest nature area in Europe: the real green heart of the Mediterranean. en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 3 ABRUZZO ITALY 3 Europe’s greenest region In Abruzzo, a third of the territory is set aside in protected areas: three National Parks, a Regional Park and more than 30 Nature Reserves. A visionary and tough decision by those who have made the environment their resource and will project Abruzzo into a major and leading role in “green tourism”. Overall most of this legacy – but not all – is to be found in the mountains, where the landscapes and ecosystems change according to altitude, shifting from typically Mediterranean milieus to outright alpine scenarios, with mugo pine groves and high-altitude steppe. Of all the Apennine regions, Abruzzo is distinctive for its prevalently mountainous nature, with two thirds of its territory found at over 750 metres in altitude.This is due to the unique way that the Apennine develops in its central section, where it continues to proceed along the peninsula’s -

Rifugio Campo Imperatore + Center for Ecotourism and Cultural Creativity
CAMPO IMPERATORE Center for Ecotourism + Cultural Creativity ANALYSIS, RESEARCH AND DESIGN FOR THE REQUALIFICATION OF NEGLECTED SPACES Prepared by Elsa G. De Leon ENVIRONMENT LOCATION Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Provincia di Terramo Urbino Provincia Marche di Pescara Abruzzo Campo L’Aquila Provincia Imperatore Lazio di Chieti Roma Campo Imperatore Parco Nazionale della Parco Nazionale Provincia Majella dell’Aquila d’Abruzzo ABRUZZO - ITALY. Italian Region. PROVINCIA DELL’AQUILA. Abruzzo Province. GRAN SASSO. National Park. CAMPO IMPERATORE. Alpine meadow. ASCOLIPICENO CULTURAL + VALUES SAN GIACOMO L’ecomuseo di Valle Castellana Ripe Valle Castellana Lago di CEPPO Campotosto L’ecomuseo di Lago di Valle Castellana Campotosto TERAMO AMATRICE CAMPOTOSTO PIETRACAMELA ISOLA DEL GRAN SASSO Arsita Prati di Tivo S. Pietro CAMPO IMPERATORE Museo del Camoscio Orto Botanico Appenninico di San Colombo FONTE VETICA FONTE CERRETO Farindola Arischia Assergi LAGO RACOLLO S. Stefano di Sessanio L’AQUILA Barisciano Calascio PARCO NAZIONALE L’Aquila Centro GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA Visite Fiume Tirino Bussi sul Tirino Historic Center km 0 1 2 3 4 5 km ENVIRONMENTAL + CULTURAL VALUES 150.000 3 5 44 HECTARES REGIONS PROVINCES MUNICIPALITIES BIODIVERSITY AGRO-BIODIVERSITY 51 In danger flora Cereals Solina, Farro Rosso 59 Spontaneous Orchids Legumes Lentils of Santo Stefano di Sessanio 2 Carnivorous plants Vegetables Red Potato Aromatic Plants Tansy, Customary 2364 Register Plants Fruit Trees Apples, figs, Mediterranean hack berry, almonds -

Discovery Marche.Pdf
the MARCHE region Discovering VADEMECUM FOR THE TOURIST OF THE THIRD MILLENNIUM Discovering THE MARCHE REGION MARCHE Italy’s Land of Infinite Discovery the MARCHE region “...For me the Marche is the East, the Orient, the sun that comes at dawn, the light in Urbino in Summer...” Discovering Mario Luzi (Poet, 1914-2005) Overlooking the Adriatic Sea in the centre of Italy, with slightly more than a million and a half inhabitants spread among its five provinces of Ancona, the regional seat, Pesaro and Urbino, Macerata, Fermo and Ascoli Piceno, with just one in four of its municipalities containing more than five thousand residents, the Marche, which has always been Italyʼs “Gateway to the East”, is the countryʼs only region with a plural name. Featuring the mountains of the Apennine chain, which gently slope towards the sea along parallel val- leys, the region is set apart by its rare beauty and noteworthy figures such as Giacomo Leopardi, Raphael, Giovan Battista Pergolesi, Gioachino Rossini, Gaspare Spontini, Father Matteo Ricci and Frederick II, all of whom were born here. This guidebook is meant to acquaint tourists of the third millennium with the most important features of our terri- tory, convincing them to come and visit Marche. Discovering the Marche means taking a path in search of beauty; discovering the Marche means getting to know a land of excellence, close at hand and just waiting to be enjoyed. Discovering the Marche means discovering a region where both culture and the environment are very much a part of the Made in Marche brand. 3 GEOGRAPHY On one side the Apen nines, THE CLIMATE od for beach tourism is July on the other the Adriatic The regionʼs climate is as and August. -

(1990). Lithological Analysis of Material Used for the Sacred Area of Saidu Sharif I (Swat Valley, N.W.F.P., Pakistan) and Their Origins
Claudio Faccenna Curriculum Vitae Publication list 1 Di Florio R., Faccenna C., Lorenzoni S. & Lorenzoni Zanettin E. (1990). Lithological analysis of material used for the sacred area of Saidu Sharif I (Swat Valley, N.W.F.P., Pakistan) and their origins. In"Saidu Sharif I (Swat, Pakistan). The Buddhist sacred area: the stupa terrace - Appendix D-" edito da Faccenna D., Reports and Memoires IsMEO, vol. XXIII.2, 317-340. 2 De Vittorio P., Faccenna C. & Praturlon A. (1991). Monte Velino-Monti della Magnola- Monte Sirente. In Damiani et al. "Elementi litostratigrafici per una sintesi delle facies carbonatiche meso-cenozoiche dell'Appennino centrale". Studi Geologici Camerti, vol. sp. 1991/2, 203-205. 3 Di Florio R., Faccenna C., Lorenzoni S. & Lorenzoni Zanettin E. (1993). Lithological analysis of material used for the sacred area of Panr I (Swat valley, Northern Pakistan) and their origins. In "PanrI, Swat, Pakistan-Appendix D-" edita da Faccenna D., Nabi Khan A. & Nadiem I.H. Reports and Memoires IsMEO, 357-372. 4 De Vittorio P. & Faccenna C. (1990). Ulteriori dati sulla tettonica da thrust presente nell’area Sirente-Magnola. Geologica Romana, vol. XXVI (1987), 287-291. 5 Faccenna C. & Funiciello R. (1993). Tettonica pleistocenica tra il Monte Soratte e i Monti Cornicolani. Il Quaternario, 6 (1), 103-118. 6 Faccenna C., Olivieri L., Lorenzoni S. & Lorenzoni Zanettin E. (1993). Geo-archeology of the Swat Valley (N.W.F.P. Pakistan) in the Charbag-Barikot stretch. Preliminary note. East and West (IsMEO), vol. 41, 1-4, 257-270. 7 Faccenna C., Florindo F., Funiciello R. & Lombardi S. (1993). -

Map 44 Latium-Campania Compiled by N
Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -

S Italy Is a Contracting Party to All of the International Conventions a Threat to Some Wetland Ibas (Figure 3)
Important Bird Areas in Europe – Italy ■ ITALY FABIO CASALE, UMBERTO GALLO-ORSI AND VINCENZO RIZZI Gargano National Park (IBA 129), a mountainous promontory along the Adriatic coast important for breeding raptors and some open- country species. (PHOTO: ALBERTO NARDI/NHPA) GENERAL INTRODUCTION abandonment in marginal areas in recent years (ISTAT 1991). In the lowlands, agriculture is very intensive and devoted mainly to Italy covers a land area of 301,302 km² (including the large islands arable monoculture (maize, wheat and rice being the three major of Sicily and Sardinia), and in 1991 had a population of 56.7 million, crops), while in the hills and mountains traditional, and less resulting in an average density of c.188 persons per km² (ISTAT intensive agriculture is still practised although land abandonment 1991). Plains cover 23% of the country and are mainly concentrated is spreading. in the north (Po valley), along the coasts, and in the Puglia region, A total of 192 Important Bird Areas (IBAs) are listed in the while mountains and hilly areas cover 35% and 41% of the land present inventory (Table 1, Map 1), covering a total area of respectively. 46,270 km², equivalent to c.15% of the national land area. This The climate varies considerably with latitude. In the south it is compares with 140 IBAs identified in Italy in the previous pan- warm temperate, with almost no rain in summer, but the north is European IBA inventory (Grimmett and Jones 1989; LIPU 1992), cool temperate, often experiencing snow and freezing temperatures covering some 35,100 km². -
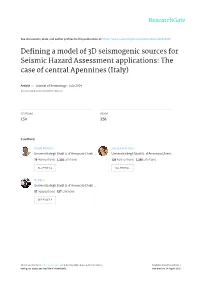
Defining a Model of 3D Seismogenic Sources for Seismic Hazard Assessment Applications: the Case of Central Apennines (Italy)
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/226266337 Defining a model of 3D seismogenic sources for Seismic Hazard Assessment applications: The case of central Apennines (Italy) Article in Journal of Seismology · July 2004 DOI: 10.1023/B:JOSE.0000038449.78801.05 CITATIONS READS 150 258 3 authors: Paolo Boncio Giusy Lavecchia Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti … Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti … 79 PUBLICATIONS 1,338 CITATIONS 138 PUBLICATIONS 2,385 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE B. Pace Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti … 57 PUBLICATIONS 537 CITATIONS SEE PROFILE All in-text references underlined in blue are linked to publications on ResearchGate, Available from: Paolo Boncio letting you access and read them immediately. Retrieved on: 24 August 2016 Journal of Seismology 8: 407–425, 2004. 407 C 2004 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Defining a model of 3D seismogenic sources for Seismic Hazard Assessment applications: The case of central Apennines (Italy) Paolo Boncio∗, Giusy Lavecchia & Bruno Pace Geodynamics and Seismogenesis Laboratory, Dipartimento di Scienze della Terra, Universita` “G. d’Annunzio” – Campus Universitario, 66013 Chieti, Italy ∗author for correspondence: e-mail: [email protected] Received 14 March 2003; accepted in revised form 13 January 2004 Key words: active fault, earthquake, maximum expected magnitude, rheology, seismic hazard, seismogenic source, segmentation, structural geology Abstract Geology-based methods for Probabilistic Seismic Hazard Assessment (PSHA) have been developing in Italy. These methods require information on the geometric, kinematic and energetic parameters of the major seismogenic faults. In this paper, we define a model of 3D seismogenic sources in the central Apennines of Italy. -

Europe's Greenest Region Gran Sasso E Monti Della Laga National Park Majella National Park Abruzzo, Lazio E Molise Na
en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 1 Abruzzo: Europe’s 2 greenest region Gran Sasso e Monti della Laga 6 National Park 12 Majella National Park Abruzzo, Lazio e Molise 20 National Park Sirente-Velino 26 Regional Park Regional Reserves and 30 Oases Abruzzo Promozione Turismo - Corso V. Emanuele II, 301 - 65122 Pescara - Email [email protected] en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 2 ABRUZZO In Abruzzo nature is a protected resource. With a third of its territory set aside as Park, the region not only holds a cultural and civil record for protection of the environment, but also stands as the biggest nature area in Europe: the real green heart of the Mediterranean. Abruzzo Promozione Turismo - Corso V. Emanuele II, 301 - 65122 Pescara - Email [email protected] en_ambiente&natura:Layout 1 3-09-2008 12:33 Pagina 3 ABRUZZO ITALY 3 Europe’s greenest region In Abruzzo, a third of the territory is set aside in protected areas: three National Parks, a Regional Park and more than 30 Nature Reserves. A visionary and tough decision by those who have made the environment their resource and will project Abruzzo into a major and leading role in “green tourism”. Overall most of this legacy – but not all – is to be found in the mountains, where the landscapes and ecosystems change according to altitude, shifting from typically Mediterranean milieus to outright alpine scenarios, with mugo pine groves and high-altitude steppe. Of all the Apennine regions, Abruzzo is distinctive for its prevalently mountainous nature, -

Boll. Soc. Entomol. 142-3-2 30-11-2010 10:51 Pagina 111
Boll. Soc. Entomol. 142-3-2 30-11-2010 10:51 Pagina 111 BOLL. SOC. ENTOMOL. ITAL., 142 (3): 111-120 30 NOVEMBRE 2010 Paolo NERI & Augusto VIGNA TAGLIANTI Note su Ocydromus alticola e O. incognitus, con descrizione di una nuova razza di O. alticola dei Monti della Laga, Appennino Centrale (Coleoptera Carabidae) Riassunto - Vengono discussi alcuni aspetti tassonomici e nomenclatoriali del genere Ocydromus Clairville, 1806, con particolare ri- ferimento alle specie italiane del “Gruppe des nitidulum” sensu Netolitzky (1943), Ocydromus alticola (A. Fiori, 1903) e O. incognitus (G. Müller, 1931), che presentano il medesimo schema di struttura dell’endofallo e che vengono assegnate al sottogenere Peryphus De- jean, 1821. Viene presentato uno schema di confronto tra la terminologia qui utilizzata e quelle adottate dai precedenti autori nella descrizione delle medesime strutture dell’endofallo dei vari sottogeneri. Viene infine descritto Ocydromus (Peryphus) alticola lagae n. ssp. dei Monti della Laga (Appennino Centrale), che differisce dalla forma tipica di Maiella, Monti della Meta, Marsicano e Greco per le antenne scure, la forma del pronoto, la microscultura e punteggiatura elitrale e la forma del lobo mediano dell’edeago. Abstract - Notes on Ocydromus alticola and O. incognitus, with description of a new subspecies of O. alticola from Monti della Laga, Central Apennine (Coleoptera Carabidae). Some taxonomical and nomenclatorial problems concerning the genus Ocydromus Clairville, 1806 are discussed with particular ref- erence to which subgenus the italian species of the “Gruppe des nitidulum” sensu Netolitzky (1943) are to be referred to. Ocydromus incognitus (G. Müller, 1931) and Ocydromus alticola (A. Fiori, 1903), characterized by a similar morphology of the endophallus, are included in the subgenus Peryphus Dejean, 1821. -

Luoghi Da Scoprire Monti Di Tolfa E Valle Del Mignone Scarica Il Pdf Della Rivista
Anno I - N. 1 ORGANO UFFICIALE COMITATO REGIONALE LAZIO FITETREC ANTE Luoghi da scoprire Monti di Tolfa e Valle del Mignone Scarica il pdf della rivista Speciale L’intervista Monta da Lavoro Romacavalli Assessore alle Origini e tipologie, Un successo Politiche Agricole tradizioni e attualità annunciato Angela Birindelli ® Camera di Commercio Viterbo vagandovagando ScopriScopri paesaggi,paesaggi, luoghi,luoghi, tradizionitradizioni ee saporisapori delladella TusciaTuscia Viterbese.Viterbese. Viterbo ROMA 30 Giugno - 17 Luglio 2011 ECONOMENTI: Gustosi momenti su economia e dintorni Viterbo, via San Pellegrino, Cortile Bonucci In occasione di Caffeina Cultura incontri con esponenti del mondo dell’economia e degustazioni guidate dei prodotti tipici di qualità. MILANO SIENA BOLOGNA 23 Luglio - 15 Agosto 2011 FIRENZE FESTE DEL VINO DELLA TUSCIA A1 Nei Comuni che nella Tuscia vantano una vasta produzione e tradizione vitivinicola ORVIETO oltre cento appuntamenti tra degustazioni, folclore, convegni e spettacoli. 3 - 4 Settembre 2011 SANTA ROSA PERUGIA ARGENTARIO RIETI Viterbo, Piazza S. Carluccio, ex chiesa di S. Salvatore PORTO S. STEFANO TERNI In occasione della Festa di Santa Rosa esposizione e degustazioni guidate ORBETELLO di pani e dolci tipici di qualità a Marchio Tuscia Viterbese. Viterbo ORTE 27 Settembre - 30 Ottobre 2011 A1 FESTE DELLA CASTAGNA DELLA TUSCIA Nei Comuni che nella Tuscia vantano una ricca produzione e tradizione S.S. CASSIA ROMA S.S. AURELIA sulla castanicoltura oltre cento appuntamenti tra degustazioni, folclore, convegni e spettacoli. NAPOLI 26 Novembre - 11 Dicembre 2011 CIVITAVECCHIA ROMA FESTE DELL’OLIO DELLA TUSCIA ROMA Nei Comuni che nella Tuscia vantano una intensa produzione e tradizione olivicola oltre cento appuntamenti tra degustazioni, folclore, convegni e spettacoli. -

I Siti Natura 2000 Del Versante Laziale Del Parco Nazionale Del Gran Sasso E Monti Della Laga
ZPS IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga SIC IT6020025 Monti della Laga (area sommitale) SIC IT6020002 Sede Legale VALLE DEL FIUME TRONTO Lago Secco e Agro Nero Via del Convento, 1 67010 Assergi - L'Aquila Tel. 0862/60521 (centralino automatico) - Fax 0862/606675 www.gransassolagapark.it Polo Agroalimentare Piazza San Francesco - 02012 Amatrice - Rieti Tel. 0746/824519 - Fax 0746/824074 Museo Didattico Un giorno da orista Palazzo Cappelli - Accumoli (RI) Tel. 345/7387163 I SITI NATURA 2000 DEL VERSANTE LAZIALE DEL PARCO NAZIONALE COMUNE DI AMATRICE Via Cola 47, 02012 Amatrice (RI) Tel. 0746 825537 - www.comune.amatrice.rieti.it DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA COMUNE DI ACCUMOLI Via Salvator Tommasi 44, 02011 Accumoli (RI) 0746/80793 - 0746/80577 - www.comune.accumoli.ri.it SEZIONE CAI DI AMATRICE Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto - 02012 Amatrice (RI) - Tel. 339 47 311 94 - www.caiamatrice.it OASI WWF DI LAGO SECCO Le visite all’Oasi sono organizzate su prenotazione. Informazioni Tel. 3483.311853 - [email protected] PIANO DI GESTIONE E RELATIVI STRUMENTI ATTUATIVI PER IL SITO NATURA 2000 ZPS “PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA(IT7110128) E DEISIC “LAGO SECCO ED AGRO NERO (IT6020002)” E “AREA SOMMITALE DEI MONTI DELLA LAGA (IT6020025)” Il SIC Monti della Laga (area sommitale), comprende le cime più I Monti della Laga sono uno dei pochi gruppi montuosi dell’Appennino La Rete Natura 2000 è costituita da un sistema di aree che tutti gli elevate della catena montuosa, con un’altitudine media di circa 2000 metri centrale costituito da arenarie e marne anzichè da rocce calcaree. -

Vasemania: Neoclassical Form and Ornament
VOLUME: 4 WINTER, 2004 Vasemania: Neoclassical Form and Ornament: Selections from The Metropolitan Museum of Art at the Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Design, and Culture Review by Nancy H. Ramage 1) is a copy of a vase that belonged to Ithaca College Hamilton, painted in Wedgwood’s “encaustic” technique that imitated red-figure with red, An unusual and worthwhile exhibit on the orange, and white painted on top of the “black passion for vases in the 18th century has been basalt” body, as he called it. But here, assembled at the Bard Graduate Center in Wedgwood’s artist has taken all the figures New York City. The show, entitled that encircle the entire vessel on the original, Vasemania: Neoclassical Form and and put them on the front of the pot, just as Ornament: Selections from The Metropolitan they appear in a plate in Hamilton’s first vol- Museum of Art, was curated by a group of ume in the publication of his first collection, graduate students, together with Stefanie sold to the British Museum in 1772. On the Walker at Bard and William Rieder at the Met. original Greek pot, the last two figures on the It aims to set out the different kinds of taste — left and right goût grec, goût étrusque, goût empire — that sides were Fig. 1 Wedgwood Hydria, developed over a period of decades across painted on the Etruria Works, Staffordshire, Britain, France, Italy, Spain, and Germany. back of the ves- ca. 1780. Black basalt with “encaustic” painting. The at the Bard Graduate Center.