FREGOSO (CAMPOFREGOSO) (I, II) Inkl
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ministero Per I Beni E Le Attività Culturali E Per Il Turismo Archivio Di Stato Di Genova
http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Archivio di Stato di Genova Instructiones et relationes Inventario n. 11 Regesti a cura di Elena Capra, Giulia Mercuri, Roberta Scordamaglia Genova, settembre 2020, versione 1.1 - 1 - http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DELLE UNITÀ ARCHIVISTICHE Nella richiesta occorre indicare il nome del fondo archivistico e il numero della busta: quello che nell’inventario è riportato in neretto. Ad esempio per consultare 2707 C, 87 1510 marzo 20 Lettere credenziali a Giovanni Battista Lasagna, inviato in Francia. Tipologia documentaria: Lettere credenziali. Autorità da cui l’atto è emanato: Consiglio degli Anziani. Località o ambito di pertinenza: Francia. Persone menzionate: Giovanni Battista Lasagna. occorre richiedere ARCHIVIO SEGRETO 2707 C SUGGERIMENTI PER LA CITAZIONE DELLE UNITÀ ARCHIVISTICHE Nel citare la documentazione di questo fondo, ferme restando le norme adottate nella sede editoriale di destinazione dello scritto, sarà preferibile indicare la denominazione completa dell’istituto di conservazione e del fondo archivistico seguite dal numero della busta, da quello del documento e, se possibile, dall’intitolazione e dalla data. Ad esempio per citare 2707 C, 87 1510 marzo 20 Lettere credenziali a Giovanni Battista Lasagna, inviato in Francia. Tipologia documentaria: Lettere credenziali. Autorità da cui l’atto è emanato: Consiglio degli Anziani. Località o ambito di pertinenza: Francia. Persone menzionate: Giovanni Battista Lasagna. è bene indicare: Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, b. 2707 C, doc. 87 «Lettere credenziali a Giovanni Battista Lasagna, inviato in Francia» del 20 marzo 1510. - 2 - http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it SOMMARIO Nota archivistica p. -

La Signoria Dei Campofregoso a Sarzana
ANNA IVALDI LA SIGNORIA DEI CAMPOFREGOSO A SARZANA (1421 - 1484) Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012 Il presente lavoro fa parte di un piano di studi patrocinato e finanziato dal C.N.R. presso l’istituto di Paleografia e Storia Medievale dell’Università di Genova,, sotto la direzione del prof. Geo Pistarino. Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012 P r e m e s s a Molte questioni particolari riguardanti la signoria dei Campofregoso a Sarzana sono state studiate; mancava tuttavia una monografia circa tale argomento. La presente trattazione è stata condotta sugli studi precedenti e sulla documentazione ricavata dagli Archivi di Stato di Genova e Firenze e dagli Archivi comunale e capitolare di Sarzana; molte lacune potranno, però, essere colmate con più approfondite ricerche negli Archivi ricordati e in Quelli comunali, notarili e privati della Lunigiana. Attraverso i molti particolari, i frammenti e gli episodi, di cui Questa storia è intessuta, appare evidente la vitalità della signoria sarzanese, le cui energie e attività non si esauriscono nell’ambito della Lunigiana, ma vanno inquadrate nella storia italiana del Quattrocento. I - L’insediamento d e i C ampofregoso a Sa r z a n a . Nell’estate del 1421 Filippo Maria Visconti preparava un grande esercito, per cacciare da Genova il doge Tommaso da Campofregoso e farsi signore della città, sollecitato da molti genovesi fuorusciti, ostili alla famiglia del doge ’. Genova, politicamente isolata per la lega del duca con Venezia e Firenze e per l’accostamento tra Filippo Maria e Alfonso d’A- ragona, contro il Quale essa combatteva in Corsica, assediata per terra e per mare, dopo la sconfitta navale di Battista, fratello del doge, dovette arrendersi al Carmagnola2. -

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA Nuova Serie – Vol
ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA Nuova Serie – Vol. LV (CXXIX) Fasc. I Vittorio Poggi (1833-1914) tra la Liguria e l’Europa degli studi GENOVA MMXV NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5 Referees : i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell’elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all’indirizzo: http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp Referees : the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente. All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer. « Atti della Società Ligure di Storia Patria » è presente nei cataloghi di centinaia di biblioteche nel mondo: http://www.storiapatriagenova.it/biblioteche_amiche.asp « Atti della Società Ligure di Storia Patria » is present worldwide in the catalogues of hundreds of academic and research libraries: http://www.storiapatriagenova.it/biblioteche_amiche.asp I saggi contenuti in questo volume sono l’esito della giornata di studi tenutasi a Savona, nel Museo d’Arte di Palazzo Gavotti e Albisola Superiore, a La Pace, Villa Poggi 3 ottobre 2013, in occasione del primo centenario della morte di Vittorio Poggi. Alla sessione mattutina ha presieduto Bruno Massabò (Soprintendente ai Beni Archeo- logici della Liguria), a quella pomeridiana Dino Puncuh (Presidente della Società Ligure di Storia Patria). A cento anni dalla morte di Vittorio Poggi abbiamo voluto ricordare la sua figura poliedrica, espressione di un ceto tipico dei centri minori liguri e di una cultura italiana, che fra la metà dell’Ottocento e il primo Novecento era aperta a tutto campo sull’Europa: possiamo affermare che Vittorio Poggi rappresenti, nei vari aspetti degli studi e delle attività cui si è rivolto, un esempio di quelle personalità che, in tutta la penisola, hanno contribuito a porre le basi per la nascita dell’Italia moderna. -

Reti Medievali E-Book Monografie 4
Reti Medievali E-Book Monografie 4 Reti Medievali E-book Comitato scientifico Claudio Azzara (Università di Salerno) Pietro Corrao (Università di Palermo) Roberto Delle Donne (Università di Napoli Federico II) Stefano Gasparri (Università di Venezia) Paola Guglielmotti (Università di Genova) Gian Maria Varanini (Università di Verona) Andrea Zorzi (Università degli Studi di Firenze) Giovanna Petti Balbi Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale Firenze University Press 2007 Governare la città : pratiche sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale / Giovanna Petti Balbi. – Firenze : Firenze university press, 2007. (Reti Medievali. E-book, Monografie; 4) http://www.storia.unifi.it/_RM/e-book/titoli/PettiBalbi.htm http://digital.casalini.it/9788884536037 ISBN 978-88-8453-603-7 (online) ISBN 978-88-8453-604-4 (print) 945.1804 (ed. 20) Liguria - Medioevo Volume realizzato con il contributo del Prin 2004, Linguaggi e culture politiche nell’Italia del Rinascimento, coordinato da Giuseppe Petralia. Impaginazione: Alberto Pizarro Fernández Editing: Leonardo Raveggi © 2007 Firenze University Press Università degli Studi di Firenze Firenze University Press Borgo Albizi, 28 50122 Firenze, Italy http://epress.unifi.it/ Printed in Italy Indice Introduzione 7 I. Organizzazione familiare 13 1. Strutture familiari nella Liguria medievale 15 2. La vita e la morte: riti e comportamenti in ambito urbano 29 3. I Visconti di Genova: identità e funzioni dei Carmadino (secoli XI-XII) 51 4. I Fieschi: un percorso familiare 83 II. Dinamiche sociali 99 1. Magnati e popolani in area ligure 101 2. L’apogeo della città tra Due e Trecento 127 3. I Gerosolimitani in Liguria in età medievale tra tensioni politiche e compiti istituzionali 145 4. -

Spazi Per La Memoria Storica
SPAZI PER LA MEMORIA STORICA ROMA 2009 Genova, Complesso monumentale di Sant’Ignazio: particolare della loggia di Psiche Genova, Palazzetto criminale PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO SAGGI 93 SPAZI PER LA MEMORIA STORICA La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell’Archivio di Stato Atti del convegno internazionale Genova, 7 - 10 giugno 2004 a cura di ALFONSO ASSINI e PAOLA CAROLI MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2009 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI Servizio III - Studi e ricerca Direttore generale per gli archivi: Luciano Scala Direttore del Servizio III: Patrizia Ferrara Impaginazione: Fausto Amalberti Autorizzazioni alla pubblicazione delle immagini: Accademia Nazionale dei Lincei, Roma Archivio di Stato di Venezia Archivio Storico del Comune di Genova Biblioteca Civica Berio, Genova Biblioteca Nazionale Braidense, Milano British Library, Londra Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine di Genova Staatsbibliothek, Berlino © 2009 Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale per gli archivi ISBN 978-88-7125-302-2 Stampato nel mese di novembre 2009 a cura della Tipografia Brigati Glauco & c. s.d.f. – Genova ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA Manifestazioni “Genova capitale della cultura 2004” Convegno internazionale Spazi per la memoria storica La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell’Archivio di Stato Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Complesso monumentale di Sant’Ignazio, -

Andrea Lercari LA NOBILTÀ CIVICA a GENOVA E in LIGURIA DAL
Andrea Lercari LA NOBILTÀ CIVICA A GENOVA E IN LIGURIA DAL COMUNE CONSOLARE ALLA REPUBBLICA ARISTOCRATICA 1 Ogni studioso che si trovi ad affrontare un tema afferente alla storia genovese, sia questo di taglio politico, sia economico, sia ancora storico-artistico o architettonico o urbanistico, deve confron- tarsi con il composito e complesso ceto dirigente che ebbe il control- lo politico e sociale della città dalle origini del Comune, nel XII secolo, a tutta la durata della Repubblica aristocratica, nata nel 1528 e caduta nel 1797. Attraverso un’evoluzione continua e articolata, il gruppo di potere, diviso nelle fazioni cittadine dei guelfi e ghibellini, prima, e dei nobiles e populares, poi, con la riforma costituzionale del 1528 si organizzò in un vero e proprio patriziato sovrano, nel quale confluirono coloro che avevano già acquisito il diritto di parte- cipare all’amministrazione della cosa pubblica. Si era trattato in sostanza di un’operazione di riordino del ceto dirigente cittadino – nel quale erano già riscontrabili tutte le caratteristiche di una vera e propria nobiltà civica – ispirata dalla necessità di porre fine alle lotte di fazione per il controllo della città. 1 Desidero esprimere un sentito ringraziamento per aver favorito la mia partecipazione al convegno Le aristocrazie cittadine. Evoluzione dei ceti dirigenti urbani nei secoli XV-XVIII all’amico Saverio Simi de Burgis, il quale come discendente di una delle famiglie compo- nenti la nobiltà genovese sin dalle sue origini, i Di Negro, condivide l’interesse per le vicen- de del ceto dirigente dell’antica Repubblica di Genova, e a Marino Zorzi e Girolamo Mar- cello del Majno membri del comitato organizzatore del convegno. -

Copertina2011.Pub (Sola Lettura)
Annuario Statistico Edizione 2012 Sistema Statistico Nazionale Direzione Statistica Prefazione L’Annuario Statistico del Comune di Genova, nelle sue 370 pagine, fornisce una fotografia puntuale ed aggiornata della città attraverso un significativo repertorio di informazioni e dati su tematiche di rilievo quali: economia, lavoro, inflazione, cultura, evoluzione demografica, sanità, trasporti, ambiente e giustizia. Un capitolo è dedicato alla Civica Amministrazione con particolare attenzione alle notizie storiche, all’organizzazione, alle rappresentanze politiche ed ai servizi comunali. L’annuario 2012, la cui maggior parte dei dati è relativa all'anno 2011, non solo aggiorna le tavole pubblicate nell’edizione dell’anno precedente, ma presenta anche serie storiche decennali o quinquennali che consentono di seguire nel tempo, anche attraverso la rappresentazione grafica di un andamento, l’evoluzione di determinati fenomeni. L’attuale edizione presenta aspetti innovativi in termini di contenuto: è stata arricchita di nuove sezioni ed ampliata con informazioni relative all’organizzazione comunale, all’attività dei Municipi, all’istruzione universitaria, alla giustizia. Sono state, inoltre, introdotte tavole contenenti nuovi indicatori ambientali e, all’interno del capitolo dedicato all’Economia, è possibile acquisire i dati dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura svoltosi nel 2010. Le note introduttive ai singoli capitoli sono state dotate di una veste grafica colorata, più consona all'utilizzo via web, con titoli laterali che accompagnano -

Fieschi (I-Vi)
Nikolai Wandruszka: Un viaggio nel passato europeo – gli antenati del Marchese Antonio Amorini Bolognini (1767-1845) e sua moglie, la Contessa Marianna Ranuzzi (1771-1848) 12.1.2010 FIESCHI (I-VI) XIII.7859 Fieschi Francesca, * (ex 2°), oo 1497 Ludovico Gonzaga dei conti di Sabbioneta XIV.15718 Fieschi Gian Luigi, * um 1440 (1441) (ex 2°) als Gottardo, seit 1451 Gian Luigi, + test.: 20.4.1502 Genova e 20.6.1508 Montoggio, morto ante 1510; oo (a) Bartolomea della Rovere, oo (b) (1473) Caterina del Carretto, figlia di Giovanni Lazzarino e di Viscontina Adorno. Per una ampia biografia da Giovanni NUTI ved. DBI 47 (1997), pp.458-462: “Nacque a Genova nella prima metà del sec. XV da Gian Luigi, del ramo di Torriglia della potente casata ligure, e da Luisetta (Lucetta) di Rollando Fregoso; fu battezzato con il nome di Gottardo. Dopo la morte del padre (1451) ne adottò il nome; fu il più giovane della famiglia. Ucciso il fratello maggiore Giovanni Filippo, capo della famiglia (1459), scomparso tragicamente anche un altro fratello, Orlando, venne chiamato ad affiancare un terzo fratello, Ibleto, nel progetto di consolidamento e recupero dei castelli rivieraschi, che in parte erano stati occupati da Genova e dalle altre forze che premevano sul territorio, in primo luogo dalla famiglia Landi. Colpiti i Fieschi dalla politica espansionistica di Galeazzo Maria Sforza, diventato signore di Genova, il F. accompagnò Ibleto nelle peregrinazioni alla ricerca di aiuti militari e trovò alla fine ospitalità a Roma, dove venne protetto da papa Sisto IV. Quando nel marzo del 1477 a Genova esplose la rivolta antisforzesca, collaborò col fratello nel governo della città: si trattò di un breve periodo di predominio, perché le truppe ducali, guidate da R. -

Riccardo Musso "El Stato Nostro De Zenoa"
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Reti Medievali Open Archive Riccardo Musso "El stato nostro de Zenoa". Aspetti istituzionali della prima dominazione sforzesca su Genova (1464-78) [A stampa in "Serta antiqua et mediaevalia", V, Società e istituzioni del medioevo ligure, Roma, Scheiwiller, 2001, pp. 199-236 © dell’ autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]. Premessa Le vicende che, nel 1464, portarono all’affermazione su Genova della signoria di Francesco Sforza sono forse tra le più conosciute della storia genovese, merito soprattutto dell’accurata descrizione che ne diede Albano Sorbelli all’inizio del secolo scorso1; ugualmente noti – sia pure con qualche inesattezza cronologica - sono gli avvenimenti successivi2, e in particolare quelli legati alle due rivolte che, nel 1477 e nel 1478, condussero alla fine della dominazione sforzesca3. Meno conosciuti sono invece gli aspetti istituzionali relativi a questo periodo: una mancanza che, se ben s’inserisce nel quadro generale di scarsa conoscenza delle istituzioni genovesi tardo- medioevali (che diviene macroscopica a livello di storiografia nazionale…), appare invece strana se rapportata alla ricca ed agguerrita bibliografia sullo stato visconteo- sforzesco, oggetto negli ultimi decenni di numerosi e approfonditi studi4. La separazione dello “stato de Zenoa” dal resto dei domini degli Sforza - di cui si darà conto nelle pagine seguenti – è stata così ben recepita dalla storiografia “lombarda” che esso ha continuato ad essere percepito come un elemento sostanzialmente estraneo allo stato sforzesco, nonostante che nei cinquanta anni che gli Sforza dominarono su Milano dalla presa di potere da parte del duca Francesco alla cattura *Abbreviature usate: ASG, Archivio di Stato di Genova; ASM, Archivio di Stato di Milano; DBI, Dizionario Biografico degli Italiani; RIS, Rerum Italicarum Scriptores. -
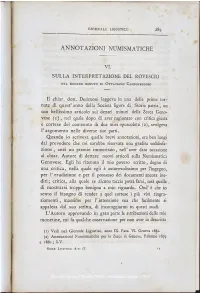
Annotazioni Numismatiche
g io r n a l e ligustico 289 ANNOTAZIONI NUMISMATICHE VI. SULLA INTERPRETAZIONE DEL ROVESCIO NEL DENARO MINUTO DI OTTAVIANO CAMPOFREGOSO Il chiar. dott. Desimoni leggeva in una delle prime tor nate di quest’ anno della Società ligure di Storia patria , un suo bellissimo articolo sui denari minuti della Zecca Geno vese ( i ) , nel quale dopo di aver ragionato con critica giusta e cortese del contenuto di due miei opuscoletti (2), svolgeva 1’ argomento nelle diverse sue parti. Q uando io scriveva quelle brevi annotazioni, era ben lungi dal prevedere che mi sarebbe riservata una gradita soddisfa zione , anzi un premio immeritato, nell’ aver dato occasione al chiar. Autore di dettare nuovi articoli sulla Numismatica Genovese. Egli ha ritenuto il mio povero scritto, degno di una critica, nella quale egli è autorevolissimo per l’ingegno, per 1’ erudizione e per il possesso dei documenti ancora ine diti; critica, alla quale se alcuna taccia potrà farsi, sarà quella . di mostrarsi troppo benigna a mio riguardo. Ond’ è che io sento il bisogno di render a quel cortese i più vivi ringra ziam enti , massime per l’ intenzione sua che facilmente si appalesa dal suo scritto, di incoraggiarmi in questi studi. L ’ A u tore approvando in gran parte le aitribuzioni delle mie m onetine, m i fa qualche osservazione per non aver io descritta (1) Vedi nel Giornale Ligustico, anno IX. Fase. VI. Genova 1882. (2) Annotazioni Numismatiche per la Zecca di Genova. Palermo 1879 e 1881 ; I-V . Giorn. Ligustico, Λ ίπο I X . 1 9 Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012 290 GIORNALE LIGUSTICO tutta la serie conosciuta, non accetta perchè erronea qualche mia dichiarazione, e propone una nuova interpretazione per il minuto dell’Ottaviano, che egli mi fa Γ onore di sottoporre al mio giudizio. -

Carte Antonio Gavazzo
http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Archivio di Stato di Genova Carte Antonio Gavazzo Inventario n. 33/1 trascrizione a cura di Stefania Verrengia indice alfabetico a cura di Francesco Tripodi Genova, luglio 2020, versione 1.1 - 1 - http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DELLE UNITÀ ARCHIVISTICHE Nella richiesta occorre indicare il nome del fondo archivistico e il numero della filza. Ad esempio per consultare 34 Copia di lettera del papa Benedetto XIV a Luigi, re di 1753 gen. 19 Francia (con epigramma francese) occorre richiedere GAVAZZO 1 SUGGERIMENTI PER LA CITAZIONE DELLE UNITÀ ARCHIVISTICHE Nel citare la documentazione di questo fondo, ferme restando le norme adottate nella sede editoriale di destinazione dello scritto, sarà preferibile indicare la denominazione completa dell’istituto di conservazione e del fondo archivistico seguite dal numero della filza e, se possibile, dal numero, dalla data e dalla descrizione del singolo documento. Ad esempio per citare 34 Copia di lettera del papa Benedetto XIV a Luigi, re di 1753 gen. 19 Francia (con epigramma francese) è bene indicare: Archivio di Stato di Genova, Carte Antonio Gavazzo, 1, doc. 34 «Copia di lettera del papa Benedetto XIV a Luigi re di Francia», del 19 gennaio 1753. - 2 - http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it SOMMARIO Introduzione p. 4 Bibliografia p. 8 Inventario p. 9 Filza 1 – docc. 1-250 p. 9 Filza 2 – docc. 251-411 p. 21 Filza 3 – docc. 412-870 p. 29 Filza 4 – docc. 871-1004 p. 56 Indice dei nomi p. -

Della Vita Privata Dei Genovesi Uscì Per La Prima Volta a Stampa Negli Atti Della Società Ligure Di Storia Patria, in Sullo Scorcio Del 1866
Informazioni su questo libro Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo. Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te. Linee guide per l’utilizzo Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate. Inoltre ti chiediamo di: + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.