Metodologia Operativa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

European Project Grapegen 06 - Grapevine Genetic Resources - Version 18 March 2011 P
European Project GrapeGen 06 - Grapevine Genetic Resources European Grapevine Catalogue: Towards a Comprehensive List T. Lacombe, L. Audeguin, M. Boselli, B. Bucchetti, F. Cabello, M. Crespan, C. D’Onofrio, J. Eiras Dias, S. Ercisli, M. Gardiman, MS. Grando, S. Imazio, O. Jandurova, A. Jung, E. Kiss, P. Kozma, E. Maul, D. Maghradze, C. Martinez, G. Muñoz, J-K. Pátková, I. Pejic, E. Peterlunger, D. Pitsoli, D. Preiner, S. Raimondi, F. Regner, G. Savin, S. Savvides, A. Schneider, J-L. Spring, A. Szoke, A. Veres, J-M. Boursiquot, R. Bacilieri and P. This Annex 1 A: List of the grape varieties registered in the Member States of the European Union Legend : in bold, common prime name of the variety according to VIVC database when referenced, # identification number of the variety, species, sex (H = hermaphrodite, F = female, M = male), colour of berry skin (B = yellow-green, N = blue-black, Rg = red, Rs = rose, G = grey). In normal characters, name of the variety as registered in the country and its registered synonyms, country, year of the national catalogue's last update available, utilization allowed in the country (W = wine grape, T = table grape, ROOT = rootstock). Synonyms marked with an * are used under condition (see national regulations). 4 444-6 (# PRT482 no correspondance in VIVC database) - - 444-6 (syn. ¤) : PRT - 2010 - ROOT A ABBUOTO (# 7 ) vinifera - - N Abbuoto N. (syn. ¤) : ITA - 2010 - W ABONDANT (# 24 ) vinifera - H - B Abondant B (syn. ¤) : FRA - 2010 - W ABOURIOU (# 34 ) vinifera - H - N Abouriou N (syn. ¤) : FRA - 2010 - W ABRUSCO (# 32 ) vinifera - - N Abrusco N. (syn. ¤) : ITA - 2010 - W ACCENT (# 20540 ) interspecific cross - - N Accent (syn. -

A Note About Ratings. Although Many Magazines, Web Sites, and Commercial Retailers Rate Wines, the Most Influential Are Probably
Great Red Wines - $20 or Less Compiled by Rick Brusca Vers. July 2015 Name Year RCBs Comments Price Rating (usually Total Wine, sometimes BevMo, CostCo or TJs) A note about ratings. Although many magazines, web sites, and commercial retailers rate wines, the most influential are probably three magazines: The Wine Enthusiast, Wine Spectator, and The Wine Advocate. The Wine Enthusiast magazine reviews over 1000 wines for each issue; not all are published, but all are available at their web site. Wine Spectator review 400-1000 wines per issue. Both use a traditional 100-point scale, and both use panels of professional wine tasters (commonly in blind tastings). The Wine Advocate, launched by wine critic Robert M. Parker in 1978, also reviews many wines in each issue. The magazine’s success allowed Parker to quit practicing law in 1984 and devote himself full time to wine. In 2012, a majority stake in The Wine Advocate was sold to investors from Singapore, with a plan to go from print+online, to fully on-line; however, this has not happened and the print magazine still exists. The role of Editor-in-Chief went from Parker to Lisa Perotti-Brown, and a second editorial office opened in Singapore. Following lead critic Antonio Galloni’s departure from The Wine Advocate in 2013, three new core critics were recruited, Jeb Dunnuck, Monica Larner and Luis Guitérrez. Others also review wines, by specific regions, for the magazine, but Parker continues to do the reviews for northern California (e.g., Napa-Sonoma) and Bordeaux. Robert Parker’s influence in the global wine business has been so powerful that some wineries have been accused of making wines tailored strictly to his tastes. -
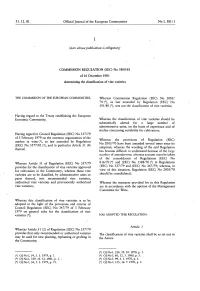
Determining the Classification of Vine Varieties Has Become Difficult to Understand Because of the Large Whereas Article 31
31 . 12 . 81 Official Journal of the European Communities No L 381 / 1 I (Acts whose publication is obligatory) COMMISSION REGULATION ( EEC) No 3800/81 of 16 December 1981 determining the classification of vine varieties THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Whereas Commission Regulation ( EEC) No 2005/ 70 ( 4), as last amended by Regulation ( EEC) No 591 /80 ( 5), sets out the classification of vine varieties ; Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, Whereas the classification of vine varieties should be substantially altered for a large number of administrative units, on the basis of experience and of studies concerning suitability for cultivation; . Having regard to Council Regulation ( EEC) No 337/79 of 5 February 1979 on the common organization of the Whereas the provisions of Regulation ( EEC) market in wine C1), as last amended by Regulation No 2005/70 have been amended several times since its ( EEC) No 3577/81 ( 2), and in particular Article 31 ( 4) thereof, adoption ; whereas the wording of the said Regulation has become difficult to understand because of the large number of amendments ; whereas account must be taken of the consolidation of Regulations ( EEC) No Whereas Article 31 of Regulation ( EEC) No 337/79 816/70 ( 6) and ( EEC) No 1388/70 ( 7) in Regulations provides for the classification of vine varieties approved ( EEC) No 337/79 and ( EEC) No 347/79 ; whereas, in for cultivation in the Community ; whereas those vine view of this situation, Regulation ( EEC) No 2005/70 varieties -

Torino DOC 2012-2013
cover2012OK.qxp 21-12-2011 16:08 Pagina 1 2012 2013 In collaborazione con TORINO DOC ® con il supporto di TORINO DOC • 2012 TORINO Selezione enologica della Camera di commercio di Torino Oenological selection of the Torino Chamber of commerce Sélection oenologique de la Chambre de commerce de Torino ISBN 978-88-903705 - 8 -8 163_184.qxp 18-01-2012 11:24 Pagina 184 002_018 - noPag1.qxp 17-01-2012 14:30 Pagina 1 TORINO DOC Selezione enologica della Camera di commercio di Torino Oenological selection of the Torino Chamber of commerce Sélection oenologique de la Chambre de commerce de Torino 2012 2013 ® In collaborazione con con il supporto di 002_018 - noPag1.qxp 17-01-2012 14:30 Pagina 2 Introduzione 4 IL PIACERE DEL VINO 33 I vini DOC e DOCG della provincia di Torino 68 Foreword DOC and DOCG wines from the Introduction The pleasure of wine province of Torino Le plasir du vin Les vins DOC et DOCG de la province de Torino LA SELEZIONE ENOLOGICA 7 Piccoli accorgimenti per gustare al meglio il vino! 34 Enoteca Regionale dei Vini A few tips to bring out the best from wine! della Provincia di Torino 69 The Oenological Selection Quelques petites astuces pour mieux apprécier le vin! The Regional wine cellar of the Wines La sélection oenologique Conservazione 35 of the Province of Torino L’Oenothèque Régionale des Vins Le aziende e la guida Conservation de la Province de Torino sul proprio cellulare 15 Conservation The wineries and the guide Preparazione, servizio e degustazione 36 Strada Reale dei Vini Torinesi 72 on your cell phone Preparation, -

Disciplinare Di Produzione Dei Vini a Denominazione Di Origine Controllata "Pinerolese"
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "PINEROLESE" Approvato con DM 12.09.1996 GU 227 - 27.09.1996 Modificato con DM 17.02.1997 GU 61 - 14.03.1997 Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con DM 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con DM 13.11.2014 GU 275 – 26.11.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 Denominazione La denominazione di origine controllata “Pinerolese” e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione: “Pinerolese” rosso “Pinerolese” rosato “Pinerolese” Barbera “Pinerolese” Bonarda “Pinerolese” Freisa “Pinerolese” Dolcetto “Pinerolese” Doux d'Henry “Pinerolese” Ramie . Articolo 2 Base ampelografia La denominazione di origine controllata “Pinerolese”, e' riservata ai vini rossi e rosati ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera, Bonarda, Nebbiolo, Chatus da soli o congiuntamente minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Piemonte fino ad un massimo del 50% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato -

Indagine Sul Profilo Antocianico
(;ENS'\HVFf:ilHRAl()2ili)5 ANN()i4 • X. IW INDUSTRIE l^sN0]4l•g>tl DELLE I P P? s. »l:u i. f s J. = 3 s • Etichettatrice da bobina per rappllcazione di etichette in • poiistirene, polipropilene, 1 polietilene ed altri materiali. P.t. s.r.i. via Europa, 25 • Nuovo sistema di 46047 Porto Mantovano (fViN) italy % gestione delle bobine etichette Tel. +39-0376.389311 CCURT (Computer Controlied Fa*: +39-0376.369411 IJnwind Registration and Tension). [email protected] Anche con TERMORETRAZiONE Velocità fino a 1000 BPM. vvww.pelabellers.it CHIRIOTTI i EDITOIU iniM lINKUoro • Tri. Ut 21 .lu.tir TjM'ìH • R.irjìI: N»e >(hirwdlnlhiiri.n VINO VINCENZO CERBI - LUCAROLLE • GIUSEPPE ZEPPA SUMMARY Dlpartlmenta di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestaii(DIVaPRA) - Università degliStudi diTorino - Via l. da Vinci 44 - 1009SGrugllasco • To• Italia Phenolic compounds are very important componenti ofgrapes and wines for ihei'r SILVIA GUIDONI technological, nutrih'onal and taxonomic effecti. Dipartimento ColtureArboree, Università degliStudi diTorino - Vìa L Da Vìnci 44 - 10095 Grugllasco-To - Italia Pardcular importance bave the anthocyanins wbich concentrations are only related togenet/c ANNASCHNEIDER factors. Then the aim ofthis work was tostudy Istituto Virologia Vegetale - US Viticoltura • CNR-Va L. OaVinci 44 -10095 Grugllasco-To - Italia theantìiocyanic composition ofancìent grape varieties diffused in North-West Italy, atthe foot of theAIps, and to evaluate theexisting relationi among these vaneties byexamining Ihar phendic profile, vdiich often used for a Indagine taxonomicai approai^. Muitivanated analysis ofresulti highilght some iimilanty between the grape variel'es aiready shown by taxonomy and sul profilo antocianico help toknown better this grapes. -

NEB Newsletter #1
NEB Newsletter #1 Welcome to the first ever newsletter from NEB (Nebbiolo Enthusiasts and Believers). These newsletters will hopefully appear in the future, but probably on an erratic basis. In this newsletter, we share: 1. A brief history of the NEB organization, 2. A report on a visit to the Alto Piemonte and a sharing of some California Nebbiolos with a few of those producers by JaRue (Jim) Manning. Jim is a microbiology professor at UC/Davis, a passionate believer of Italian grape varieties, and is working on a book on the role of Italian varieties in California, 3. A few interesting points on Nebbiolo culled from Jancis Robinson's recent book Wine Grapes, 4. An account of growing Nebbiolo in ElDorado County of the Sierra Foothills by Ken Musso, and 5. A description of my pursuit of the alleged first Nebbiolo grapes brought to the USA to Colorado in the 1880's. NEB4: July 20/Paso Robles Organizational planning is in progress for the convening of NEB4. Brian and Stephy Terrizzi of Giornata Winery in Paso Robles have agreed to host this year's event. The tentative date is Saturday, July 20. Brian envisions a morning technical/tasting session at his new winery, followed by a tasting event open to the public at 15C, a wine bar in Templeton. Additional details will be forthcoming as the event firms up...but mark July 20 on your calendar. A Brief History of NEB As many of you are aware, NEB is a pretty casual/rag-tag group of folks who passionately believe there is a role for the Nebbiolo grape variety in the USofA. -

Redalyc.Revelando El Origen De La Variedad De Vid 'Bonarda' Cultivada En Argentina a Través Del Empleo De
Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias ISSN: 0370-4661 [email protected] Universidad Nacional de Cuyo Argentina de Rosas, María Inés; Agüero, Cecilia B.; Martínez, Liliana Revelando el origen de la variedad de vid ‘Bonarda’ cultivada en Argentina a través del empleo de marcadores moleculares microsatélites Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, vol. XLI, núm. 1, 2009, pp. 177-187 Universidad Nacional de Cuyo Mendoza, Argentina Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=382837644001 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto IdentidadRev. FCA deUNCuyo. vid 'Bonarda Tomo XLI.Argentina' N° 1. Añoa través 2009. de 177-187. marcadores moleculares microsatélites Revelando el origen de la variedad de vid ‘Bonarda’ cultivada en Argentina a través del empleo de marcadores moleculares microsatélites 1 Unraveling the origin of the cultivar ‘Bonarda’ in Argentina using mi- crosatellite molecular markers María Inés de Rosas 2 Cecilia B. Agüero 2, 3 Liliana Martínez 2 Originales: Recepción: 18/02/2009 - Aceptación: 19/05/2009 RESUMEN ABSTRACT ‘Bonarda’ es una variedad de vid que 'Bonarda' is the second most cultivated en Argentina se cultiva principalmente en las red variety in Argentina, mainly in the provin- provincias de Mendoza y San Juan, repre- ces of Mendoza and San Juan. In the past few senta el segundo cepaje tinto en superficie years it has been valued for its great potential nacional cultivada y es considerada con for the production of high quality wines. -

Indagine Sul Profilo Antocianico
\ VINO VINCENZO CERBI • LUCAROLLE - GIUSEPPE ZEPPA SUMMARY Dipartimentodi Valorizzazione e Protezionedelle Risorse Agroforestali (DiVaPRA) - Università degli Sludi di Torino- Via L da Vinci 44 -10095 Grugliasco - To- Italia Phenoiic compounds are very important components of grapes and wines for their SILVIA GUIDONI technological, nutritional and taxonomic etfects. DipartimentoColtureArboree, Università degli Studi di Torino- Particular importance have the anthocyanins Via L. Da Vinci 44 -10095 Grugliasco - To - Italia which concentrations are only related logenetic ANNASCHNEIDER factors. Then the aim ofthis work was tostudy Istituto Virologia Vegetale - US Viticoltura - CNR - Via L DaVinci 44 -10095 Grugliasco - To- Italia the anthocyanic compositìon of ancient grape varietles diffused in North-West Italy, atthe foot of the AIps, and toevaluate the existing relations among these varieties by examining their phenoiic profile, which often used for a Indagine taxonomical approach. Multivariated analysis of resuits highiight some similarity between the grape varieties aiready shown by taxonomy and sul profilo antocianico help toknown better this grapes. di vitigni autoctoni SOMMARIO Le sostanze polifenoliche costituiscono, dal punto piemontesi di vista tecnologico, alimentare e tassonomico uno dei principali componenti dell'uva edel vino. Di particole importanza soprattutto ai fini tassonomici sono le antocianidine, una frazione delle sostanze polifenoliche, icui rapporti percentuali risultano essere funzione esclusiva di fattori genetici. -

Torino DOC 2010
TORINO DOC Selezione enologica della Camera di commercio di Torino Oenological selection of the Torino Chamber of commerce Sélection oenologique de la Chambre de commerce de Torino 2010 ® In collaborazione con con il supporto di Introduzione 4 Piccoli accorgimenti LA PROVINCIA DI TORINO Foreword per gustare al meglio il vino 20 VITIVINICOLA 41 Introduction A few tips to bring out the best from wine La selezione enologica 7 Quelques petites astuces pour... Wine-making in the province of Torino The Oenological Selection mieux apprécier le vin La province de Torino viti-vinicole La sélection oenologique Conservazione 21 I Consorzi di Tutela Vini DOC LA QUALITÀ NEL VINO 11 Conservation della provincia di Torino Conservation e la Federazione Alto Piemonte 45 The quality of wine Associations for the protection of DOC La qualité dans le vin Preparazione, servizio e degustazione 22 wines of the province of Torino and Northern Preparation, serving and tasting Piedmont Federation Laboratorio Chimico Préparation, service et dégustation Les Syndicats de Sauvegarde Vins DOC (AOC) Camera Commercio Torino 12 de la province de Torino et la Fédération A proposito dei bicchieri 28 Alto Piemonte Turin Chamber Commerce About stemware Chemical Laboratory À propos des verres I vini DOC della provincia di Torino 49 Laboratoire Chimique DOC wines from the province of Torino Chambre Commerce Torino Abbinamenti e successioni 30 Les vins DOC (AOC) de la province de Torino Food pairings and course orders Le analisi del vino 15 Accords et successions Enoteca Regionale -

Paniere Dei Prodotti Tipici Della Provincia Di Torino
T y p i c a l P r o d u c t s I P r o d o t t i 3 1 0 2 - 2 2 0 1 1 0 2 2 - 2013 I Ristoranti e i Negozi Restaurants and Shops I.P. 20 . Plaisentif 21 . Saras del Fen 21 . Toma ‘d Trausela 22 . Toma di Lanzo Salumi - Carne / Salami - Meat : 22 . Mustardela 23 . Salame di Giora di Carmagnola 23 . Salame di Turgia 24 . Salampatata del Canavese Pesce / Fish : 24 . Tinca Gobba Dorata del Pianalto Il territorio che comprende i 315 The territory that includes the 315 di Poirino / Golden humpbacked Comuni della Provincia di Torino municipalities that make up the Province Tench of Poirino Plain Indice / Index è una composizione ideale che unisce of Turin is a perfect mosaic rich in natural Prodotti da forno / Bakery products: bellezze naturali, tradizioni millenarie, beauty, thousand year-old traditions, Pagina / Page 25 . Antichi Mais Piemontesi / Corn cultivation luoghi di interesse storico e places of historical and architectural 03 . Presentazione / Introduction 25 . Grissino Rubatà del Chierese / architettonico, ma anche un ampio interest and a wide range of traditional 04 . Il Territorio della Provincia di Torino e Rubatà long bread stick of Chieri area e variegato patrimonio di tipicità local foods and gastronomic excellences. il Paniere dei Prodotti Tipici / The territory 26 . Grissino stirato Torinese / agro-alimentari e di eccellenze del To create an ever-more tourist-friendly of the Province of Turin and the “Basket” Turin flattened bread-stick gusto. La Provincia di Torino, per far environment in its art towns and of typical products 26 . -

The Other Whites & Reds from Piemonte
1-6-2021 Workshop Piëmonte Fred F.A. Nijhuis Your Favorite Dutch Wine Writer I Vini del Piemonte Ambassador i.s.m. Nederlands Wijngilde Afdeling Utrecht Online 31 mei 2021 Workshop Piemonte NWG ©Fred F.A. Nijhuis 2021 1 Workshop Piëmonte NWG Workshop Piemonte NWG ©Fred F.A. Nijhuis 2021 2 Workshop Piemonte NWG ©FFA Nijhuis 2021 1 1-6-2021 Workshop Piemonte NWG ©Fred F.A. Nijhuis 2021 3 Workshop Piëmonte NWG • Italië : 301.338 km²; inwoners 60,4 miljoen • Piëmonte : 25.400 km²; inwoners 4,4 miljoen • Nederland : 41.543 km²; inwoners 17,3 miljoen • Wijngaardareaal wereld : 7.397.000 ha (2019) • Wijngaardareaal Italië : 707.000 ha (2019) • Wijngaardareaal Piëmonte : 46.000 ha (2019) • Wijnproductie wereldwijd : 258.000.000 hl (2020) • Wijnproductie Italië : 49.225.000 hl (2019 - 42% DOP-status) • Wijnproductie Piëmonte : 2.569.000 hl (2019 - 94% DOP-status) • Qua productie Piëmonte op de 7e plaats in Italië • Circa 63% totale productie Piëmonte is rood (incl. rosé) Workshop Piemonte NWG ©Fred F.A. Nijhuis 2021 4 Workshop Piemonte NWG ©FFA Nijhuis 2021 2 1-6-2021 Workshop Piëmonte NWG Geschiedenis wijnbouw Piëmonte in het kort: • Romeinen maken wijn in de regio. • 13e eeuw: Eerste vermelding Nebbiolo, hoewel al veel eerder in de regio bekend. • 16e eeuw: Eerste vermelding Dosetto/Dolcetto. • 1600: Eerste vermeling Barbera. • 1751: Eerste vermelding wijngaard/cru/MGA: Cannubi. • 19e eeuw: Benso di Cavour start Risorgimento; gebruikt Franse netwerk voor verbeteren wijn. • 19e eeuw: Francesco Staglieno grondlegger nieuwe stijl Barolo; stil ipv zoet en sprankelend. • 19e eeuw: Federico Martinotti ontwikkelt methode 2e gisting in tanks (Charmat).