Etica Professionale E Responsabilità Civile
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Zerohack Zer0pwn Youranonnews Yevgeniy Anikin Yes Men
Zerohack Zer0Pwn YourAnonNews Yevgeniy Anikin Yes Men YamaTough Xtreme x-Leader xenu xen0nymous www.oem.com.mx www.nytimes.com/pages/world/asia/index.html www.informador.com.mx www.futuregov.asia www.cronica.com.mx www.asiapacificsecuritymagazine.com Worm Wolfy Withdrawal* WillyFoReal Wikileaks IRC 88.80.16.13/9999 IRC Channel WikiLeaks WiiSpellWhy whitekidney Wells Fargo weed WallRoad w0rmware Vulnerability Vladislav Khorokhorin Visa Inc. Virus Virgin Islands "Viewpointe Archive Services, LLC" Versability Verizon Venezuela Vegas Vatican City USB US Trust US Bankcorp Uruguay Uran0n unusedcrayon United Kingdom UnicormCr3w unfittoprint unelected.org UndisclosedAnon Ukraine UGNazi ua_musti_1905 U.S. Bankcorp TYLER Turkey trosec113 Trojan Horse Trojan Trivette TriCk Tribalzer0 Transnistria transaction Traitor traffic court Tradecraft Trade Secrets "Total System Services, Inc." Topiary Top Secret Tom Stracener TibitXimer Thumb Drive Thomson Reuters TheWikiBoat thepeoplescause the_infecti0n The Unknowns The UnderTaker The Syrian electronic army The Jokerhack Thailand ThaCosmo th3j35t3r testeux1 TEST Telecomix TehWongZ Teddy Bigglesworth TeaMp0isoN TeamHav0k Team Ghost Shell Team Digi7al tdl4 taxes TARP tango down Tampa Tammy Shapiro Taiwan Tabu T0x1c t0wN T.A.R.P. Syrian Electronic Army syndiv Symantec Corporation Switzerland Swingers Club SWIFT Sweden Swan SwaggSec Swagg Security "SunGard Data Systems, Inc." Stuxnet Stringer Streamroller Stole* Sterlok SteelAnne st0rm SQLi Spyware Spying Spydevilz Spy Camera Sposed Spook Spoofing Splendide -

Magisterarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES Magisterarbeit Titel der Magisterarbeit La Cosa Nostra – Struktur, Funktionen und mediale Berichterstattung im Zuge des Maxiprozesses von Palermo (10.2.1986 – 17.12.1987) Verfasser Fabio Arienti BA angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 236 349 Studienrichtung lt. Studienblatt: Italienisch Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Robert Tanzmeister Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis S.1 1. Fragestellung S.3 2. Methode S.6 3. Aktueller Forschungsstand S.9 4. Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte S.12 4.1. Etymologie S.13 4.2. Glossar S.13 4.3. Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert S.16 4.3.1. Die Einigung Italiens S.17 4.3.2. Implementierung einer lokalen Verwaltung S.19 4.3.3. Der Erste Weltkrieg S.22 4.3.4. Faschismus S.22 4.3.5. Die Nachkriegsjahre S.23 4.3.6. Wirtschaftlicher Aufschwung S.26 4.3.7. Der Drogenhandel S.27 4.3.8. Änderungen in der öffentlichen Wahrnehmung S.29 4.3.9. Wiederbelebung und zweite Phase des Drogenhandels S.31 4.3.10. Die Machtergreifung der Mafia aus Corleone S.33 4.3.11. Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino und der Antimafia Pool S.34 4.3.12. Revolutionierung der politischen Landschaft Italiens S.36 5. Struktur und soziale Funktionen S.38 5.1. Ihre Struktur nach Giovanni Falcone S.38 5.2. Ihre Funktionen nach Raimondo Catanzaro S.46 5.2.1. Die Mafia als Vermittler zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen S.48 1 5.2.2. -

Emeequis 11-06-2012.Pdf
Sicilia se rebela contra la mafia Hace unos días se cumplieron 20 años de los asesinatos de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, los jueces que sentaron a la mafia de Italia en el banquillo y condenaron a cientos de jefes y sicarios a varias cadenas perpetuas. Los atentados en venganza por los juicios y las posteriores manifestaciones masivas desper- taron la conciencia de una generación de adolescentes sicilianos que ahora encabezan los movimientos antimafia: en las ciuda- des, cientos de comercios se niegan a pagar extorsiones y colo- can la calcomanía con la leyenda Addio pizzo (Adiós al chantaje); en el campo, los agricultores jóvenes cultivan tierras confiscadas a los capos y venden pasta, vino, aceite de olivo, por ejemplo, con una característica única: son productos “libres de mafia”. Por Ander Izagirre Fotografías: Asociación Addio Pizzo FOTOGRAFÍA: LIBERA TERRA Palermo, Italia.- Libero Grassi, dueño de una Palermo despierta fábrica de pijamas y calzoncillos, publicó esta carta en el Giornale di Sicilia: “Queridos extor- Doce años después del asesinato de Grassi, una sionadores: pueden ahorrarse las llamadas te- mañana las calles de Palermo aparecieron em- lefónicas amenazantes y los gastos en bombas papeladas con miles de calcomanías que decían: y balas, porque no vamos a pagar el chantaje y “Un pueblo que paga el pizzo es un pueblo sin estamos bajo protección policial. He construi- dignidad”. Una periodista preguntó a Maisano do esta fábrica con mis manos, es el trabajo de si conocía a los autores. “No, yo no los conocía, mi vida, y no pienso cerrarla”. pero le dije a la periodista que para mí era como Era el 10 de enero de 1991. -

1 Dipartimento Di Scienze Politiche Cattedra Storia Dei Partiti E Dei
1 Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra Storia dei partiti e dei movimenti politici Salvatore Riina: vita criminale e organizzazione mafiosa RELATORE Prof. Andrea Ungari CANDIDATO Priscilla Roscioli Matr. 073562 ANNO ACCADEMICO 2015-2016 2 SOMMARIO Introduzione ......................................................................................................................................... 3 Cosa si intende per il termine “Mafia”? ............................................................................................... 5 ANALISI BIOGRAFICA .................................................................................................................... 8 Infanzia ................................................................................................................................................ 8 Adolescenza: i primi reati .................................................................................................................... 9 Guerra tra Corleonesi ....................................................................................................................... 10 Verso Palermo ................................................................................................................................... 11 Struttura e organizzazione di Cosa Nostra ................................................................................................. 12 Il “sacco di Palermo” ................................................................................................................................ -
Handbuch (Pdf)
TAT/ORT (UN)HEIMLICHE SPUREN DER MAFIA TOMMASO BONAVENTURA ALESSANDRO IMBRIACO FABIO SEVERO 27.04.–20.07.2014 INHALTSVERZEICHNIS Seite 04-05 Eine Geografie des Abseits. Fabio Severo Seite 06-28 Bildlegenden Seite 29-43 Ergänzende Informationen Seite 44-45 Über das Projekt und biografische Angaben Seite 46 Rahmenprogramm zur Ausstellung Seite 47 Filmprogramm zur Ausstellung Seite 48-49 Allgemeine Informationen Seite 50 Impressum Zu den orange markierten Namen von Personen und Mafia- organisationen finden Sie von Seite 29 bis 43 ergänzende Informationen. 3 EINE GEOGRAPHIE DES ABSEITS „So bestand die Schwierigkeit, der Landschaft gegenüber einen Standpunkt einzunehmen, als sei sie ein unbekannter Ort, ausgegrenzt und ausgeschlossen“ schrieb Carlo Arturo Quintavalle im Vorwort, „es geht um eine Suche nach dem Italien des Abseits, der Vieldeutigkeit, des Scheins, der Doppelbödigkeit, nach dem im Grunde ausgeschlossenen Italien, nach dem Italien, das aber auch das einzige ist, dass wir kennen, Die Darstellung der Mafia von heute bringt die Frage mit sich, welche verstehen, leben, weil es das einzige ist, das wir mit unserer gespaltenen Vorstellung man sich von einem Phänomen machen soll, das sich im Existenz in Beziehung setzen.“ Lauf der Zeit und nach Jahrzehnten der blutigen Auseinandersetzung mit dem Staat gewandelt hat. Das Szenario hat sich grundlegend TAT/ORT – Corpi di Reato erinnert zu Beginn an die Lektüre von geändert: Seit Jahren erforscht man die Veränderungen der Strategien „Viaggio in Italia“, wie es Quintavalle auf den Punkt bringt: Sich auf die in den kriminellen Organisationen und spricht heute von einer Mafia, die Spuren der Mafiaorganisationen in unserem Land zu begeben bedeutet, kaum noch tötet. -

Mafia: Der Pate Wohnt Hier Nicht Mehr | Reisen | ZEIT
11/08/2010 Mafia: Der Pate wohnt hier nicht meh… REISEN MAFIA Der Pate wohnt hier nicht mehr In Sizilien wächst der Widerstand gegen die Mafia. Alte Mafia-Häuser und -Ländereien werden in touristische Einrichtungen verwandelt. Die Einnahmen gehen an Mafia- Gegner. VON Helmut Luther 10.6.2010 - 14:36 Uhr © Matzge / photocase.com Auf Sizilien versuchen Initiativen, die Mafia mit Tourismus zu bekämpfen Es ist nicht einfach, Peppino Impastatos Wohnhaus zu finden. Dabei ist Cinisi, sein Heimatort, eine knappe Autostunde westlich von Palermo entfernt. Ein winziges Nest, das sich zwischen der Küste und dem bedrohlich aufragenden Monte Longa hinduckt. Dessen nackte Kalkwände geben noch spätabends die gespeicherte Hitze der glühenden Sonnenstrahlen ab. Auf den steinigen, nicht mehr bearbeiteten Äckern rund um das Dorf leuchtet roter Klatschmohn. Über den knorrigen Olivenbäumen liegt ein silbriges Licht, bis zum Küstenstreifen erstreckt sich das helle Grün und löst sich vor dem azurblauen Meer in eine flirrende Unschärfe auf. In diesem verschlafen wirkenden Flecken mit ein paar Häuserzeilen im Zentrum und hässlichen Wohnsilos an den ausgefransten Rändern, weist einem kein Schild den Weg zu Peppino Impastatos Haus. Darauf angesprochen, geben die Einheimischen vor, den Namen Impastato nie gehört zu haben. "Impossato, wie?", zeit.de/reisen/…/mafia-reise-italien-2… 1/6 11/08/2010 Mafia: Der Pate wohnt hier nicht meh… sagen die Alten an der Piazza Garibaldi und ziehen ihre Schiebermützen tief über die Augen herunter. Für sie ist das Gespräch mit den Leuten von auswärts nun beendet. Schweigen, Achselzucken auch bei den Jungen, eine drückende, geisterhafte Stille liegt über dem Ort. Die abweisende Haltung der Dörfler ist wahrscheinlich kein Zufall. -

Gabellotti E Notabili Nella Sicilia Dell'interno
Gabellotti e notabili nella Sicilia dell’interno di Rosario Mangiameli Nel settembre 1944 Villalba e don Calogero cenni dedicati alla presenza della mafia al di Vizzini assursero alla cronaca politica nazio fuori dell’area e degli interessi latifondistici nale per la furibonda sparatoria con cui ven in questo periodo. Nei centri costieri l’attivi ne accolto un comizio di Li Causi e Pantaleo- tà delinquenziale sembra essere piuttosto ne. Per l’importanza dei personaggi coinvolti Vintrallazzo, simbolo del degrado della vita dall’una e dall’altra parte la vicenda suscitò urbana, e che trova una parvenza di organiz subito un grande interesse e venne considera zazione nel collegamento con il contrabban ta emblematica manifestazione del potere do praticato alPinterno, nelle aree di produ mafioso, della sua tradizionale persistenza zione granaria; nessun blocco, d’altronde, si all’interno dell’isola. E tuttavia gli aspetti trova alle porte di Palermo dove in passato più classicamente connessi all’immagine del erano forti e agguerrite nel monopolizzare il la mafia: la contesa intorno al latifondo, le controllo dei mercati urbani, numerose co solidarietà primarie, l’omertà, la reazione di sche. A spadroneggiare nei centri urbani, e un mondo chiuso e primitivo contro l’intro nella stessa Palermo, sono i pastori e i bandi missione esterna, appaiono fortemente in ti che dai loro rifugi sulle Madonie vengono trecciati con una attitudine politica più evo attratti dalla lucrosa prospettiva del seque luta che li utilizza e se ne veste. stro di persona e del ricatto, infliggendo co La mafia appariva agli osservatori del se centi umiliazioni e spargendo il terrore. -

Mafia In...Galera L’ITALIA DEGLI ONESTI ESULTA, ASSICURATI NELLE PATRIE GALERE BOSS STORICI, “CAPIZONA” EM ERGENTI, POLITICI E “NOTABILI”
Venerdì 3 settembre 1982 ANNO VII- n. 16 Marzo 2009 “La mafia [email protected] non è affatto Sul luogo dell’eccidio, invincibile, è un anonimo cittadino un fatto lascia un cartello affis- umano e so al muro. Poche pa- come tutti i role che in breve fanno fatti umani il giro del mondo: “Qui ha un inizio e avrà anche una fine. è morta la speranza Gioirnalilno sc olasbtico edito daall‘I.C. —Cnarlo Albertod Dalla Chiesia“dit Prata oP.U. e sezr. ass.ta dei S.Paolina Piuttosto bisogna rendersi conto dei siciliani onesti”. che è un fenomeno terribilmente Redazione e Amministrazione Prata P.U. via M unicipio, 1 - 0825/952014 - fax 0825/961814 serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo DIRETTORE RESPONSABILE: DOTT.SSA SILVIA GAETANA MAURIELLO-REDATTORE CAPO:PROF.FLAVIO PICARIELLO da inermi cittadini ma impegnan- do in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni”(Giovanni [email protected] www.Scuolaw e b a m b i e n t e . i t www.icprata.it www.alboscuole.it Falcone) continua a pag. 5 Bliz nella notte in tutto il Paese delle “teste di cuoio” di Carabinieri e Polizia, decapitata la cupola di Cosa Nostra mafia in...galera L’ITALIA DEGLI ONESTI ESULTA, ASSICURATI NELLE PATRIE GALERE BOSS STORICI, “CAPIZONA” EM ERGENTI, POLITICI E “NOTABILI” VIM IN A LE Costituzione - Art. 2. La Repubblica rico- COMUNICATO STAMPA nosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, Decine di centinaia di carabinieri e di poliziotti sia come singolo sia nelle formazioni sociali dei comandi regionale e provinciali, dalle prime ove si svolge la sua personalità, e richiede ore dell‘alba, hanno in corso una operazione - l’adempimento dei doveri inderogabili di soli- denominata “Annozero” - per la cattura di darietà politica, economica e sociale. -
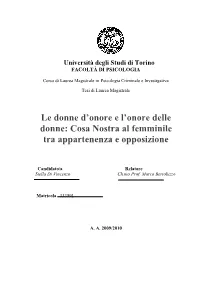
Le Donne D'onore E L'onore Delle Donne
Università degli Studi di Torino FACOLTÀ DI PSICOLOGIA Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Criminale e Investigativa Tesi di Laurea Magistrale Le donne d’onore e l’onore delle donne: Cosa Nostra al femminile tra appartenenza e opposizione Candidato/a Relatore Stella Di Vincenzo Ch.mo Prof. Marco Bertoluzzo Matricola 333591 A. A. 2009/2010 A mio Nonno A Maria Aurora Gueli Ai miei insostituibili genitori A me, Stella… INDICE INTRODUZIONE p.6 CAPITOLO I Cosa Nostra 1.1 Genesi e rappresentazione sociale: tra realtà e apparenza p.10 1.2 L’istituzione della legge Rognoni-La Torre p.16 1.2.1 I contenuti dell’art 416 bis p.20 1.3 La sospensione delle ordinarie regole di trattamento: l’art. 41 bis o.p. p.26 1.3.1 Analisi dei contenuti applicativi del regime di “carcere duro” p.30 CAPITOLO II Donna o Madre 2.1 Il ruolo materno nell’universo mafioso p. 36 2.1.1 Le madri “modello” p.42 2.1.2 Gli angeli vendicatori p.46 2.2 Famiglia e famiglia: un possibile conflitto p.51 2.3 Gli “intoccabili”: donne e bambini uccisi dalla mafia p.59 CAPITOLO III L’altra metà dalla mafia 3.1 La criminologia femminile e lo stereotipo culturale p.68 3 3.1.1Lo stereotipo della donna dentro Cosa Nostra p.73 3.2 L’impunità della donna di mafia: il paternalismo giudiziario p.76 3.3 Le attività criminali della donna di mafia. Droga e prostituzione p.86 3.3.1 Da messaggere a manager p.93 3.3.2 Le funzioni direttive p.99 3.4 La decostruzione dello stereotipo p.105 3.4.1 L’emancipazione femminile all’interno della mafia p.108 CAPITOLO IV Le donne del disonore 4.1 L’emergenza pentiti: supporto delle donne al pentimento p.112 4.1.1 L’opposizione al pentimento p.117 4.2 Le collaboratrici di giustizia p.129 CAPITOLO V L’onore delle donne 5.1 Le testimoni di giustizia p.158 5.1.1 Il modello emancipativo p.166 5.1.2 Le donne si costituiscono parti civili p.174 5.1.3 Commenti conclusivi p.190 5.2 Le Associazioni Antimafia p.194 CAPITOLO VI 6.1. -

Parte Seconda. Relazione Del Senatore Pisanò
Senato della Repubblica — 99Ì •— Camera dei Deputati LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI PARTE SECONDA (Relazione del senatore PISANO) Senato della Repubblica — 993 — Camera dei Deputati LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI MAFIA, POLITICA E POTERI PUBBLICI ATTRAVERSO LA STORIA DI LUCIANO LEGGIO 63. Senato della Repubblica — 995 — Camera dei Deputati LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Nel capitolo quarto della Relazione di I documenti e le testimonianze esistenti maggioranza (« Le ramificazioni territoriali negli archivi della Commissione antimafia della malìa »), dopo avere 'trattato l'evolu- (e che noi citeremo nel corso della nostra zione del fenomeno mafioso in questo do- relazione) portano infatti a collegare il no- poguerra, attraverso una rapida sìntesi della me di Luciano Leggio e ile vicende di cui è vita di Luciano Leggio dall'inizio della sua stato protagonista il dottor Pietro Scaglio- attività criminale fino al/la sua cattura av- ne, Procuratore capo dal/la Repubblica di venuta a Milano ii 16 maggio 1974, si affer- Palermo, assassinato il 5 maggio 1971, al dottor Angelo Vicari, già prefetto di Pa- ma (paragrafo 7): lermo e Capo della polizia dal 1960 al 1973, « Naturalmente sarebbe vano cercare di a Salvatore Lima, già sindaco democristia- individuare le responsabilità personali che no di Palermo, eletto quindi deputato e di- hanno permesso a Leggio di non essere chia- venuto Sottosegretario idi Stato alle finanze mato a rispondere dei suoi crimini con la con ii secondo Governo Andreotti, al ban- necessaria tempestività... ». chiere De Luca, già creatura di Sindona, che, Ebbene, noi non concordiamo con questa attraverso il suo Banco di Milano, ci porta affermazione. -
Proquest Dissertations
Violent Organizations in Contemporary Europe: A Comparison of Mafia and Paramilitary Organizations in Northern Ireland and Sicily By Mike Saunders, B.A. A thesis submitted to The Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Institute of European, Russian, and Eurasian Studies Carleton University Ottawa, Ontario December, 2009 © 2009, M. Saunders Library and Archives Bibliotheque et 1*1 Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 OttawaONK1A0N4 Canada Canada Your file Votre inference ISBN: 978-0-494-64443-0 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-64443-0 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par Nnternet, preter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre imprimes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

Strategie E Forme Della Comunicazione Mafiosa
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN COMUNICAZIONE PUBBLICA E D’IMPRESA LA PAROLA AL PADRINO: STRATEGIE E FORME DELLA COMUNICAZIONE MAFIOSA Tesi di Laurea di: Simona Apollonio Relatore: Prof. Nando Dalla Chiesa Correlatrice: Prof.ssa Maria Luisa Leonini Anno Accademico: 2011/2012 INDICE PARTE I .................................................................................................. 8 La comunicazione interna alla mafia ................................................... 8 CAPITOLO I ............................................................................................... 9 Lo stile comunicativo degli uomini d’onore ........................................... 9 1.1 Dalla comunicazione orale all’uso della tecnologia ................................ 9 1.2 Bernardo Provenzano ............................................................................... 14 1.2.1 Un boss “sgrammaticato”… .............................................................. 14 1.2.2 …e prudente ........................................................................................ 17 1.2.3 I destinatari ......................................................................................... 21 1.3 Le donne di Cosa Nostra .......................................................................... 27 1.4 L’uso dei soprannomi ............................................................................... 29 1.5 Impliciti, metafore e allegorie .................................................................