Il Testo Completo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Foglio Di Sala
Spettacolo teatrale “PANNI SPORCHI. COSE DA FIMMINI” Versione ridotta con Armanda Borghetti, Beatrice Carra, Martina Gabrieli, Licia Gambarelli, Giulia Canali, Barbara Mazzieri, Alessandra Pizzoni, , Franca Tragni, Maura Zappacosta. una produzione dell’Associazione di Promozione Sociale Zonafranca Parma adattamento drammaturgico e regia Franca Tragni realizzata con i patrocini della Provincia di Parma, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Fontanellato Di mafia si muore, ma anche il silenzio uccide. Un mondo sommerso, quello delle organizzazioni criminali, raccontato con uno sguardo al femminile dalle mogli, dalle madri, dalle figlie di ieri e di oggi che nel contesto mafioso sono nate, vissute, che dalle mafie sono state colpite o rese complici, che per le mafie hanno perso mariti e figli o che a causa delle mafie hanno rinunciato a essere libere, alla ricerca della verità che vive. Il reading è dedicato a ritratti di donna, dalla prima collaboratrice di giustizia Serafina Battaglia a Ninetta Bagarella moglie innamorata del boss Totò Riina e Rita Atria, morta suicida dopo l’uccisione di Paolo Borsellino. Il mondo femminile è lo spunto per la ricerca di significati, per comprendere gli aspetti culturali e più intimi che vengono messi in gioco nelle vicende di mafie, per capire, prima che per giudicare, “come” i figli crescano con la mentalità dei padri e “come” le mogli, le madri, le figlie, le sorelle - custodi della casa e della famiglia – diventino figure fondamentali, anche se nell’ombra, nel tessere le trame di questi mondi sommersi, sempre più lontani dagli stereotipi delle “mafie del sud” e sempre più fatti che ci riguardano da vicino, fino ad arrivare sulle nostre tavole. -

A Cura Di Antonia Cava 1 3 a Cura Di Antonia Cava 8 1
11381.1_cop 1381.1.13 17/02/20 16:36 Pagina 1 1 A cura di Antonia Cava 1 3 A cura di Antonia Cava 8 1 . IL GIOCO DEL KILLER 1 Questo volume raccoglie i contributi di studiosi provenienti da diversi ambiti disciplinari, A . Il gioco del killer accomunati dall’aver preso parte a un’iniziativa di formazione all’avanguardia ideata da C A Domenico Carzo: il Master “Esperto in intervento sociale minori e mafie”. I saggi proposti V analizzano le culture mafiose e la devianza minorile generando un serrato confronto tra dif - A Culture mafiose e minori ( ferenti prospettive teoriche e di ricerca. Una riflessione interdisciplinare che non solo inter - A preta il tema dei “figli di mafia”, ma esplora anche strategie che possano offrire un’alterna - C U tiva sociale, culturale e affettiva. R A D I Antonia Cava è professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi ) I presso il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali L dell’Università degli Studi di Messina. Insegna Industria culturale e media studies e Sociologia G I della comunicazione e coordina il Master “Esperto in intervento sociale minori e mafie”. O Svolge attività di ricerca su pubblici televisivi, consumi culturali e immaginario mediale. Tra le C O sue pubblicazioni: # Foodpeople. Itinerari mediali e paesaggi gastronomici contemporanei D (Aracne 2018) e Noir Tv. La cronaca nera diventa format televisivo (FrancoAngeli 2013). E L K I L L E R SScienze de ll aCcomunicazione Collana diretta da Marino Livolsi Franc oAngeli ISBN 978-88-917-7285-5 -

Mediterranea
UDI Catania – supplemento novembre 2011 Mediterranea Nei giorni scorsi si è tenuto a Palermo un seminario, con grande partecipazione femminile, sul tema “DONNE DI MAFIA”, organizzato dall’Università di Palermo e da Libera. La traccia per la discussione è stato lo studio pubblicato sul tema dal n. 67 della rivista MERIDIANA. Per il grande valore civile e l’affidabilità scientifica delle analisi e delle proposte al centro dell’incontro (non pubblicizzato come si dovrebbe), riteniamo che il suo valore vada riproposto e diffuso il più possibile, anche se a posteriori, tra molte di noi che non erano a Palermo. Per questo, per rilanciare la discussione e la partecipazione sui temi trattati e sulla loro attualizzazione riportiamo due articoli sul convegno di Antonella Lombardo (pubblicati sul giornale del Centro Studi Pio La Torre ‐ Sud’Europa) che hanno il pregio di tracciare alcuni dei punti salienti e quindi, speriamo, di invogliare alla ricerca. L’identikit dei ‘boss in gonnella’ Le ‘signore della mafia' vivono una particolare forma di 'emancipazione' femminile: sono donne escluse dall'affiliazione eppure protagoniste della gestione economica della criminalità organizzata. Subordinate ai loro uomini per statuto interno mafioso, ma non sottomesse. Sono donne che accettano gli assassini dei figli e dei congiunti e congelano le loro emozioni per salvare e far coincidere la famiglia parentale e quella criminale. Ai tanti volti di camorriste o donne delle 'ndrine’ talvolta succubi, altre protagoniste, è dedicato il numero 67 della rivista di storia e scienze sociali Meridiana, pubblicata dall'istituto Imes e presentato a Palermo in un seminario organizzato dall'Università e dall'associazione Libera. -

Il Volantino Europeo N°46 Octobre 2014 Bulletin Internautique De L’Association Piotr-Tchaadaev
Il Volantino Europeo n°46 Octobre 2014 Bulletin internautique de l’Association Piotr-Tchaadaev Jamais aucun avion ne remplira le ciel. Nous étions pour ce numéro à la recherche d’une image linéaire, sobre, épurée, qui aurait pu provenir de la terre, de l’eau ou du feu. Elle nous vient du ciel, toute connotation religieuse mise à part. Du ciel bleu strié dans tous les sens par les gaz d’échappement des avions, spectacle que cet automne chaud et lumineux nous aura permis de contempler à loisir. Automne estival, un thermomètre extérieur indiquait 33°C ce jour (19.10.2014) à Nice vers 12h30, après l’été automnal de juillet dernier. Faut-il s’en inquiéter ? Nous n’allons certainement pas débattre ici – en toute incompétence - du changement climatique. Mais revenir sur une phrase de l’éditorial du numéro d’été (n°45). En écrivant à l’époque : « Quitte à paraître cynique, sans cœur et sans pitié, on ajoutera froidement : qui dit-mieux ? », nous n’étions pas naïf au point d’espérer conjurer par ces mots d’autres drames et d’autres catastrophes. L’actualité s’en est amplement chargée, ajoutant l’horreur à l’horreur. Après des journalistes et des humanitaires au Moyen-Orient, c’est un guide de montagne de la région de Nice, Hervé Gourdel, qui a été décapité en Algérie le 24 septembre 2014, par une organisation terroriste qui l’avait pris en otage pendant qu’il faisait des repérages pour un prochain accompagnement. Au-delà de la marche silencieuse qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Nice le 28 septembre, nous avons été surpris par le silence qui a suivi cet assassinat, par exemple dans le monde du travail ou dans les transports en commun, comme si rien ne pouvait plus être dit sur ce qui s’était passé. -

1- Canzone (Gianni Morandi
23 MAGGIO 2010 - PIAZZA VERGA COPIONE (Musica o Accordi per richiamare l’attenzione) SALUTI DI SALVATORE RESCA VIDEO: “FUNERALE FALCONE” CANZONE: “DORMI E VOLA” (LAUTARI) RECITAZIONE: {GENNARO} Sono Antonio Montinaro, capo della scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992: Io ho sempre definito che chiunque fa questa attività deve avere la capacità di scegliere tra la paura e la vigliaccheria. La paura è qualcosa che tutti abbiamo: chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce, e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, ma non sono un vigliacco. Nella mia posizione la paura è lasciare, magari, i bambini soli. Per l'uomo sposato la paura si gestisce in virtù della propria famiglia, si ha paura di lasciarli soli, si ha paura di non avere la capacità di morire per una ragione valida, certamente in Italia morire perché si è poliziotti...non so fino a che punto valga la pena, e l'abbiamo visto, in molti casi ci si dimentica quasi completamente delle famiglie dei poliziotti uccisi. CANZONE: “MALARAZZA” (D. MODUGNO) SCUOLA I.T.G COLAJANNI DI RIPOSTO (recitazione) CANZONE: “UP PATRIOTS TO ARMS” (F. BATTIATO) RECITAZIONE: {GRAZIA} Dicono di me che sono stata la prima donna d'onore. La prima donna di mafia a pentirsi. I giornali si sono sbizzarriti. "Il pentimento della donna-boss", "Giusy Vitale dirigeva la potente e spietata cosca di Partinico", "Lady mafia, che volle essere più potente dei boss", "La boss in gonnella." Loro, i miei fratelli che mi vorrebbero vedere morta, dicono che Giusy Vitale ormai è "nuddu ammiscatu cu nenti"- ma stu nenti li ha messi in ginocchio e "l'ha fatto solo perché i suoi figli non fossero costretti a vivere come lei", a subire una vita come la sua, in cui l'amore di casa, quello che respiri in famiglia, diventa una trappola mortale. -

Le Vittime Della Mafia
LE VITTIME DELLA MAFIA 1861 Giuseppe Montalbano è un medico, fervente mazziniano, e partecipa alla rivoluzione palermitana del 1848. Dopo lo sbarco a Marsala di Giuseppe Garibaldi, si unisce ai Mille, e per questo verrà poi eletto consigliere comunale e poi provinciale. Viene ucciso la sera del 3 marzo 1861 davanti casa sua, a Santa Margherita Belice (Ag), con tre fucilate alle spalle. Montalbano paga così l’aver guidato i contadini che rivendicano tre feudi che dovrebbero essere del Comune, usurpati invece dalla principessa Giovanna Filangieri. Alla sua morte esplode la rabbia popolare e viene preso d’assalto il Circolo dei Civili e messo sotto assedio per 2 giorni il municipio della città. La rivolta viene infine sedata e sull’omicidio Montalbano non si fanno indagini. 1863 Giovanni Corrao è un operaio del porto di Palermo, un calafataro, cioè colui che con il catrame rende impermeabili le imbarcazioni di legno. Ma Corrao è soprattutto un antiborbonico. Nel 1860 si unisce ai Mille e nel corso della campagna viene nominato generale dallo stesso Garibaldi. Finita l’impresa dei Mille, Corrao entra a far parte dell’esercito sabaudo con il grado di colonnello, ma nel 1862 lascia tutto per seguire nuovamente Garibaldi nell’impresa della conquista di Roma, fino alla sconfitta sull’Aspromonte. Quando torna a Palermo, viene assassinato dalla mafia il 3 agosto 1863. Il delitto resta impunito, ma negli atti dell’indagine si usa per la prima volta il termine “mafia”. 1874 Emanuele Attardi è un bambino quando, l’8 novembre 1874, viene ucciso da un colpo di fucile che lo raggiunge mentre passeggia in compagnia del padre, Gaspare Attardi, il vero obiettivo dell’agguato. -

I Padrini Del Ponte. Affari Di Mafia Sullo Stretto Di Messina
Tempi moderni I Padrini del Ponte Affari di mafia sullo stretto di Messina di Antonio Mazzeo Per favorire la libera circolazione della cultura, è consentita la riproduzione di questo volume, parziale o totale, a uso personale dei lettori purché non a scopo commerciale. © 2010 Edizioni Alegre - Soc. cooperativa giornalistica Circonvallazione Casilina, 72/74 - 00176 Roma e-mail: [email protected] Analisi, notizie e commenti sito: www.edizionialegre.it www.ilmegafonoquotidiano.it Indice Prefazione. Il Ponte e le mafie: uno spaccato di capitalismo reale 7 Solo pizzi e dintorni? 7 L’inchiesta Brooklyn e il contesto mondiale 8 Avvertenza e ringraziamenti 13 Capitolo uno. Brooklyn, la mafia del Ponte 17 Premiata ditta Zappia & soci... 17 «...Il Ponte lo faccio io...» 20 Il segreto d’onore 23 L’odore dei soldi 25 Il Principe Bin d’Arabia 28 Capitolo due. Il clan dei canadesi 31 A Scilla la ’ndrangheta, a Cariddi la mafia 32 Per riscuotere dall’emiro 34 Una holding made in Siculiana 36 Ci vediamo tutti al Reggio Bar 37 L’internazionale degli stupefacenti 40 L’ascesa di don Vito 42 I nuovi manager della coca 45 L’Uomo del Colosseo 48 Capitolo tre. I Signori delle Antille 53 Tra corsari e governatori 56 Le amicizie pericolose di Trinacrialand 58 Come invecchiare all’ombra del Ponte 62 Alla fine arrivò il Pippo d’America 65 Le Terrazze sullo Stretto 68 La guerra per gli appalti 69 Il ponte riemerso di Tourist e Caronte 74 Alla conquista dell’Est 77 Campione dell’undici settembre 81 Grandi mercanti sauditi 86 Kabul-Messina la rotta dei capi dei servizi segreti 89 Moschee, dissalatori, armi.. -

Relations De Genre Dans Les Organisations Mafieuses Italiennes : De L'invisibilite Des Mères Et Épouses À “L'agentivit
Recebido em: 16/04/2016. Aprovado condicionalmente em: 07/02/2018. Aprovação final em: 05/03/2018. RELATIONS DE GENRE DANS LES ORGANISATIONS MAFIEUSES ITALIENNES : DE L’INVISIBILITE DES MÈRES ET ÉPOUSES À “L’AGENTIVITÉ” DES FEMMES.1 GENDER WITHIN ITALIAN MAFIAS’ ORGANISATIONS: FROM THE INVISIBILITY OF MOTHERS AND WIVES TO WOMEN’S AGENCY. RELAÇÕES DE GÊNERO NAS ORGANIZAÇÕES MAFIOSAS ITALIANAS: DA INVISIBILIDADE DAS MÃES E ESPOSAS À “AGENTIVIDADE” DAS MULHERES. RELACIONES DE GÉNERO EN LAS ORGANIZACIONES MAFIOSAS ITALIANAS: DE LA INVISIBILIDAD DE LAS MADRES Y ESPOSAS A LA “AGENTIVIDAD” DE LAS MUJERES. Tiziano Peccia** RESUMÉ : Cette recherche analyse le rôle des femmes dans les organisations mafieuses italiennes. A travers une analyse des « mères » et des « épouses » qui ont joué des rôles hétérogènes au sein des mafias, ce travail rend visible la complexité de ces femmes et de leurs actions dans les interactions inter et intrafamiliales qui caracté- risent leurs vécus. Une attention particulière est dédiée au rôle de la « violence » dans la vie de ces actrices, qui peuvent en être des vic- times autant que des reproductrices directes et/ou indirectes. En utili- sant une approche méthodologique mixte et une étude comparative de la littérature existante ainsi que des données qualitatives originales, cet article met en évidence comment la violence au sein des femmes analysées se décline sous plusieurs formes comme un élément caracté- risé par un forte polymorphisme, complexifiant l’étude de ces agentes dans des contextes sociaux en évolution continue. Mots-clés: Mafia; Genre; Violence; Femmes; Criminalité. 1 Remerciements: J'adresse mes remerciements aux personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette recherche. -

Dead Silent: Life Stories of Girls and Women Killed by the Italian Mafias, 1878-2018 Robin Pickering-Iazzi University of Wisconsin-Milwaukee, [email protected]
University of Wisconsin Milwaukee UWM Digital Commons French, Italian and Comparative Literature Faculty French, Italian and Comparative Literature Books Department 2019 Dead Silent: Life Stories of Girls and Women Killed by the Italian Mafias, 1878-2018 Robin Pickering-Iazzi University of Wisconsin-Milwaukee, [email protected] Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/freita_facbooks Part of the Criminology and Criminal Justice Commons, Italian Language and Literature Commons, and the Women's Studies Commons Recommended Citation Pickering-Iazzi, Robin, "Dead Silent: Life Stories of Girls and Women Killed by the Italian Mafias, 1878-2018" (2019). French, Italian and Comparative Literature Faculty Books. 2. https://dc.uwm.edu/freita_facbooks/2 This Book is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in French, Italian and Comparative Literature Faculty Books by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. DEAD SILENT: Life Stories of Girls and Women Killed by the Italian Mafias, 1878-2018 Robin Pickering-Iazzi Robin Pickering-Iazzi is Professor of Italian and Comparative Literature in the Department of French, Italian, and Comparative Literature at the University of Wisconsin-Milwaukee. She is the author of The Mafia in Italian Lives and Literature: Life Sentences and Their Geographies, published in Italian as Le geografie della mafia nella vita e nella letteratura dell’Italia contemporanea, and editor of the acclaimed volumes The Italian Antimafia, New Media, and the Culture of Legality and Mafia and Outlaw Stories in Italian Life and Literature. She is currently working on a book that examines representations of feminicide in Italian literature, film, and media. -

Scarica La Versione in Pdf Con Immagini
2013 luglio-agosto Anno 15 Numero 4 Numero 15 Anno RistrettiRistrettiwww.ristretti.org Periodico di informazione e cultura dal Carcere Due Palazzi di Padova OrizzontiOrizzonti Il male che si nasconde dentro di noi Spedizione in A.P. art. 2 comma 20/C Legge 662/96 filiale di Padova art. 2 comma 20/C Legge 662/96 filiale di Padova Spedizione in A.P. La violenza che cancella le donne Una persona che distrugge la sua famiglia non fa calcoli di pena Quali narrative per le scienze che si occupano del male? La narrazione giudiziaria e quella con al centro l’umanità degli individui Giornata di studi “Il male che si nasconde dentro di noi” Redazione 1 Il male ci riguarda tutti 2 Il significato e il valore delle narrazioni Miguel Arrieta Guevara, Qamar Aslam Abbas, di Ornella Favero di Adolfo Ceretti, Professore ordinario di Criminologia, Università di Gentian Belegu, Erjon Celaj, Clirim Bitri, Sandro Calderoni, Paolo Cambedda, Alain Canzian, Gianluca Milano-Bicocca, e Coordinatore Scientifico dell’Ufficio per la Mediazione Cappuzzo, Marco Cavallini, Roverto Cobertera, Penale di Milano. Ulderico Galassini, Luigi Guida, Dritanet Iberisha, Bardhyl Ismaili, Pjerin Kola, Davor Kovac, Sofian Madsiss, Enos Malin, Angelo Meneghetti, Andrea Leoni, Fabio Montagnino, Michele Montagnoli, Capitolo primo: Violenza, vendetta, “codice del disonore” Bruno Monzoni, Igor Munteanu, Carmelo Musumeci, Victor Mora, Santo Napoli, Alessandro Pfeifer, Elvin 3 Orgoglio, onore, coraggio di Dritanet Iberisha, Ristretti Orizzonti Pupi, Lorenzo Sciacca, Kleant Sula, Oddone -

Le Donne Nelle Organizzazioni Mafiose
CORSO DI LAUREA IN Scienze politiche Le donne nelle organizzazioni mafiose. La letteratura contemporanea. Elaborato finale di: Monica Memeo Relatore: Prof. Fernando Dalla Chiesa Anno Accademico: 2010/2011 INDICE INTRODUZIONE pag. 3 CAPITOLO 1 IL RUOLO TRADIZIONALE DELLA DONNA NELLE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE 1.1 IL TRADIZIONALE RUOLO MATERNO pag. 8 1.2 TRASMISSIONE DEL CODICE CULTURALE MAFIOSO pag. 9 1.3 INCITAMENTO ALLA VENDETTA pag. 11 1.4 GARANTE DELLA REPUTAZIONE MASCHILE pag. 13 1.5 MERCE DI SCAMBIO NELLE POLITICHE MATRIMONIALI pag. 14 CAPITOLO 2 LA DONNA IN CARRIERA COME PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE MAFIOSA 2.1 I FATTORI DI CAMBIAMENTO pag. 17 2.2 I CAMBIAMENTI NELLA GIURISDIZIONE pag. 19 2.3 TRA STEREOTIPI E CAMBIAMENTO: MARIA CONCETTA IMBRAGUGLIA E IL PERMANERE DELL’AMBIGUITA’ pag. 20 2.4 MAFIA, ‘NDRANGHETA, CAMORRA: UN’EVOLUZIONE DISUGUALE pag. 21 2.5 I SETTORI IN CUI OPERANO LE DONNE pag. 23 1 CAPITOLO 3 LA DONNA COME SUPPLENTE DEL BOSS 3.1 DETENZIONE O LATITANZA DEI CAPOMAFIA pag. 26 3.2 ALCUNI CASI CONCRETI DI TEMPORANEA DELEGA DEL POTERE pag. 28 3.3 UN CASO A META’ TRA SUPPLENZA E LEADERSHIP: MARIA FILIPPA MESSINA pag. 31 3.4 DONNE DI MAFIA: UN ELEMENTO DI RACCORDO pag. 31 CAPITOLO 4 LA DONNA COME CAPO 4.1 UNA QUESTIONE CONTROVERSA pag. 34 4.2 NONNA EROINA pag.35 4.3 ANNA MAZZA pag. 36 4.4 LA SIGNORA pag. 37 4.5 GIUSY VITALE pag. 38 4.6 IL CARISMA DELLE DONNE BOSS pag. 39 CONCLUSIONI pag. 42 BIBLIOGRAFIA pag. 46 SITOGRAFIA pag. 47 2 INTRODUZIONE «[Le donne di mafia] non sono protagoniste della violenza in prima persona, generalmente -
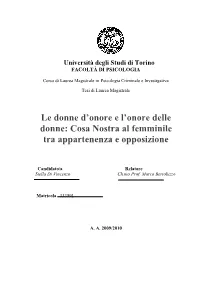
Le Donne D'onore E L'onore Delle Donne
Università degli Studi di Torino FACOLTÀ DI PSICOLOGIA Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Criminale e Investigativa Tesi di Laurea Magistrale Le donne d’onore e l’onore delle donne: Cosa Nostra al femminile tra appartenenza e opposizione Candidato/a Relatore Stella Di Vincenzo Ch.mo Prof. Marco Bertoluzzo Matricola 333591 A. A. 2009/2010 A mio Nonno A Maria Aurora Gueli Ai miei insostituibili genitori A me, Stella… INDICE INTRODUZIONE p.6 CAPITOLO I Cosa Nostra 1.1 Genesi e rappresentazione sociale: tra realtà e apparenza p.10 1.2 L’istituzione della legge Rognoni-La Torre p.16 1.2.1 I contenuti dell’art 416 bis p.20 1.3 La sospensione delle ordinarie regole di trattamento: l’art. 41 bis o.p. p.26 1.3.1 Analisi dei contenuti applicativi del regime di “carcere duro” p.30 CAPITOLO II Donna o Madre 2.1 Il ruolo materno nell’universo mafioso p. 36 2.1.1 Le madri “modello” p.42 2.1.2 Gli angeli vendicatori p.46 2.2 Famiglia e famiglia: un possibile conflitto p.51 2.3 Gli “intoccabili”: donne e bambini uccisi dalla mafia p.59 CAPITOLO III L’altra metà dalla mafia 3.1 La criminologia femminile e lo stereotipo culturale p.68 3 3.1.1Lo stereotipo della donna dentro Cosa Nostra p.73 3.2 L’impunità della donna di mafia: il paternalismo giudiziario p.76 3.3 Le attività criminali della donna di mafia. Droga e prostituzione p.86 3.3.1 Da messaggere a manager p.93 3.3.2 Le funzioni direttive p.99 3.4 La decostruzione dello stereotipo p.105 3.4.1 L’emancipazione femminile all’interno della mafia p.108 CAPITOLO IV Le donne del disonore 4.1 L’emergenza pentiti: supporto delle donne al pentimento p.112 4.1.1 L’opposizione al pentimento p.117 4.2 Le collaboratrici di giustizia p.129 CAPITOLO V L’onore delle donne 5.1 Le testimoni di giustizia p.158 5.1.1 Il modello emancipativo p.166 5.1.2 Le donne si costituiscono parti civili p.174 5.1.3 Commenti conclusivi p.190 5.2 Le Associazioni Antimafia p.194 CAPITOLO VI 6.1.