Il Dibattito Omaggio in Versi Letture
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Crestomazia Poetica Italiana Del Lavoro
Crestomazia poetica italiana del lavoro Nel 2013 è stato dato alle stampe un numero monografico di Semicerchio – Rivista di poesia comparata dedicato alla poesia del lavoro, corredato da immagini delle acciaierie di Piombino del pittore grossetano Claudio Cionini, lo stesso soggetto che era stato frequentato magistralmente, negli anni Sessanta del Novecento, dal fiorentino Fernando Farulli (1923-1997) con la serie di dipinti sui costruttori. L’opera è dedicata ai «lavoratori della Thyssen di Torino che hanno perso la vita in fabbrica e a tutti quelli che, per la mancanza di lavoro e la convinzione di non potervi fare fronte, della vita si sono privati». Il panorama poetico delineato dalla rivista è molto ampio, globale e fondato su una scelta non ben comprensibile (ma sempre apprezzabile), se non sul fatto di mettere in campo prevalentemente autori novecenteschi noti per la propria produzione poetica che hanno avuto anche la ventura di scrivere, più o meno occasionalmente, di lavoro e 1 lavoratori; sono presenti anche due saggi che si occupano di lavoro e canzone. Gli argomenti sono così antologizzati: § il Medioevo con il lavoro carolingio e la coltivazione dei giardini; § il Sudafrica dell’apartheid e del post-apartheid; § la Cina con la giovane poetessa operaia Zheng Xiaoqiong; § la Francia con George Sand (1804-1876), altri autori tra Otto e Novecento, una lettura poetica del capitolo 15 del libro I del Capitale di Guillaume Pigeard de Gurbert, e poi acuni testi di Pierre-Yves Soucy (L’ordre dans le maines) e di Jean- Claude Villain -

Alla Sera La Poesia-File Di Lavoro
2013 cinque giorni, cinquantatrè poeti Alla sera la poesia Le traduzioni, ove non indicato diversamente, sono di Daniela Sartogo. Alla sera la poesia Calendario Loggia del Municipio Mercoledì 18 settembre 2013, 19.00 Antonio De Biasio, Fabio Franzin, Silvio Ornella, Giacomo Vit, Giuseppe Zoppelli Loggia del Municipio Mercoledì 18 settembre 2013, 21.00 Cristina Alziati, Alberto Bertoni, Sebastiano Gatto, Maddalena Lotter, Luigi Nacci, Stefano Raimondi, Davide Rondoni, Francesco Tomada, Giovanni Turra Loggia del Municipio Giovedì19 settembre 2013, 21.00 Corrado Benigni, Alberto Cellotto, Maurizio Cucchi, Igor De Marchi, Andrea Longega, Titos Patrikios, Francesca Serragnoli, Francesco Targhetta, Mary Barbara Tolusso Loggia del Municipio Venerdì 20 settembre, 21.00 Stefano Dal Bianco, Alba Donati, Stefano Guglielmin, Andrej Hočevar, Erik Lindner, Daniele Mencarelli, Christian Sinicco, Giovanni Tuzet, Adam White, Willem M. Roggeman Alla sera la poesia Loggia del Municipio Sabato 21 settembre 2013, 21.00 Nino De Vita, Gabriel Del Sarto, Veronica Dintinjana, Matteo Fantuzzi, Marko Kravos, Isabella Leardini, Francesca Merloni, Michele Obit, Antonio Riccardi, Peter Semolič Loggia del Municipio Domenica 22 settembre 2013, 21.00 Nanni Balestrini, Mario Benedetti, Carlo Carabba, Tommaso Di Dio, Alessandra Frison, Omar Ghiani, Domenico Arturo Ingenito, Umberto Piersanti, Gregor Podlogar, Luigia Sorrentino Alla sera la poesia Antonio De Biasio Sto al finestrino. Fermo Non ho orgoglio. Non ho ambizioni. Vivo Infelice e felice la mia storia. Trascorre un tempo che non dà memoria. Mi chiudo in me. E se ne ho voglia scrivo. Ho preso un treno che non fa fermate: Ma se anche ne facesse, scenderei? Sto al finestrino, fermo sul replay. E a volte faccio inutili zoomate. -

Sono Le Prime Esperienze a Contare E Quella Con Elio Pagliarani
. Elio per tutti, tutti per Elio The straight story Ti chiedi perché sei come in un quadro di Hopper fra una domenica e l’altra davanti a una candela raggrumata come in un quadro sullo sgabello col bicchiere di vino. Ti reggi sul freddo del calice fai esercizio anche un poeta l’ha detto: «ci vuole temperanza e abitudine» Perciò dialoghi con me e mi sovvieni e/o a riporto sostieni e bisogna essere guardinghi che non si aprano le dighe quelle che non ti risultavano il lagnio della poesia domenicale a pancia piena. Cetta Petrollo Sono le prime esperienze a contare e quella con Elio Pagliarani (la poesia scritta da lui, la voce raschiante, il modo che aveva di lasciar parlare gli altri e di interromperli con scatti di impazienza che di brutale avevano però solo il suono, come film giapponesi in versione orginale) fu importante anche se non saprei dire esattamente per cosa, perché fu seminale come in effetti fu, a cosa contribuì, forse a nient’ altro che a lasciar essere liberamente ciascuno di quelli che lo leggevano, lo ascoltavano e gli parlavano – quindi l’esatto contrario di una formazione o magari la sua versione più raffinata. È raro, ho scoperto in seguito, che il gusto di influenzare il prossimo si eserciti in una maniera tanto riservata. Forse era proprio la sua scontrosità a renderlo delicatamente sensibile e pudico verso l’essenziale del discorso (basti leggere gli Esercizi platonici, cavati fuori con straordinaria leggerezza in poche ruvide mosse) e insofferente o indifferente verso le moine verbali che costituiscono il novanta per cento di ciò che, tra letterati, si usa definire «magistero». -

RIVISTE ITALIANE a Cura Di Elena Parrini (Si Segnalano Solo Le Riviste Pervenute Alla Redazione)
RIVISTE ITALIANE a cura di Elena Parrini (si segnalano solo le riviste pervenute alla redazione) ATELIER, trimestrale di poesia critica no inoltre un racconto del romano Andrea redazione e direzione: via Losanna 6, letteratura, a. VII, n. 25, marzo 2002, dire- De Carlo, omonimo dell’autore milanese 20154 Milano. E-mail: [email protected] zione: Corso Roma 168, 28021 Borgomane- di Treno di panna, e uno scritto di Amil- ro (NO). E-mail: [email protected] care Bardi. Fra le proposte poetiche spic- Come di consueto, la rivista pubblica cano le poesie sulle città dell’antichità di le poesie dei finalisti del concorso di poe- L’editoriale di Marco Merlin, Lo sci- Miro Gabriele che, come scrive Alessan- sia «Controcorrente» (vincitore della set- sma della poesia, rivendica per la propria dro Fo nella presentazione, è una delle tima edizione è Salvo Nugara con Le bel- generazione (e implicitamente per la pro- non poche voci contemporanee che «ri- le primavere). Segnaliamo anche l’inter- pria rivista, ampliata e rinnovata nella scoprono nella poesia greca e latina linfe vento di Gianni Pre su Quasimodo in oc- struttura redazionale come ci informa la nuove». Altri articoli si occupano di arte, casione del centenario della nascita. scheda introduttiva del numero) una po- scienza e reportages dall’India. [E. P.] sizione militante, «proprio nel mezzo, fra [A.F.] italiane riviste il Museo e la Piazza». La rubrica «L’Au- CORRENTE ALTERNATA, bolletti- tore» è dedicata a Franco Fortini, con una CAPOVERSO, rivista di scritture no d’informazione dell’Associazione notizia biobibliografica di Sandro Mon- poetiche, n. -

IL LIBRO DEGLI ALLIEVI Per Biancamaria Frabotta I L G L I M R I G a S E M
Questo libro, il libro degli allievi di Biancamaria Frabotta, funziona come un piccolo archivio storico meteoclimatico; un atlante di eventi e temperature registrati, nel corso dei decenni, lì dove continuano a incontrarsi le stesse coordinate. Le flessioni e i picchi dei climi qui rubricati si sono verificati su un'identica, tenace geografia: tutti, sulla stessa mappa, abbiamo raccontato la medesima stagione: quasi qua- rant’anni d’innamoramenti lirici, passioni civili, piani di studio, versi, lettere, chiacchiere e tesi di laurea. Funziona, questa curiosa seduta di IL LIBRO DEGLI ALLIEVI spiritismo, come un reportage corale da quei posti e da quei tempi, a t t come una fuga a più voci (oltre trenta) da ascoltare ininterrottamente, o b a movimento per movimento, rincorrendo le molte eco di temi e con- r F Per Biancamaria Frabotta a trappunti inseguitisi tra le generazioni nelle aule e nei collettivi, negli i r archivi e nelle cantine, nei libri e nelle dispense. Scrittrici di fama e a m a blogger, poeti e ricercatrici, giornaliste e autori televisivi, dottorande, c n a fotografi, professori, attivisti: ognuno ha modulato il suo canto di i B nostalgia e di omaggio rispondendo a una chiamata di gratitudine r Marco Caporali, Paolo Febbraro, Melania G. Mazzucco, e P Mario De Santis, Stefania Benini, Giommaria Monti, affettuosa. Come per ogni fuga che si rispetti, infine, c’è anche una coda, un’ultima voce sola con cui tutte le altre si sono intrecciate: la I Pietro Pedace (nella memoria di Tommaso Giartosio V voce della nostra professoressa, trascritta dalla lezione con cui si è con- E ed Edoardo Albinati), Maria Grazia Calandrone, I gedata dalla sua professione d’insegnante ma non, ci pare, dall’inse- L Simone Caltabellota, Vania De Luca, Nicola Sguera, L A gnamento in sé, un’arte umana che forse scenderà alla sua stessa Stefano Carta, Barbara Castaldo, Michele Fianco, I fermata, come la poesia. -

Diari Di Cineclub N. 88
_ n.3 Anno IX N. 88 | Novembre 2020 | ISSN 2431 - 6739 Il nostro caro Alberto Non è un film demen- Roma 1920 - 2020, auguri ziale Che parte del mondo della politica italiana, Sordi era per antono- comico, ha sviluppato, nel tempo, ruoli poeti- quella più egocentrica e rissaiola, provenga da masia l’italiano me- ci, drammatici, oltre a essere uno dei prover- persone che tentarono la loro notorietà con le dio, nell’immaginario biali 4 moschettieri del cinema italiano con televisioni berlusconiane è noto; che dopo es- collettivo, e questo ha Gassmann, Manfredi, Tognazzi, in un’epoca ser diventati “uomini politici” abbiano conti- voluto essere per tan- d’oro del cinema italiano, finora la più impor- nuato su quel percorso, lo paghiamo tutti i tissimi anni, nella sua tante. Divenuto autore e sceneggiatore dei giorni. arte di Player, di Atto- suoi film ha costruito, con Rodolfo Sonego, Nel 2021 si terranno le elezioni comunali per le re. Lui stesso è stato il con Armando Trovajoli, la narrativa e la poie- maggiori città italiane. A sentire i primi possi- Leonardo Dini primo grande attore sis delle sue opere, avendo come target la de- bili candidati abbiamo la conferma che il circo italiano, a realizzare, scrizione puntuale delle cose italiane e l’intui- della D’Urso è diventato partito. Si sussurra per la tv, per la Rai, l’antologia dei suoi brani to di sapere anticipare le evoluzioni della Massimo Giletti candidato a Roma e Torino; cinematografici, vista appunto come la Storia Storia sociale del Paese. Con Tutti dentro, ad Viperetta (Massimo Ferrero) a Roma; l’ex atto- di un italiano. -

Albo D'oro Dei Vincitori Del Mondello
Albo d’Oro dei vincitori del Premio Letterario Internazionale Mondello 1975 BARTOLO CATTAFI, letteratura UGO DELL’ARA, teatro DENIS MCSMITH, Premio speciale della Giuria 1976 ACHILLE CAMPANILE, letteratura ANTONINO ZICHICHI, scienze fisiche DOMENICO SCAGLIONE, scienze finanziarie FELICE CHILANTI, giornalismo FRANCESCO ROSI, cinema GIAMPIERO ORSELLO, informazione PAOLA BORBONI, teatro 1977 GÜNTER GRASS, letteratura SERGIO AMIDEI, SHELLEY WINTERS, cinema ROMOLO VALLI, ROBERTO DE SIMONE, teatro GIULIANA BERLINGUER, EMILIO ROSSI, televisione PIETRO RIZZUTO, lavoro STEFANO D’ARRIGO, Premio speciale della Giuria 1978 MILAN KUNDERA, Il valzer degli addii (Bompiani), narrativa straniera GHIANNIS RITSOS, Tre poemetti (Guanda), poesia straniera CARMELO SAMONÀ, Fratelli (Einaudi), opera prima narrativa GIOVANNI GIUGA, Poesie da Smerdjakov (Lacaita), opera prima poetica ANTONELLO AGLIOTTI, FRANCO CHIARENZA, MUZI LOFFREDO, GIOVANNI POGGIALI, GIULIANO VASILICÒ, teatro JURIJ TRIFONOV, Premio speciale della Giuria 1979 N. S. MOMADAY, Casa fatta di alba (Guanda), narrativa straniera JOSIF BRODSKIJ, Fermata nel deserto (Mondadori), poesia straniera FAUSTA GARAVINI, Gli occhi dei pavoni (Vallecchi), PIERA OPPEZZO, Minuto per minuto (La Tartaruga), opera prima narrativa GILBERTO SACERDOTI, Fabbrica minima e minore (Pratiche), opera prima poetica LEO DE BERARDINIS, PERLA PERAGALLO, teatro JAROSLAW IWASZKIEVICZ, Premio speciale della Giuria 1980 JUAN CARLOS ONETTI, Gli addii (Editori Riuniti), narrativa straniera JUAN GELMAN, Gotan (Guanda), poesia straniera -

«Corpo a Corpo Con Le Parole». La Poesia Di Jolanda Insana
Università degli Studi di Padova Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna Classe LM-14 Tesi di Laurea «Corpo a corpo con le parole». La poesia di Jolanda Insana. Relatore Laureanda Prof. Andrea Afribo Elisabetta Biemmi n° matr. 1143228 / LMFIM Anno Accademico1 2018 / 2019 2 Indice Capitolo 1. Tra vita, cultura e poesia: Jolanda Insana. ........................................... 5 1.1 L’infanzia a Messina e Monforte San Giorgio; la vita a Roma e le tappe della produzione poetica: la «poesia che si fa». ........................................................................ 5 1.2 La scrittura poetica e il rapporto con il linguaggio: corpo a corpo con la parola e con il mondo. ......................................................................................................................... 11 1.3 La generazione del ’56 e le influenze del secondo Novecento................................. 16 Capitolo 2. «Lei si chiama vita / e lei si chiama morte».Temi, motivi, semantica di Sciarra amara. .................................................................................................. 23 2.1 Vita e morte, due motivi in contrasto. ...................................................................... 23 2.2 La danza macabra della morte nei versi di Jolanda Insana....................................... 30 2.3 La resistenza della vita in una continua sciarra con la morte. .................................. 36 Capitolo 3. Corpo a corpo con la lingua: plurilinguismo in Sciarra Amara. -

Osservatorio Bibliografico Della Letteratura Italiana Otto-Novecentesca
ob io Oblio Osservatorio Bibliografico della Letteratura Italiana Otto-novecentesca Anno I, numero 1 Aprile 2011 OBLIO – Periodico trimestrale on-line – Anno I, n. 1 – Aprile 2011 sito web: www.progettoblio.com e-mail: [email protected] ISSN: 2039-7917 Direttore: Nicola MEROLA Direttore responsabile: Giulio MARCONE Redazione: Laura ADRIANI, Saverio VECCHIARELLI Amministratore: Saverio VECCHIARELLI Realizzazione Editoriale: Vecchiarelli Editore S.r.l. Comitato dei referenti scientifici: Giovanni BARBERI SQUAROTTI, Floriana CALITTI, Giovanna CALTAGIRONE, Luca CLERICI, Francesco DE NICOLA, Matilde DILLON, Marco DONDERO, Enrico ELLI, Patrizia FARINELLI, Lucio FELICI, Ombretta FRAU, Margherita GANERI, Lucio Antonio GIANNONE, Stefano GIOVANNUZZI, Vicente GONZÁLEZ MARTÍN, Cristina GRAGNANI, Monica LANZILLOTTA, Giuseppe LO CASTRO, Giovanni MAFFEI, Marco MANOTTA, Aldo MORACE, Mariella MUSCARIELLO, Giorgio NISINI, Massimo ONOFRI, Marina PAINO, Nunzia PALMIERI, Antonio PIETROPAOLI, Elena PORCIANI, Giancarlo QUIRICONI, Mario SECHI, Carlo SERAFINI, Silvana TAMIOZZO GOLDMANN, Dario TOMASELLO, Caterina VERBARO VECCHIARELLI EDITORE S.R.L. Piazza dell’Olmo, 27 – 00066 Manziana (Rm) Tel/Fax: 06 99674591 Partita IVA 10743581000 Iscrizione C.C.I.A.A. 10743581000 del 13/01/2010 VECCHIARELLI EDITORE Elenco Recensori Oblio I, 1 Ilaria ACCARDO Chiara LOMBARDI Federica ADRIANO Silvia LUTZONI Celia ARAMBURU SÁNCHEZ Giovanni MAFFEI Francesco Mattia ARCURI Beatrice MANETTI Luigi Ernesto ARRIGONI Chiara MARASCO Luca BANI Alessandro MARONGIU Maria Ginevra BARONE -

Si Può, Si Dovrebbe Essere Grati Agli Artisti. Che Cosa Sarebbe La Nostra Vita Senza La Loro Compagnia?
Si può, si dovrebbe essere grati agli artisti. Che cosa sarebbe la nostra vita senza la loro compagnia? Camillo de Piaz A rtisti epoetiperCamillo a cura di Giorgio Luzzi e Valerio Righini a curadiGiorgio LuzzieValerio RELIGIO LAICA DELL’amiCIZIA Artisti e poeti per Camillo PATROCINI RELIGIO LAICA DELL’amiCIZIA Inaugurazione mostra 21 settembre, ore 17.00 Apertura dal 22 settembre al 21 ottobre 2018 PREFETTURA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO CITTÀ DI TIRANO PALAZZO FOPPOLI TIRANO Orari 10.30/12.30-16.30/19.00 CONTRIBUTO E COLLABORAZIONE venerdì e sabato 10.30/12.30 - 16.30/19.00 - 20.30/22.00 MUSEO ETNOGRAFICO TIRANESE Settembre, 10.00/12.30 - 15.30/18.00 Ottobre, 15.30/18, chiuso il lunedì accordi per visite fuori orario tel. 0342 702572 SERVI DI MARIA CITTÀ DI TIRANO Progetto e coordinamento della mostra di Valerio Righini HANNO INOltrE CONTRIBUITO FINANZIARIAMENTE Sezione poesia a cura di Giorgio Luzzi Con la collaborazione di Bruno Ciapponi Landi e Laura Novati dell’Associazione Camillo De Piaz Referenze fotografiche Rachele Righini Archivio Banca Popolare di Sondrio pp. 24, 59, 62, 70 Archivio Galleria d’Arte Ponte Rosso pp. 28, 34 Archivio Centro Artistico Alik Cavaliere p. 29 TELERISCALDAMENTO Archivio Museo Etnografico Tiranese p. 32 COOGESTIONE lions club Bormio Paolo Monti p. 50 Archivio Galleria Anna Maria Consadori p. 58 Massimo Mandelli p. 31 Promozione della Archivi dei rispettivi artisti pp. 24, 36, 40, 42, 53, 56, 65, 69 cultura poschiavo Elaborazione grafica, redazione e stampa catalogo Tipografia Bettini, Sondrio - Settembre -
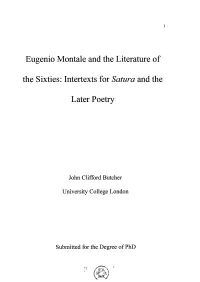
Eugenio Montale and the Literature of the Sixties: Intertexts for Satura And
Eugenio Montale and the Literature of the Sixties: Intertexts forSatura and the Later Poetry John Clifford Butcher University College London Submitted for the Degree of PhD ProQuest Number: 10015796 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10015796 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 Abstract This thesis sets out to explore the significant impact that poetry, fiction and essays published in the Sixties had on the development of Eugenio Montale’s later poetry. The primary focus is Satura (1971) but space is also accorded to Montale’s ensuing four collections,Diario del ’71 e del ’72 (1973), Quaderno di quattro anni (1977), Altri versi (1980) and Diario postumo (1996). The first part of this study delves into the role played by contemporary literature in that ‘svolta’ that took place with the composition of the ‘Xenia’ {Satura). Amongst those texts mentioned are an Italian translation of verse by William Carlos Williams and Natalia Ginzburg’s Lessico famigliare. The second part of this thesis deals with those works that helped effect the grand shift from the poetic mode of the ‘Xenia’ to that of ‘Satura T and ‘Satura IT (the final two sections ofSatura). -

5. Numeri Di Letterature
I PRIMI 9 ANNI DI LETTERATURE Festival Internazionale di Roma Nelle prime 9 EDIZIONI di Letterature Festival Internazionale di Roma, la Basilica di Massenzio ha ospitato 300.000 SPETTATORI in 91 SERATE . 183 SCRITTORI e POETI , accompagnati da 88 ATTORI , 123 MUSICISTI o GRUPPI e 14 VIDEO ARTISTI , sono saliti sul palco e hanno letto 150 TESTI INEDITI scritti appositamente per le diverse edizioni del Festival e poi raccolti in 9 CATALOGHI. Durante il periodo del festival nei 9 ANNI di programmazione oltre 200.000 PERSONE hanno visitato il sito www.festivaldelleletterature.it dove è possibile rileggere i testi inediti e avere maggiori informazioni su autori e artisti partecipanti. Dallo scorso anno, inoltre, il Festival è sbarcato sui social network: è stato creato il canale FLICKR che al momento raccoglie 279 FOTO , il canale youtube con 49 VIDEO , la pagina FACEBOOK e la pagina TWITTER. 2002 | SOLI, INSIEME Una riflessione sul rapporto tra la memoria del vissuto individuale e di quello collettivo. Michael Chabon, Jonathan Coe, Jostein Gaarder, Günter Grass, David Grossman, J.T. Leroy, Frank McCourt, Ian McEwan, Patrick McGrath, Toni Morrison, Amélie Nothomb, Luis Sepúlveda, Manuel Vázquez Montálban, Derek Walcott, Abraham B. Yehoshua. 2003 | PASSATO, FUTURO Una riflessione sul rapporto tra l’esperienza del passato e le brucianti questioni del domani Doris Lessing, Jonathan Lethem, Jeffrey Eugenides, Andrea Camilleri, Boris Akunin, Alan Warner, Don DeLillo, Tracy Chevalier, Daniel Pennac, Susan Sontag, Alice Sebold, Irina Denezkina, Dacia Maraini, Paco Ignacio Taibo II, Hanif Kureishi, Paul Auster. 2004 | REALE, IMMAGINARIO Il vissuto e l’immaginazione, la realtà e la fantasia, la Letteratura ne fa oggetto costante di riflessione, propria “materia” di lavoro .