Sono Le Prime Esperienze a Contare E Quella Con Elio Pagliarani
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Karaoke Catalog Updated On: 20/12/2018 Sing Online on Entire Catalog
Karaoke catalog Updated on: 20/12/2018 Sing online on www.karafun.com Entire catalog TOP 50 Tennessee Whiskey - Chris Stapleton Perfect - Ed Sheeran Grandma Got Run Over By A Reindeer - Elmo & All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey Summer Nights - Grease Crazy - Patsy Cline Bohemian Rhapsody - Queen Feliz Navidad - José Feliciano Have Yourself A Merry Little Christmas - Michael Sweet Caroline - Neil Diamond Folsom Prison Blues - Johnny Cash Killing me Softly - The Fugees Don't Stop Believing - Journey Ring Of Fire - Johnny Cash Zombie - The Cranberries Baby, It's Cold Outside - Dean Martin Dancing Queen - ABBA Fly Me To The Moon - Frank Sinatra Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee Girl Crush - Little Big Town Livin' On A Prayer - Bon Jovi White Christmas - Bing Crosby Piano Man - Billy Joel Jackson - Johnny Cash Jingle Bell Rock - Bobby Helms Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Baby It's Cold Outside - Idina Menzel Friends In Low Places - Garth Brooks Let It Go - Idina Menzel I Wanna Dance With Somebody - Whitney Houston Last Christmas - Wham! Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Dean Martin You're A Mean One, Mr. Grinch - Thurl Ravenscroft Uptown Funk - Bruno Mars Africa - Toto Rudolph The Red-Nosed Reindeer - Alan Jackson Shallow - A Star is Born My Way - Frank Sinatra I Will Survive - Gloria Gaynor The Christmas Song - Nat King Cole Wannabe - Spice Girls It's Beginning To Look A Lot Like Christmas - Dean Take Me Home, Country Roads - John Denver Please Come Home For Christmas - The Eagles Wagon Wheel - -

75Thary 1935 - 2010
ANNIVERS75thARY 1935 - 2010 The Music & the Artists of the Bach Festival Society The Mission of the Bach Festival Society of Winter Park, Inc. is to enrich the Central Florida community through presentation of exceptionally high-quality performances of the finest classical music in the repertoire, with special emphasis on oratorio and large choral works, world-class visiting artists, and the sacred and secular music of Johann Sebastian Bach and his contemporaries in the High Baroque and Early Classical periods. This Mission shall be achieved through presentation of: • the Annual Bach Festival, • the Visiting Artists Series, and • the Choral Masterworks Series. In addition, the Bach Festival Society of Winter Park, Inc. shall present a variety of educational and community outreach programs to encourage youth participation in music at all levels, to provide access to constituencies with special needs, and to participate with the community in celebrations or memorials at times of significant special occasions. Adopted by a Resolution of the Bach Festival Society Board of Trustees The Bach Festival Society of Winter Park, Inc. is a private non-profit foundation as defined under Section 509(a)(2) of the Internal Revenue Code and is exempt from federal income taxes under IRC Section 501(c)(3). Gifts and contributions are deductible for federal income tax purposes as provided by law. A copy of the Bach Festival Society official registration (CH 1655) and financial information may be obtained from the Florida Division of Consumer Services by calling toll-free 1-800-435-7352 within the State. Registration does not imply endorsement, approval, or recommendation by the State. -
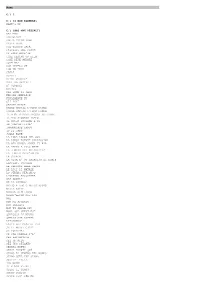
Name C:\ \ C:\ \4 NON BLONDES\ WHAT's up C:\ \883 MAX PEZZALI
Name C:\ \ C:\ \4 NON BLONDES\ WHAT'S UP C:\ \883 MAX PEZZALI\ 883 MIX AEROPLANO ANDRÀ TUTTO BENE BELLA VERA CHE GIORNO SARÀ CHIUDITI NEL CESSO CI SONO ANCH'IO COME DENTRO UN FILM COME DEVE ANDARE COME MAI CON DENTRO ME CON UN DECA CREDI CUMULI DIMMI PERCHE' DURI DA BATTERE E' VENERDI ECCOTI FAI COME TI PARE FAVOLA SEMPLICE FINALMENTE TU GLI ANNI GRAZIE MILLE HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO IL MEGLIO DEVE ANCORA ARRIVARE IL MIO SECONDO TEMPO IL MONDO INSIEME A TE IN QUESTA CITTA' INNAMORARE TANTO IO CI SARÒ JOLLY BLUE LA DURA LEGGE DEL GOL LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA LA MIA BANDA SUONA IL RAP LA RADIO A 1000 WATT LA REGINA DEL CELEBRITA' LA REGOLA DELL'AMICO LA STRADA LA VITA E' UN PARADISO DI BUGIE LASCIATI TOCCARE LE CANZONI ALLA RADIO LE LUCI DI NATALE LO STRANO PERCORSO L'ULTIMO BICCHIERE MAI UGUALI ME LA CAVERO' MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO NELLA NOTTE NESSUN RIMPIANTO NIENT'ALTRO CHE NOI NOI NON MI ARRENDO NON PENSAVI NON TI PASSA PIÙ NORD SUD OVEST EST QUALCOSA DI NUOVO QUELLO CHE CAPITA RITORNERO' ROTTA PER CASA DI DIO SE TI MUOVI COSI' SE TORNERAI SE UNA REGOLA C'E' SEI FANTASTICA SEI UN MITO SEI UNO SFIGATO SEMBRO MATTO SENZA AVERTI QUÌ SIAMO AL CENTRO DEL MONDO SIAMO QUEL CHE SIAMO SOLITA ITALIA TENENDOMI TI SENTO VIVERE TIENI IL TEMPO TORNO SUBITO TUTTO CIO' CHE HO TUTTO CIÒ CHE HO UN GIORNO COSI UN GIORNO COSI' UNA CANZONE D'AMORE UNA LUNGA ESTATE CALDISSIMA UN'ESTATE CI SALVERA' UNO IN PIÙ UNO SFIGATO VIAGGIO AL CENTRO DEL MONDO WEEKEND WELCOME TO MIAMI YOU NEEDED ME C:\ \A HA\ ANALOGUE COSY PRISONS DREAM -

Karaoke Mietsystem Songlist
Karaoke Mietsystem Songlist Ein Karaokesystem der Firma Showtronic Solutions AG in Zusammenarbeit mit Karafun. Karaoke-Katalog Update vom: 13/10/2020 Singen Sie online auf www.karafun.de Gesamter Katalog TOP 50 Shallow - A Star is Born Take Me Home, Country Roads - John Denver Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang Griechischer Wein - Udo Jürgens Verdammt, Ich Lieb' Dich - Matthias Reim Dancing Queen - ABBA Dance Monkey - Tones and I Breaking Free - High School Musical In The Ghetto - Elvis Presley Angels - Robbie Williams Hulapalu - Andreas Gabalier Someone Like You - Adele 99 Luftballons - Nena Tage wie diese - Die Toten Hosen Ring of Fire - Johnny Cash Lemon Tree - Fool's Garden Ohne Dich (schlaf' ich heut' nacht nicht ein) - You Are the Reason - Calum Scott Perfect - Ed Sheeran Münchener Freiheit Stand by Me - Ben E. King Im Wagen Vor Mir - Henry Valentino And Uschi Let It Go - Idina Menzel Can You Feel The Love Tonight - The Lion King Atemlos durch die Nacht - Helene Fischer Roller - Apache 207 Someone You Loved - Lewis Capaldi I Want It That Way - Backstreet Boys Über Sieben Brücken Musst Du Gehn - Peter Maffay Summer Of '69 - Bryan Adams Cordula grün - Die Draufgänger Tequila - The Champs ...Baby One More Time - Britney Spears All of Me - John Legend Barbie Girl - Aqua Chasing Cars - Snow Patrol My Way - Frank Sinatra Hallelujah - Alexandra Burke Aber Bitte Mit Sahne - Udo Jürgens Bohemian Rhapsody - Queen Wannabe - Spice Girls Schrei nach Liebe - Die Ärzte Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Country Roads - Hermes House Band Westerland - Die Ärzte Warum hast du nicht nein gesagt - Roland Kaiser Ich war noch niemals in New York - Ich War Noch Marmor, Stein Und Eisen Bricht - Drafi Deutscher Zombie - The Cranberries Niemals In New York Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) - Don't Stop Believing - Journey EXPLICIT Kann Texte enthalten, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. -

Clicca Qui Per Scaricare Touchpoint Magazine
Aprile | 2021 | n°03 FOCUS ASSICURAZIONI E BANCHE, LA FIDUCIA NELL’ERA DEL TECH Tra digitalizzazione, nuovi target e tone of voice, vince la relazione umana SPECIALE STAMPA Simona Maggini, LA CARTA Country Manager di WPP SCOMMETTE SULLA e CEO di VMLY&R Italy SOSTENIBILITÀ Nella sfida al digitale, il più classico dei media ha ancora chiari punti di forza La creatività sposa il commerce n°03 | Aprile 2021 € 8,00 Poste Italiane S.P.A. Spedizione Premium Press RENATO FRANCESCHIN/BLU COBALTO PHOTOGRAPHY 692003 ISSN 2612-6923 ISSN 772612 9 GOCCIA A GOCCIA OltreLaMediaGroup Editore Oltre La Media Group srl Sede legale: Via Melchiorre Gioia, 66 Cos’è quella cosa che si guadagna goccia a goccia, ma che si perde 20125 Milano - Italia a litri? Vi lascio qualche istante per trovare la soluzione a questo Sede operativa: Via Pescantina, 8 20162 Milano - Italia indovinello… Uno, due, tre, quattro… Bene, tempo scaduto. Per Phone +39 349 2671133 il grande Jean-Paul Sartre la risposta al quesito è semplice: la Registrazione Tribunale di Milano nr. 133 del 06/06/2019 fiducia. Credo che sia difficile dargli torto. Se le relazioni umane Numero iscrizione al ROC: 33224 fossero una ricetta, la fiducia sarebbe l’ingrediente essenziale. Amministratore unico Questo vale in amore, nell’amicizia, sul lavoro e naturalmente nel Giampaolo Rossi business. Conquistarla spesso equivale a scalare una montagna, Direttore responsabile ma perderla è un attimo: basta un passo falso per precipitare nel Andrea Crocioni burrone della disapprovazione e dell’incomunicabilità, da cui è [email protected] difficile risalire. Banche e assicurazioni, protagoniste del nostro Redazione focus, sono macchine complesse che proprio sulla fiducia dei Laura Buraschi [email protected] clienti costruiscono il loro valore. -

STAMPA REGISTRO DI INGRESSO Biblioteca Biblioteca Elio Pagliarani 120 Serie: Da Inv.: 1 a Inv.: 2685 Data Di Elaborazione: 18/01/2018
STAMPA REGISTRO DI INGRESSO Biblioteca Biblioteca Elio Pagliarani 120 Serie: da inv.: 1 a inv.: 2685 data di elaborazione: 18/01/2018 Inventario Data Prov. T Titolo T. mat Valore Precisazioni BID Collocazione Prezzo Fattura Del *Giornale di bordo / Ardengo Soffici. - Firenze : Vallecchi, 1951. - 229 p. : ill., [1] NARRATIVA 260 13/12/2017 D VM 30,00 1 v.TSA1467746 0,00 ritr. ; 22 cm. ((Ed. di 850 esemplari SOFFICI 1951 numerati. *Poesie inedite sull'amore, poesie politiche e varie / Bertolt Brecht ; nella versione di POESIA BRECHT 856 30/11/2017 D Gabriele Mucchi. - Milano : Garzanti, 1986. VM 25,00 CFI0049631 0,00 1986 - XIII, 345 p. ; 22 cm. ((Testo orig. a fronte. - In custodia. *Lingua contemporanea / Bruno Migliorini. - SAGGISTICA 1334 17/01/2018 D Firenze : G. C. Sansoni, 1938. - VI, 202 p. ; VM 25,00 1 v.RML0070965 0,00 MIGLIORINI 1938 18 cm. *Saggi sulla lingua del Novecento / Bruno SAGGISTICA 1335 17/01/2018 D Migliorini. - Firenze : Sansoni, 1941. - 257 VM 25,00 1 v.PUV0547826 0,00 MIGLIORINI 1941 p. ; 18 cm. *Conversazioni sulla lingua italiana / Bruno SAGGISTICA 1337 17/01/2018 D Migliorini. - Firenze : F. Le Monnier, 1949. - VM 20,00 1 v.TO00575721 0,00 MIGLIORINI 1949 174 p. ; 17 cm. NARRATIVA *Hilarotragoedia / Giorgio Manganelli. - 1643 13/12/2017 D VM 20,00 1 v.SBL0265653 MANGANELLI 0,00 Milano : Feltrinelli, 1964. - 176 p. ; 18 cm. 1964 L'*angelo del Liponard e altri racconti di mare / Mario Tobino ; introduzione di NARRATIVA 1648 03/01/2018 D VM 20,00 1 v.SBL0330918 0,00 Claudio Marabini. -

Karaoke-Katalog Update Vom: 17/06/2020 Singen Sie Online Auf Gesamter Katalog
Karaoke-Katalog Update vom: 17/06/2020 Singen Sie online auf www.karafun.de Gesamter Katalog TOP 50 Shallow - A Star is Born Take Me Home, Country Roads - John Denver Cordula grün - Die Draufgänger Dance Monkey - Tones and I Rote Lippen soll man küssen - Gus Backus Amoi seg' ma uns wieder - Andreas Gabalier Perfect - Ed Sheeran Tears In Heaven - Eric Clapton Chasing Cars - Snow Patrol Griechischer Wein - Udo Jürgens My Way - Frank Sinatra You Are the Reason - Calum Scott Someone You Loved - Lewis Capaldi Lemon Tree - Fool's Garden Tage wie diese - Die Toten Hosen Angels - Robbie Williams 99 Luftballons - Nena Up Where We Belong - Joe Cocker Im Wagen Vor Mir - Henry Valentino And Uschi I Want It That Way - Backstreet Boys Zombie - The Cranberries All of Me - John Legend Ich war noch niemals in New York - Ich War Noch New York, New York - Frank Sinatra Blinding Lights - The Weeknd Niemals In New York Hulapalu - Andreas Gabalier Hallelujah - Alexandra Burke Creep - Radiohead EXPLICIT Verdammt, Ich Lieb' Dich - Matthias Reim Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Let It Be - The Beatles Always Remember Us This Way - A Star is Born Atemlos durch die Nacht - Helene Fischer A Million Dreams - The Greatest Showman Kuliko Jana, Eine neue Zeit - Oonagh Eine Nacht - Ramon Roselly In The Ghetto - Elvis Presley (Everything I Do) I Do It For You - Bryan Adams Can You Feel The Love Tonight - The Lion King Bohemian Rhapsody - Queen Egal - Michael Wendler Warum hast du nicht nein gesagt - Roland Kaiser Der hellste Stern (Böhmischer Traum) - DJ Ötzi Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) - Über Sieben Brücken Musst Du Gehn - Peter Maffay Uber den Wolken - Reinhard Mey Losing My Religion - R.E.M. -

RIVISTE ITALIANE a Cura Di Elena Parrini (Si Segnalano Solo Le Riviste Pervenute Alla Redazione)
RIVISTE ITALIANE a cura di Elena Parrini (si segnalano solo le riviste pervenute alla redazione) ATELIER, trimestrale di poesia critica no inoltre un racconto del romano Andrea redazione e direzione: via Losanna 6, letteratura, a. VII, n. 25, marzo 2002, dire- De Carlo, omonimo dell’autore milanese 20154 Milano. E-mail: [email protected] zione: Corso Roma 168, 28021 Borgomane- di Treno di panna, e uno scritto di Amil- ro (NO). E-mail: [email protected] care Bardi. Fra le proposte poetiche spic- Come di consueto, la rivista pubblica cano le poesie sulle città dell’antichità di le poesie dei finalisti del concorso di poe- L’editoriale di Marco Merlin, Lo sci- Miro Gabriele che, come scrive Alessan- sia «Controcorrente» (vincitore della set- sma della poesia, rivendica per la propria dro Fo nella presentazione, è una delle tima edizione è Salvo Nugara con Le bel- generazione (e implicitamente per la pro- non poche voci contemporanee che «ri- le primavere). Segnaliamo anche l’inter- pria rivista, ampliata e rinnovata nella scoprono nella poesia greca e latina linfe vento di Gianni Pre su Quasimodo in oc- struttura redazionale come ci informa la nuove». Altri articoli si occupano di arte, casione del centenario della nascita. scheda introduttiva del numero) una po- scienza e reportages dall’India. [E. P.] sizione militante, «proprio nel mezzo, fra [A.F.] italiane riviste il Museo e la Piazza». La rubrica «L’Au- CORRENTE ALTERNATA, bolletti- tore» è dedicata a Franco Fortini, con una CAPOVERSO, rivista di scritture no d’informazione dell’Associazione notizia biobibliografica di Sandro Mon- poetiche, n. -

Racconti Fantasy Inventati Dalla Classe 2^A
Racconti Fantasy Inventati dalla classe 2^A 1 Presentazione del lavoro Durante il secondo bimestre di quest'anno scolastico gli alunni della classe 2^A hanno approfondito la conoscenza del genere fantasy leggendo vari racconti riportati nella sezione specifica del libro di antologia. Al termine di questa attività i ragazzi sono stati invitati a cimentarsi nella stesura di un racconto fantasy inventato da loro. I testi che seguono sono quindi racconti originali completamente inventati dagli alunni e corredati di immagini da loro disegnate per rendere il lettore partecipe della loro viva immaginazione. Buona lettura a tutti! Prof.ssa Daniela Doria 2 Indice Mpay e il medaglione (di Alessia Bernacchia) Pag. 4 La battaglia dei cavalieri (di Annalisa Tavola) Pag. 6 Il gioco (di Vittoria Marroni) Pag. 7 Jewuels il cavaliere di Campo Verde (di Andrea Torlaschi) Pag. 9 Somengard (di Stefano del Bosco) Pag.11 Il sogno perduto (di Mariachiara Zecchini) Pag.12 Cronometricus il drago del tempo (di Matthias Moroni) Pag.14 La botola (di Nicolò Calamai) Pag.15 Sopra le nuvole (di Thomas De Rosa) Pag.16 Il segreto del regno di Fantasy (di Laura Tapletti) Pag.17 Il mistero nella palude (di Rebecca Valgoi) Pag.19 La pietra della felicità (di Martina Barbaro) Pag.20 Eragon (di Andrea Martinelli) Pag.21 La banda mascherata e il cavaliere mascherato (di Giovanni Kone Massa) Pag.23 Il cavaliere fantasma (di Giacomo Vezzaro) Pag.24 Il diavolo (di Lorenzo Barocci) Pag.25 Il mago e la strega (di Alex Rizzotto) Pag.26 L’anello magico (di Erika Lombardi) Pag.27 Il mago (di Alessio De Felice) Pag.28 3 MPAY ED IL MEDAGLIONE Racconto di Alessia Bernacchia i aprì la solita porta di legno di quercia sulla camera della nonna di Mpay Laungh. -

Towards a Literary and Feminist Neo-Avant-Garde: Carla Vasio’S Experimental Fiction
Towards a Literary and Feminist Neo-Avant-Garde: Carla Vasio’s Experimental Fiction Lucia Re and Joseph Tumolo Fig. 1. Carla Vasio, in her home in Rome in June, 2019. Photo: Joseph Tumolo. Reproduced with permission of Carla Vasio. Carla Vasio (b. 1923; fig. 1) was one of two women writers present at the Gruppo 63’s first meeting in Palermo in October of 1963. The other was her friend, the poet Amelia Rosselli. Despite Vasio’s active involvement in several of the group’s meetings and activities over the years, she is rarely mentioned in critical discussions, and very little attention has been devoted to her work.1 This is not an isolated oversight, but a part of a larger pattern of marginalizing the women writers of the Italian neo-avant-garde.2 Even a cursory reading of Vasio’s works shows that this marginalization is unjustified, and that she is a writer who actively contributed to the aesthetic innovation of the Gruppo 63 while creating her own experimental literary style. As will become clear, Vasio’s experimentation is a fine example of neo-avant-garde aesthetics, distinguished by its sophisticated feminist critique of both the dominant masculinist dynamic of the Gruppo 63 and the misogyny of postwar Italian culture and society. Far from being a mere phase in her literary production, Vasio’s commitment to literary experimentation and feminism endured in different forms well beyond the 1960s.3 1 See Lucia Re, “Fanalini di coda,” in Gruppo 63. Il Romanzo sperimentale. Col senno di poi, ed. Nanni Balestrini and Andrea Cortellessa (Rome: L’orma, 2013), 319. -

IL LIBRO DEGLI ALLIEVI Per Biancamaria Frabotta I L G L I M R I G a S E M
Questo libro, il libro degli allievi di Biancamaria Frabotta, funziona come un piccolo archivio storico meteoclimatico; un atlante di eventi e temperature registrati, nel corso dei decenni, lì dove continuano a incontrarsi le stesse coordinate. Le flessioni e i picchi dei climi qui rubricati si sono verificati su un'identica, tenace geografia: tutti, sulla stessa mappa, abbiamo raccontato la medesima stagione: quasi qua- rant’anni d’innamoramenti lirici, passioni civili, piani di studio, versi, lettere, chiacchiere e tesi di laurea. Funziona, questa curiosa seduta di IL LIBRO DEGLI ALLIEVI spiritismo, come un reportage corale da quei posti e da quei tempi, a t t come una fuga a più voci (oltre trenta) da ascoltare ininterrottamente, o b a movimento per movimento, rincorrendo le molte eco di temi e con- r F Per Biancamaria Frabotta a trappunti inseguitisi tra le generazioni nelle aule e nei collettivi, negli i r archivi e nelle cantine, nei libri e nelle dispense. Scrittrici di fama e a m a blogger, poeti e ricercatrici, giornaliste e autori televisivi, dottorande, c n a fotografi, professori, attivisti: ognuno ha modulato il suo canto di i B nostalgia e di omaggio rispondendo a una chiamata di gratitudine r Marco Caporali, Paolo Febbraro, Melania G. Mazzucco, e P Mario De Santis, Stefania Benini, Giommaria Monti, affettuosa. Come per ogni fuga che si rispetti, infine, c’è anche una coda, un’ultima voce sola con cui tutte le altre si sono intrecciate: la I Pietro Pedace (nella memoria di Tommaso Giartosio V voce della nostra professoressa, trascritta dalla lezione con cui si è con- E ed Edoardo Albinati), Maria Grazia Calandrone, I gedata dalla sua professione d’insegnante ma non, ci pare, dall’inse- L Simone Caltabellota, Vania De Luca, Nicola Sguera, L A gnamento in sé, un’arte umana che forse scenderà alla sua stessa Stefano Carta, Barbara Castaldo, Michele Fianco, I fermata, come la poesia. -

Albo D'oro Dei Vincitori Del Mondello
Albo d’Oro dei vincitori del Premio Letterario Internazionale Mondello 1975 BARTOLO CATTAFI, letteratura UGO DELL’ARA, teatro DENIS MCSMITH, Premio speciale della Giuria 1976 ACHILLE CAMPANILE, letteratura ANTONINO ZICHICHI, scienze fisiche DOMENICO SCAGLIONE, scienze finanziarie FELICE CHILANTI, giornalismo FRANCESCO ROSI, cinema GIAMPIERO ORSELLO, informazione PAOLA BORBONI, teatro 1977 GÜNTER GRASS, letteratura SERGIO AMIDEI, SHELLEY WINTERS, cinema ROMOLO VALLI, ROBERTO DE SIMONE, teatro GIULIANA BERLINGUER, EMILIO ROSSI, televisione PIETRO RIZZUTO, lavoro STEFANO D’ARRIGO, Premio speciale della Giuria 1978 MILAN KUNDERA, Il valzer degli addii (Bompiani), narrativa straniera GHIANNIS RITSOS, Tre poemetti (Guanda), poesia straniera CARMELO SAMONÀ, Fratelli (Einaudi), opera prima narrativa GIOVANNI GIUGA, Poesie da Smerdjakov (Lacaita), opera prima poetica ANTONELLO AGLIOTTI, FRANCO CHIARENZA, MUZI LOFFREDO, GIOVANNI POGGIALI, GIULIANO VASILICÒ, teatro JURIJ TRIFONOV, Premio speciale della Giuria 1979 N. S. MOMADAY, Casa fatta di alba (Guanda), narrativa straniera JOSIF BRODSKIJ, Fermata nel deserto (Mondadori), poesia straniera FAUSTA GARAVINI, Gli occhi dei pavoni (Vallecchi), PIERA OPPEZZO, Minuto per minuto (La Tartaruga), opera prima narrativa GILBERTO SACERDOTI, Fabbrica minima e minore (Pratiche), opera prima poetica LEO DE BERARDINIS, PERLA PERAGALLO, teatro JAROSLAW IWASZKIEVICZ, Premio speciale della Giuria 1980 JUAN CARLOS ONETTI, Gli addii (Editori Riuniti), narrativa straniera JUAN GELMAN, Gotan (Guanda), poesia straniera