Bibliografia Numismatica (1997-2001) Novella Vismara
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Founding of the City
1 The Founding of the City 1. The environment of rome’s early hisTory Italy: A Geographically Fragmented Land italy is not a naturally unified land. It is a mosaic of different regions and sub-regions that through- out history have had difficulty communicating with each other. It lacks a large natural “center” the way, for instance, France and England have geographically coherent central homelands, or as Egypt or Mesopotamia had in antiquity. Symbolic of the way the ancients thought about Italy was the fact that for a good portion of their history, Romans did not think of the Po valley, today Italy’s most productive region, as part of Italy, and with good reason. The Po constituted what amounted to a separate country, being generally more in contact with continental Europe through the Brenner Pass than with peninsular Italy to the south where the Apennines impeded communications. The Romans called the Po valley Gallia Cisalpina—that is, “Gaul-on-this-side-of-the-alps.” (Gaul proper or modern france was Gallia Transalpina—“Gaul-on-the other side-of-the-alps”). it was an alien land inhabited by Gauls (Gaels—or, as we know them more commonly, Celts). Vestiges of this sense of regional diversity persist to the present. An active political movement currently seeks to detach northern Italy from the rest of the country, arguing that as the most developed and wealthiest part of italy, the north should not be forced to subsidize backward parts of southern Italy and Sicily. Other parts of Italy besides the Po valley are still difficult to reach from each other. -

A Near Eastern Ethnic Element Among the Etruscan Elite? Jodi Magness University of North Carolina at Chapel Hill
Etruscan Studies Journal of the Etruscan Foundation Volume 8 Article 4 2001 A Near Eastern Ethnic Element Among the Etruscan Elite? Jodi Magness University of North Carolina at Chapel Hill Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies Recommended Citation Magness, Jodi (2001) "A Near Eastern Ethnic Element Among the Etruscan Elite?," Etruscan Studies: Vol. 8 , Article 4. Available at: https://scholarworks.umass.edu/etruscan_studies/vol8/iss1/4 This Article is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Etruscan Studies by an authorized editor of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. A Near EasTern EThnic ElemenT Among The ETruscan EliTe? by Jodi Magness INTRODUCTION:THEPROBLEMOFETRUSCANORIGINS 1 “Virtually all archaeologists now agree that the evidence is overwhelmingly in favour of the “indigenous” theory of Etruscan origins: the development of Etruscan culture has to be understood within an evolutionary sequence of social elaboration in Etruria.” 2 “The archaeological evidence now available shows no sign of any invasion, migra- Tion, or colonisaTion in The eighTh cenTury... The formaTion of ETruscan civilisaTion occurred in ITaly by a gradual process, The final sTages of which can be documenTed in The archaeo- logical record from The ninTh To The sevenTh cenTuries BC... For This reason The problem of ETruscan origins is nowadays (righTly) relegaTed To a fooTnoTe in scholarly accounTs.” 3 he origins of the Etruscans have been the subject of debate since classical antiqui- Tty. There have traditionally been three schools of thought (or “models” or “the- ories”) regarding Etruscan origins, based on a combination of textual, archaeo- logical, and linguistic evidence.4 According to the first school of thought, the Etruscans (or Tyrrhenians = Tyrsenoi, Tyrrhenoi) originated in the eastern Mediterranean. -

Cultural Transmission and Semantic Change of Ceramic Forms in Grave Goods of Hellenistic Etruria
Cultural Transmission and Semantic Change of Ceramic Forms in Grave Goods of Hellenistic Etruria Raffaella Da Vela Abstract: This contribution addresses semantic change in ceramics as connected to identity con- struction. With three case studies from Hellenistic Etruria, beaked situlae, lagynoi and amphorae, I aim to answer the following research question: How can a change of vessel functions in funerary contexts express the changing cultural identities of the deceased and their family? The choice of fu- nerary contexts allows an approximation of the change of meaning through the analysis of the dis- tance between daily life and ritual function of the objects. Each case study presents a different rela- tionship between changing meaning and identity construction: the beaked situlae, related to the so- cial identity of new social layers; the amphorae, related to local cultural identities during the process of Romanisation; and the lagynoi, related to the construction of multicultural identities in new- founded agricultural settlements. The distinct patterns of the three forms suggest the possibility of analysing stratified and complex societies by the study of changing meaning. This article approaches the semantic change terranean represent a breaking point in the of some grave goods in funerary contexts of social structure of many Etruscan communi- Hellenistic Etruria as a consequence of a ties. This break effected a change which global process of cultural transmission involved many aspects of the material cul- which affected Etruscan and Italic cultures1 ture. Three case studies are selected and during the Hellenistic period. The process of isolated to analyse specific research ques- adopting the Latin language and roman insti- tions which are stated at the beginning of tutions in Etruria, especially in the inland each paragraph and relate to the construction and northern part of the region, engaged a of local identities and their transformation complexity of layers. -

The Roman Settlement of Poggio Del Molino: the Late Republican Fort and the Early Imperial Farm
The Journal of Fasti Online (ISSN 1828-3179) ● Published by the Associazione Internazionale di Archeologia Classica ● Palazzo Altemps, Via Sant'Appolinare 8 – 00186 Roma ● Tel. / Fax: ++39.06.67.98.798 ● http://www.aiac.org; http://www.fastionline.org The Roman Settlement of Poggio del Molino: the Late Republican Fort and the Early Imperial Farm Stefano Genovesi – Carolina Megale The Roman Settlement of Poggio del Molino, located in the territory controlled by the city of Populonia (Piombino, Livorno), has long drawn the interest of archaeologists. Excavations conducted by the University of Florence were interrupted for twenty years and eventually resumed in 2008. The new research project has provided evidence for the site’s architectural evolution, revealing different construction stages and uses of spaces during a time of intense environmental and political change. Such data confirm the strategic importance of Poggio del Molino throughout a very long period of Roman history, from the Late Republic to the end of the Empire– mid 2nd century BCE-beginning of 5th century CE. The new research project is endorsed and supported by public institutions (Municipality of Piombino and University of Florence) as well as private national and international institutions (Cultur- al Association Past in Progress, Earthwatch Institute, University of Arizona, Hofstra University, Union College, Foundation RavennAntica) which are involved in field surveys, post-excavation studies and initiatives concerning the site’s enhancement. This paper focuses on the oldest stage of the site’s history, the Late Republican Fort, and on the second stage, the farm with fish sauce production. 1 - The Late Republican Fort of Poggio del Molino. -

Archaeological and Literary Etruscans: Constructions of Etruscan Identity in the First Century Bce
ARCHAEOLOGICAL AND LITERARY ETRUSCANS: CONSTRUCTIONS OF ETRUSCAN IDENTITY IN THE FIRST CENTURY BCE John B. Beeby A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Classics in the College of Arts and Sciences. Chapel Hill 2019 Approved by: James B. Rives Jennifer Gates-Foster Luca Grillo Carrie Murray James O’Hara © 2019 John B. Beeby ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT John B. Beeby: Archaeological and Literary Etruscans: Constructions of Etruscan Identity in the First Century BCE (Under the direction of James B. Rives) This dissertation examines the construction and negotiation of Etruscan ethnic identity in the first century BCE using both archaeological and literary evidence. Earlier scholars maintained that the first century BCE witnessed the final decline of Etruscan civilization, the demise of their language, the end of Etruscan history, and the disappearance of true Etruscan identity. They saw these changes as the result of Romanization, a one-sided and therefore simple process. This dissertation shows that the changes occurring in Etruria during the first century BCE were instead complex and non-linear. Detailed analyses of both literary and archaeological evidence for Etruscans in the first century BCE show that there was a lively, ongoing discourse between and among Etruscans and non-Etruscans about the place of Etruscans in ancient society. My method musters evidence from Late Etruscan family tombs of Perugia, Vergil’s Aeneid, and Books 1-5 of Livy’s history. Chapter 1 introduces the topic of ethnicity in general and as it relates specifically to the study of material remains and literary criticism. -

Volume 14 Winter 2012 the Etruscans in Leiden and Amsterdam: “Eminent Women, Powerful Men” Double Exhibition on Ancient Italian Culture Perspective
Volume 14 Winter 2012 The Etruscans In Leiden and Amsterdam: “Eminent Women, Powerful Men” Double Exhibition on Ancient Italian culture perspective. The exhibition in Leiden tombs still adorn the romantic land- focuses on Etruscan women, the exhibi- scapes of Umbria and Tuscany. tion in Amsterdam on Etruscan men. Etruscan art, from magnificent gold On display will be more than 600 jewels to colorful tomb paintings, con- pieces from the museums’ own collec- tinues to fire the imagination of lovers tions and from many foreign museums. of Italy and art. “Etruscans: Eminent The ruins of imposing Etruscan Women, Powerful Men,” provides a October 14 - March 18, 2012 detailed introduction to Etruscan civi- The National Museum of lization in a visually delightful exhibi- Antiquities in Leiden and the Allard tion. Pierson Museum in Amsterdam pres- The Etruscans flourished hundreds ents the fascinating world of the of years before the Romans came to Etruscans to the public in a unique dou- power in Italy. Their civilization ble exhibition. The two museums tell reached its height between 750 and 500 the tale of Etruscan wealth, religion, BC, Etruscan society was highly devel- power and splendor, each from its own Left & Right: Brolio bronzes. Center: Replica of the Latona at Leiden. oped; women continued on page 15 Scientists declare the XXVIII Convegno di tions with Corsica and featured specific studies of Etruscan material found in the Fibula Praenestina and its engraved with the earliest archaic Latin Studi Etruschi ed Italici inscription. The matter of its authentic- Corsica and Populonia excavations at Aleria. Rich in minerals inscription to be genuine ity has been a question for a long time. -
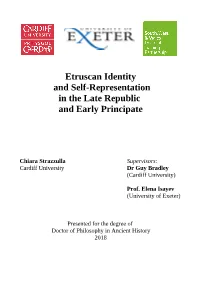
Etruscan Identity and Self-Representation in the Late Republic and Early Principate
Etruscan Identity and Self-Representation in the Late Republic and Early Principate Chiara Strazzulla Supervisors: Cardiff University Dr Guy Bradley (Cardiff University) Prof. Elena Isayev (University of Exeter) Presented for the degree of Doctor of Philosophy in Ancient History 2018 Acknowledgements Research might often be portrayed as a solo enterprise, but no work of research is ever truly done alone. This work would most certainly not have been possible without the help and support of many others beside me, who gave their own precious insights, directed my investigation to unexpected corners of the subject topic, and generously gave assistance when assistance was needed. My heartfelt thanks go therefore to: My supervisors, Dr Guy Bradley and Prof. Elena Isayev, who have been present at every stage, providing fundamental clarifications, encouraging me to push my limits and find my strengths, helping me shape what was a disconnected bunch of ideas about Romans and Etruscans into something concrete. Their dedication to this work cannot be understated and without it none of it would have been possible. All at AHRC and the South, West and Wales Doctoral Training Partnership, for generously funding my PhD and providing invaluable occasions for personal and professional development, debate, and sharing. The discussions had at cohort days organised by the DTP have helped guide the direction my research was taking, provided me with additional tools and given me interdisciplinary insights. My thanks in particular to Chantelle Payne and Rose Jones, for their tireless organisational work; and to all the fellow DTP students with whom I exchanged opinions and ideas, most importantly Beatrice Hitchman, Sophie Payne, Maria Tomlinson, Anna Field, James Thomas Lloyd, and Jo Bryant. -

915 Radiocarbon Reveals the Age of Two Precious Tombs
RADIOCARBON, Vol 51, Nr 3, 2009, p 915–922 © 2009 by the Arizona Board of Regents on behalf of the University of Arizona RADIOCARBON REVEALS THE AGE OF TWO PRECIOUS TOMBS IN THE ETRUSCAN SITE OF POPULONIA-BARATTI (TUSCANY) C Scirè Calabrisotto1 • M E Fedi2,3 • F Taccetti2 • M Benvenuti4 • L Chiarantini4 • L Quaglia5 ABSTRACT. The archaeological site of Populonia-Baratti, in the southern part of Tuscany (Italy), was one of the most important centers in ancient Etruria, as seen in the evidence of metallurgical activities carried out at that time. During recent archaeological excavations (2005) in the ancient industrial area of Populonia, along the Baratti beach, 2 interesting tombs were found. The 2 graves were unusually located in an area dedicated to metallurgical activity and showed a particular struc- ture of the burial chambers and an extreme richness in the grave goods. The unique character of the 2 tombs prompted many questions: who were these 2 individuals (a woman wearing many jewels and a tall, vigorous man) and when did they die? In order to obtain useful information about the chronology of the 2 tombs, accelerator mass spectrometry (AMS) radiocarbon analyses were performed on samples taken from the ribs of the 2 skeletons. Measured 14C ages were converted to calibrated ages using additional information derived from stable isotope ratios measured in the extracted collagen. Actually, the 13C data provided useful hints about the diet of the 2 individuals, thus allowing us to estimate the percentage of marine food consumed (about 30%) and exploit a combined marine-terrestrial calibration curve. -

Giovannangelo Camporeale Un Convegno Di Studi Etruschi in Corsica
GIOVANNAN G ELO CAMPOREALE UN CONVEGNO DI STUDI ETRUSCHI IN CORSICA Autorità, colleghi, signori e signore, se si scorrono i nomi dei partecipanti al I convegno nazionale etrusco del 1926 o al I congres- so internazionale etrusco del 1928, che sono stati gli eventi promotori della nascita dell’Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici, o se si scorrono anche i nomi dei membri che vi afferi- scono o quelli dei collaboratori degli Studi Etruschi già dalle prime annate, si constata che la sua attività fin dalla fondazione ha avuto un carattere internazionale, carattere che si è conservato e intensificato nel corso degli anni. Del resto, la ricerca scientifica o la cultura prescindono da definizioni o limiti di carattere nazionale o etnico o politico. Il convegno che si inaugura oggi a Bastia rientra in questa direttiva. Chi studia etruscologia sa bene che il campo di indagine della disciplina è da intendere in senso geograficamente e culturalmente più ampio dello stretto mondo etrusco e comprende l’intera Italia preromana, beninteso nell’ultimo millennio a.C.: non a caso l’Istituto è di studi etruschi ed italici e non a caso nelle università italiane l’insegnamento si chiama Etruscologia e Antichità (o Archeologia) italiche. Inoltre, si sa bene che il ruolo che hanno avuto gli antichi Ita- lici, e in modo speciale gli Etruschi, nelle vicende storiche che hanno interessato le aree me- diterranea e transalpina nel corso dell’ultimo millennio a.C. è stato di primaria importanza. Le risorse del suolo e del sottosuolo della regione da loro abitata, come i minerali e i metalli, i prodotti agricoli, il bestiame d’allevamento, il sale, il legname dei boschi, i manufatti di bronzo e di ferro hanno attirato nella penisola gruppi di diversa provenienza, che vi hanno dedotto colonie o hanno intrecciato relazioni di scambi con le popolazioni locali: fatti, questi, che sono stati seguiti da risvolti culturali di notevole rilievo. -

Etruscan Italy
Etruscan italy as seen by students Study Materials ENGLISH VERSION Brno 2018 EDITORS Anna Krčmářová, Tomáš Štěpánek, Klára Matulová, Věra Klontza-Jaklová Published only in the electronic form. These study materials are available on the webpage of ÚAM MU Brno (http://archeo-muzeo.phil.muni.cz/). These study materials were created under the auspices of Masaryk University at Department of Archeology and Museology within the grant project FRMU MUNI / FR / 1298/2016 (ID = 36283). Etruscan italy as seen by students Excursion participants, Volterra 2017. ENGLISH VERSION Brno 2018 Introduction The excursion to Italy was held from 29th May till 7th June 2017 and was organized by students of Department of Archaeology and Museology of Masaryk University in Brno. The main intention was to present the Etruscan landscape in its natural settings to students of Classical Archaeology and related fields of study. The excursion took place within the grant project FRMU ID-MUNI / FR / 1298/2016 (ID = 36283). This excursion completed following Classical Archaeology courses: AEB_74 (Etruscan and Central Europe) and KLBcA25 (Etruscans in the context of Ancient World - Etruscology), KLMgrA31 (Excursion) but it was considerably valuable as well for students of History and Ancient history. All students had to be active in the period of its organization in order to complete the course and get the credits. Before the field trip, they had to attend a seminar to get acquainted with each visited site and the individual essay’s topics have been shared with students. The selection of topics was based on their own interest. Students were allowed to work in smaller groups or completely independently. -

Presentation of Italia Ante Romanum Imperium an Etruscan Herbal?
VOLUME: 5WINTER, 2006 An Etruscan Herbal? Presentation of Italia ante by Kyle P. Johnson New York University Romanum imperium Among the approximately 200 Etruscan words which have come down to us are over fifty glosses, synonyms of Greek and Latin words from ancient authors found in the margins of medieval man- uscripts and preserved in the manuscript tradition. 1 Among these glosses, thirteen plant names are of particular inter- est. They are preserved in two codices (R and V) of Dioscorides of Anazarbus’ de Materia Medica, a first-century compendium of pharmacologi- cal uses of plants, minerals, and animal products.2 These glosses have a fascinating history and are of value not only to philolo- gists of the Etruscan lan- The Bay of Pyrgi seen from the Castle of Santa Severa, with a storm at sea. The arrows guage, but also to scholars of indicate the site of the monumental sanctuary (left) and the Area Sud (right). In the Roman religious practice. background, the Monti Ceriti. (Photo G. Colonna 1993). The source of the glosses in the de Materia Medica is a matter for speculation. The likeli- Italia ante Romanum imperium. Scritti di sion by reading a letter by Giovanni Pugliese est candidate is the first-century CE lexicog- Henbane (Hyoscyamus niger L. © 1995- antichità etrusche, italiche e romane (1958- Carratelli, who could not be present. rapher Pamphilus of Alexandria, who com- 2005 Missouri Botanical Garden 1998) , 6 vols., by Giovanni Colonna. Roma, Giovanni Colonna, Professor of Etruscan http://www.illustratedgarden.org/) piled a now-lost lexicon in ninety-five Pisa, Istituti Editoriali e Poligrafici Studies at the Sapienza University in Rome, is 3 books. -

Metallurgy and the Development of Etruscan Civilisation
Dissertation submitted for the degree of MPhil Ancient History, UCL, London Metallurgy and the Development of Etruscan Civilisation PIETER WILLIAM MOMMERSTEEG History Department, University College, London Supervisor: Prof. Michael Crawford I confirm that this dissertation is entirely my own work. All sources and quotations have been acknowledged. The main works consulted are listed in the bibliography. Note: This dissertation is an unrevised examination copy for consultation only, and may not be quoted or cited without permission of the Chairman of the Board of Examiners for the MPhil in Ancient History. 1 Metallurgy and the Development of Etruscan Civilisation Contents Acknowledgements Chapter 1 Introduction Chapter 2 Ancient Technologies: Pottery and Textiles Chapter 3 The Technology of Copper and Bronze Chapter 4 The Advent of Iron 1200 – 900 BC Chapter 5 The Emergence of Etruria: Middle Bronze Age – 6th century BC Chapter 6 Metalworking in Etruria: 1st millennium BC Chapter 7 The Output of Iron from Populonia: quantitative analysis Chapter 8 The Demand for Iron: the economic background Chapter 9 Applications for Iron: 300-100 BC Chapter 10 Quantities: Uses of Iron, 300-100 BC Chapter 11 The Transfer of Technology Chapter 12 Summary and Conclusions Appendix 1 Area map: Golfo di Baratti. Diagram of the Gulf of Baratti from P Crew in JHMS 25/2 Appendix 2 Site Map from A.Minto Populonia Bibliography 2 Acknowledgements Firstly, I would like to thank Prof Michael Crawford, my supervisor, whose patience, encouragement and professional input has been invaluable and beyond the call of duty. Any errors or misguided reasoning though remain mine alone.