Il Palazzo Storico Della Magnifica Comunità
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Istituto D'istruzione “La Rosa Bianca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE “LA ROSA BIANCA - WEISSE ROSE” PROGETTO TRIENNALE DI ISTITUTO 2020/2023 (Legge Provinciale n.10/2016) 1 STRUTTURA DEL PROGETTO D’ISTITUTO PREMESSA NORMATIVA PRESENTAZIONE VISION E MISSION ORGANISMI FUNZIONIGRAMMA DELL’ISTITUZIONE L’ISTITUTO DI CAVALESE (UN’ANALISI SWOT) PREMESSE E CONTENUTI GENERALI IL CONTESTO LE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALE LOCALI IL CONTESTO SOCIALE PARTNER STRATEGICI LE STRATEGIE INCLUSIVE LE PERFORMANCE I PROFILI PROFESSIONALI OBIETTIVI STRATEGICI 2 PATTO EDUCATIVO AREA ALUNNI REGOLAMENTI I PROGETTI EDUCATIVI CARTA DEI SERVIZI AREA FAMIGLIE QUADRI ORARI LA CONSULTA REGOLAMENTI PIANO ANNUALE DELLA AREA DOCENTI FORMAZIONE MACROAREE E PIANO ANNUALE DELLE SUPPORTI ATTIVITA’ DOCUMENTALI MANSIONARIO SERVIZI DI SUPPORTO ORARI DI SEGRETERIA PIANI DI STUDIO OFFERTA SCOLASTICA CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE ARTICOLAZIONE DELLE PROVE ORGANISMI DELL’ISTITUZIONE E LORO FUNZIONE 3 PREMESSA -VISTA la legge provinciale n. 05 del 07.08.2006 che definisce ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia il “sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”; -VISTA la legge provinciale n. 10 del 22.06.2016, recante la “Riforma del sistema educativo di istruzione e formazione della provincia di Trento” che dà attuazione, nel rispetto delle prerogative statutarie alla Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; -VISTO il piano della performance 2014-2016 del Ministero -
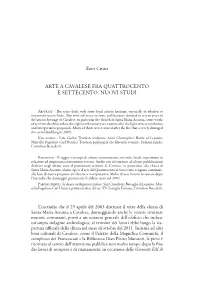
Arte a Cavalese Fra Quattrocento E Settecento
Ezio Chini ARTE A CAVALESE FRA QUATTROCENTO E SETTECENTO. NUOVI STUDI Abstract - Th e essay deals with some local artistic heritage, especially in relation to important recent fi nds. Also with reference to some publications devoted in recent years to the artistic heritage of Cavalese, in particular the church of Santa Maria Assunta, some works of art from the fi fteenth to the eighteenth century are examined in the light of new attributive and interpretative proposals. Many of them were restored after the fi re that severely damaged the sacred building in 2003. Key words - Late Gothic Tyrolean sculpture; Saint Christopher; Battle of Lepanto; Marcello Fogolino; Carl Henrici; Tyrolean painting of the fi fteenth century; Firmian family; Cristoforo Benedetti. Riassunto - Il saggio si occupa di alcune testimonianze artistiche locali, soprattutto in relazione ad importanti ritrovamenti recenti. Anche con riferimento ad alcune pubblicazioni dedicate negli ultimi anni al patrimonio artistico di Cavalese, in particolare alla chiesa di Santa Maria Assunta, alcune opere d’arte dal Quattrocento al Settecento vengono esaminate, alla luce di nuove proposte attributive e interpretative. Molte di esse furono restaurate dopo l’incendio che danneggiò gravemente l’edifi cio sacro nel 2003. Parole chiave - Scultura tardogotica tirolese; San Cristoforo; Battaglia di Lepanto; Mar- cello Fogolino; Carl Henrici; pittura tirolese del sec. XV; Famiglia Firmian; Cristoforo Benedetti. L’incendio che il 29 aprile del 2003 distrusse il tetto della chiesa di Santa Maria Assunta a Cavalese, danneggiando anche le vetuste strutture murarie sottostanti, portò a un restauro generale dell’edifi cio che incluse un’ampia indagine archeologica; al termine dei lavori ebbe luogo la ria- pertura uffi ciale della chiesa nel mese di ottobre del 2011. -

Tra Arte Cultura E Storia Maggio 2017 Palazzi Aperti - I Municipi Del Trentino Per I Beni Culturali
PALAZZI APERTI I MUNICIPI DEL TRENTINO PER I BENI CULTURALI TRA ARTE CULTURA E STORIA MAGGIO 2017 PALAZZI APERTI - I MUNICIPI DEL TRENTINO PER I BENI CULTURALI PALAZZI APERTI I MUNICIPI DEL TRENTINO PER I BENI CULTURALI TRA ARTE CULTURA E STORIA MAGGIO 2017 Maggio, tempo di primavera, tempo di Palazzi Aperti: un appuntamento fisso per gli amanti dell’arte e della cultura che nei fine settimana possono ammirare vere e proprie chicche, altrimenti non visitabili, per motivi logistici o perché spazi privati. Una suggestiva occasione pensata per rafforzare l’identità storica ed artistica del territorio, per svelare vezzi artistici e storie affascinanti che hanno caratterizza- to gli antichi palazzi ed i percorsi scelti per raccontare al meglio la nostra realtà culturale, con l’intenzione primaria di soddisfare la curiosità degli appassionati, che da anni ci seguono nei diversi itinerari e di attirare nuovi fruitori con percorsi sempre più accattivanti e diversi nelle loro proposte. Come ogni anno, nel mese di maggio tutto il territorio trentino si fa portavoce di storie e valori tipici della sua tradizione, per offrire una nuova prospettiva attra- verso cui guardare all’ambiente circostante: una prospettiva fatta di racconti, di immagini di piazze e palazzi che restano impresse nella memoria della storia e non si piegano all’inesorabile scorrere del tempo. La proposta, coordinata dal Comune di Trento con la partecipazione della Provin- cia, vuole consapevolizzare i cittadini della presenza di tutti quegli edifici, chiese e frammenti di storia che spesso rimangono poco noti o non opportunamente valorizzati. Questa nuova edizione di Palazzi Aperti coinvolge più di 70 comuni, molti dei quali presenziano per la prima volta, con l’accorpamento dei centri più piccoli in un’uni- ca amministrazione attraverso tour culturali che interessano anche nuovi Comu- ni, tra cui quelli dell’Altopiano della Vigolana, di Amblar-Don e di Altavalle. -

Marina Botteri Nicolò Rasmo E Il Settecento: Percorsi Inediti E Tutela
Marina Botteri Nicolò Rasmo e il Settecento: percorsi inediti e tutela Abstract Il Settecento è un campo di studio cui Rasmo dedica particolare attenzione con lavori pionieristici riguardanti, in particolare, la cosiddetta Scuola di Fiemme. In questo contesto ricostruisce criticamente la figura di Giuseppe Alberti (Tesero, 1640- Cavalese 1716), che ne fu promotore e maestro indiscusso, e di Francesco Unterperger (Cavalese, 1707-1776), cui Rasmo si interessa già all’inizio della sua attività, verso la metà degli anni Trenta, e al quale dedica una mostra monografica nel 1977. Altrettanto significativo è avere riportato alla luce un artista sconosciuto come Antonio Longo (Varena 1742-Varena 1820), pittore e architetto eclettico. Anche Giovan Battista Lampi (Romeno 1751 - Vienna 1830), pittore che lega la sua fama di artista ai ritratti eseguiti presso le più importanti corti europee, è oggetto precoce degli studi di Rasmo. Nella mostra del 1951, a lui dedicata al castello del Buonconsiglio, Rasmo rivela non solo una grande capacità critica nel presentare il pittore, ma dà anche l'avvio agli studi sulla ritrattistica del Settecento trentino, tanto che il relativo catalogo rimane per molto tempo un testo di riferimento fondamentale per queste ricerche. Si tratta anche del primo lavoro in cui viene presentata l'attività di Domenico Zeni (Bardolino 1762-Brescia 1819), autore allora praticamente sconosciuto, quale ritrattista della nobiltà trentina. Più legata all’ambiente bolzanino è la figura di Carl Henrici (Schweidnitz 1737-Bolzano 1823), prolifico pittore rococò, anch’esso oggetto di studi costanti e di ricerche archivistiche, culminati nella mostra monografica del 1977. L’intervento affronta questi temi, unitamente alla segnalazione di uno dei molteplici episodi legati alla tutela, riguardante la salvaguardia della chiesa della Disciplina a Riva del Garda. -

Note Storico-Artistiche Sulla Chiesa Della Madonna Della Neve a Bellamonte
Note storico-artistiche sulla chiesa della Madonna della Neve a Bellamonte di Italo Giordani La località Bellamonte, anticamente la Monte degli uomini di Fiemme o la Monte del fieno o la Mont'Orfana, dove la monte, al femminile, stava per zona prativa e di pascolo, è un'ampia distesa di prati di media montagna, il cui accesso per la fienagione nei mesi di luglio ed agosto di ogni anno era regolamentato dalla Comunità di Fiemme. Ed in quei mesi vi era una processione di uo- mini e donne con carri per portarsi dal loro paesi in valle verso quella località a falciare il fieno, seccarlo, rastrellarlo, ammucchiarlo, caricarlo e portarlo a casa. Poiché già nel Seicento buona parte di quei prati appartenevano a gente di Tesero, fu questa Regola che il 29 settembre 1707 presentò domanda alla Comunità di poter costruire una cappella al fine di poter celebrare le funzioni religiose in estate durante la fienagione. Ottenuta l'autorizza- zione ed il legname necessario, venne edificata una chiesetta orientata nord-sud, con campanilet- to di legno e con dedica a Maria Ausiliatrice o della Neve ed ai Santi Cosma e Antonio abate ed all'Angelo Custode, benedetta il 5 agosto 1708 dadon Giuseppe Antonio Manci, decano di Fiemme (1708-1737). Fu consacrata il 18 luglio 1722 dal vescovo Giovanni Michele Venceslao Spaur, suffraga- neo e nipote del principe vescovo di Trento Giovanni Michele Spaur (1696-1725) in visita pastorale. La chiesetta venne poi ampliata nel 1882 su disegno di Simone Longo di Predazzo e restaurata nel 1919 dai danni subiti durante la guerra; in ambedue i casi grazie ad un consistente contributo della Comunità di Fiemme. -

Scarica La Brochure
ITA BENVENUTI A VILLA MADRUZZO HOTEL, RISTORANTE, SPA & WELLNESS La famiglia Polonioli e tutto il suo team saranno lieti di accogliervi con calore e professionalità, con l’auspicio che Villa Madruzzo non sia solo il vostro hotel, ma la vostra casa in Trentino. Lasciatevi conquistare dall’atmosfera storica che ci cir- conda, dal verde distensivo delle montagne trentine e dalle nostre attenzioni. PERCHE’ VILLA MADRUZZO? Villa Madruzzo è una dimora da un ambiente ricercato, ma al storica del cinquecento che sorge tempo stesso ospitale e confortevole. sulle colline ad Est di Trento. La Lasciatevi avvolgere dall’accoglienza villa è immersa nel verde di alberi familiare, dal servizio attento, secolari e dei vigneti limitrofi, con cordiale e dall’atmosfera senza tempo una splendida vista panoramica che riserviamo a ciascun cliente: sulla città e sulle montagne Trentine. professionalità e calore sono i nostri Villa Madruzzo è la meta ideale in segni distintivi. cui vivere un’esperienza circondati IL RISTORANTE Un ambiente raffinato, curato nei abbinamenti più adatti dalla nostra dettagli, ed un servizio competente carta vini; e, per concludere, una e accorto fanno da contorno alle buona grappa, distillato d’eccellenza gustose pietanze che i nostri cuochi nella nostra terra. A Villa Madruzzo propongono quotidianamente nel non c’è che l’imbarazzo della scelta. nostro menù. Piatti e ingredienti Pronto ad accogliere gli ospiti della tradizione trentina si alternano dell’hotel, il ristorante è noto e a ricette nazionali, in una proposta frequentato anche da ospiti esterni, che gastronomica varia, capace di ne apprezzano da sempre la cucina, gli accontentare i palati dai più curiosi ambienti e la cortesia del personale. -

Biblioteca Professionale
BIBLIOTECA PROFESSIONALE Incunaboli dologica, p. XXXI). Ulteriori ne alla coerenza dell’og- ne e alla circolazione del li- e cinquecentine indicazioni, di carattere non getto potrebbe ingenerarsi bro in area trentina tra il del Fondo trentino più tecnico ma storico-cul- alla lettura del catalogo cu- primo insediamento della della Biblioteca turale, sono rintracciabili mulativo, e ciò è ricono- attività tipografica nel 1475 comunale di Trento. nella Prefazione di Pasquale sciuto molto onestamente e l’ultimo scorcio del XVI Catalogo Chistè e Fabrizio Leonardelli dai prefatori (ibidem). Ma secolo. Non che sia scarna a cura di Elena Ravelli riguardo ai “requisiti di per- habent sua fata bibliothe- la bibliografia su singoli e Mauro Hausbergher tinenza/attinenza trentina cae, e sono le varie, e perfi- aspetti del tema. Ad esem- Trento, Provincia autonoma delle opere e delle pubbli- no contraddittorie, modalità pio bene esplorati, grazie a di Trento – Servizio beni cazioni e quindi i criteri di di accumulazione di nuclei convegni e mostre, sono librari e archivistici inclusione delle pubblica- librari, con l’emersione di stati i profili individuali, le 2000, p. IX-401 zioni nelle sezioni trentine nuovi orientamenti di ac- politiche culturali e le rac- della biblioteca” (p. X). Ri- quisizione e casuali con- colte librarie dei principi chiamandosi alla distinzione fluenze patrimoniali, che vescovi: Il principe vescovo In una tendenza, peraltro tra opera (intesa come rea- fondano e costituiscono la Johannes Hinderbach (1465- largamente diffusa, -

Notiziario Gennaio 2021
n. 1 - 2021 La Magnifi ca COMUNITÀ DI FIEMME CARA FORESTA Questa è una promessa LEGNAME Prezzi in lieve crescita L’ARCHIVISTA 2.800 tracce di passato RIORGANIZZIAMOCI Le priorità del nuovo scario Renzo Daprà per traghettare l’Ente oltre la “crisi” Anno XXXIX n. 1 - Quadrimestrale - Poste Italiane SpA - Spedizione in abb. post. 70% DCB - TN - Tassa pagata - Taxe perque Taxe pagata - Tassa TN - post. 70% DCB - Italiane SpA - Spedizione in abb. n. 1 - Quadrimestrale Poste Anno XXXIX 2 In copertina foto di Enrico Delvai L’arte contamina nonostante tutto MUSEI SONO CHIUSI a causa della pandemia, ma l’arte contamina liberamente. Durante le scorse festività natalizie, il Comune di Cavalese ha proiettato sui suoi edifi ci le opere del Museo Arte Contempora- Inea Cavalese, del Museo Pinacoteca Magnifi ca Comunità di Fiemme e del Museo Casa Natale Antonio Longo. Sulla facciata dell’albergo Bellante è stata proiettata l’Adorazione dei Magi, dipinta da Giambattista Pittoni (Venezia, 1687-1767): un capolavoro che potremmo tornare ad ammirare nel museo pinacoteca della Magnifi ca appena sarà riaperto. Sulla chiesa della Santissima Trinità di Masi di Cavalese è comparsa un’opera di grande intensità espressiva del pittore sacerdote di Varena Antonio Longo: Madonna con Bambino e San Giovannino (1772). Nel giardino di casa Ress è stata proiettata l’opera fotografi ca “Goc- ce di ghiaccio-Racconto d’inverno” di Albert Ceolan, ospitata dal Museo Arte Contemporanea di Cavalese nel 2019. La notizia di questa luminosa evasione d’arte è approdata anche sul sito del Tgcom24. Intanto, il Museo Arte Contemporanea Cavalese ha pubblicato la mostra online “Mutamenti”, dove i cambiamenti dettati da Vaia18 e Covid19 viaggiano in parallelo, grazie all’intervento di 10 artisti. -

Indice Dei Documenti Pubblicati Sul Sito
Italo Giordani – Via Ischia, 2/C I – 38030 Panchià cell. +39 320/6704204 [email protected] www.storiadifiemme.it Indice dei documenti pubblicati sul sito Documenti in ordine cronologico 1236 maggio 1 (giovedì), Trento. Il vescovo di Trento Aldrighetto di Campo autorizza la costruzio- ne di due case a Cavalese [ASTn, APV, Codici, 18, n. 230 e n. 2311] (giugno 2019). 1297 gennaio 25 (venerdì), Cavalese. Testimonianze del toponimo Anterivo [ADT, Archivio del Capi- tolo2] {pp. 320-322}3 (novembre 2017). 1307 aprile 1 (sabato), Trento. Il vescovo di Trento Bartolomeo Querini conferma i privilegi della Comunità di Fiemme [Copia autentica del 24 giugno 1322 in AMCF, capsa G, 1] {pp. 292-295} (maggio 2017). 1310 gennaio 15 (giovedì), Castel Tirolo. Il conte del Tirolo Ottone promette di non far più edificare fortilizi in Fiemme [Archivio di Stato di Vienna, MS 389, f. 61] {pp. 87-91 e pp. 302-304} (giu- gno 2009) (agosto 2017). 1310 maggio 3 (domenica), Gries di Bolzano. Il conte del Tirolo Ottone fa demolire il fortilizio di Castello [Archivio di Stato di Vienna, MS 389, f. 61] {pp. 87-91 e pp. 302-304} (giugno 2009) (agosto 2017). 1312 maggio 8 (lunedì), Trento. Il conte del Tirolo conferma l’accordo del 1234 sui confini tra la Co- munità di Fiemme e le Regole di Egna, Montagna, Aldino [AMCF, capsa K, 2] {pp. 120-122} (febbraio 2010). 1313 dicembre 29 (sabato), Fiemme. Testimonianze del legittimo possesso delle case romane sparse per Fiemme da parte dei conti del Tirolo [Archivio di Stato di Monaco di Baviera, “Auswärti- ge Staaten Grafschaft Tirol”, Lit. -

Tovazzi Diario 1 1754-1780
Giangrisostomo Tovazzi OFM Diario secolaresco e monastico TRENTO Fondazione Biblioteca San Bernardino 2006 Prefazione Il P. Giangrisostomo Tovazzi non ha premesso alcuna prefazione al suo Diario, probabilmente perché è rimasto interrotto causa la morte dell'autore. Per poter capire la disposizione della materia trattata cronologicamente dobbiamo riportare qui i titoli previsti dall'autore per i sei volumi in cui è contenuto tale Diario e come sono ora registrati presso la Biblioteca San Bernardino di Trento. Diario monastico ossia parte seconda del Diario di F. Grisostomo. MS 64, pp. 246. Questo volume (con paginazione a sé) in pratica non fa parte dell'opera conosciuta come Diario del Tovazzi, e perciò qui lo tralasciamo. I seguenti cinque volumi hanno paginazione continuata. Volume I: Diario secolaresco ossia parte prima del Diario di F. Grisostomo. MS 65, pp. 1-224. Periodo di tempo: 1754-13 febbraio 1780. Volume II: Continuazione del Diario secolaresco parte prima. MS 66, pp. 225-986+3. Periodo di tempo: 11 marzo 1780-2 agosto 1785. Volume III. Continuazione Diario secolaresco parte prima. MS 67, pp. 987-1.544 +3. Periodo di tempo: 9 agosto 1785-15 ottobre 1791. V0lume IV: Continuazione del Diario trentino. Secolaresco, e monastico. MS 68, pp. 1.548- 2066+3. Periodo di tempo: 18 ottobre 1791-15 luglio 1801. Volume V: Continuazione del Diario Trentino secolaresco, e monastico. MS 69, pp. 2.068- 2.433+ 1. Periodo di tempo: 2 agosto 1801-12 ottobre 1809. Dalla pagina 2.230 a pagina 2.433 (16 marzo 1806-12 ottobre 1809) questo volume del Diario è stato continuato dal P. -

Scoiattolo Economico Il Trentino Rivista Della Provincia Autonoma Di Trento Anno XLVIII – Numero 318 Sommario 318 Maggio 2012 Piazza Dante N
L’Autonomia? Il diritto di sentirsi in dovere www.provincia.tn.it il Trentino maggio 2012 Rivista della Provincia autonoma di Trento anno XLVIII - numero 318 Scoiattolo economico il Trentino Rivista della Provincia autonoma di Trento Anno XLVIII – numero 318 sommario 318 Maggio 2012 Piazza Dante n. 15, 38122 Trento maggio 2012 Tel. 0461 494684-37 www.riviste.provincia.tn.it festival dell’economia 4 Direttore responsabile: Giampaolo Pedrotti Coordinatore editoriale: Carlo Martinelli Redazione: Pier Francesco Fedrizzi, Mauro Neri, notiZie Euregio! 16 Marco Pontoni, Lorenzo Rotondi, Fausta Slanzi, Arianna Tamburini, Corrado Zanetti L’innovazione delle idee 18 Vanda Campolongo, Marina Malcotti, De Gasperi on-line 20 Elisabetta Valduga, Silvia Vernaccini Amministrazione: Lara Degasperi teRRitoRio Speciale Strade / Vallarsa 23 Hanno collaborato: Gabriele Catania, Marco Potrich, Luca Rizzonelli, Marina Rosset, Rossella Saltini, Ierma Sega, Daniele Valersi, Gianna Zortea. notiZie L’isola dei Feaci 30 Fotografie: Archivio: Ufficio stampa Provincia autonoma Trento; ReMida; Servizio civile Pat; AgfBernardinatti, Piero Cavagna, I Piani dei Giovani 32 Giovanni Cavulli, Massimo Franceschini-Fondazione Orchestra Riciclo creativo 34 Haydn, Romano Magrone, Daniele Mosna, Hugo Muñoz, Luca Ognibeni. cultuRa A tutta orchestra 36 Impaginazione: Artimedia - Trento Copertina: un momento del Festival 2011. Al museo Pietra Viva 38 Foto di Giovanni Cavulli Paolo, il riformista 40 Stampa: S.I.E. Spa Società Iniziative Editoriali - Trento Registrazione del Tribunale di Trento n. 100 BiBlioteca 42 del 13.08.1963 – iscrizione nel R.O.C. n. 480 Volete ricevere Il Trentino ad un indirizzo diver- euRoPa 44 so? C’è un indirizzo da modificare? Ci sono più destinatari nella stessa famiglia? Non volete più ricevere la rivista? Dubbi, domande, curiosità, chiarimenti, consigli, critiche, suggerimen- La rivista “il Trentino” è consultabile sul sito www.ufficiostampa.provincia.tn.it/il_trentino ti, complimenti? Il numero verde e l’indirizzo email sono a vostra disposizione. -

(Secc. Xv-Xviii) 2012-2014
Progetto di ricerca FRAMMENTI DELL’ARCHIVIO DEL PRINCIPATO VESCOVILE NEL FONDO MANOSCRITTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO (SECC. XV-XVIII) 2012-2014 Coordinatori scientifici: dr.ssa Katia Occhi Istituto storico italo-germanico, Fondazione Bruno Kessler prof. Andrea Giorgi Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Trento Schedatura delle carte e documenti dell'archivio vescovile di Trento nella Raccolta Mazzetti 14 dicembre 2014 1 BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO Fondo Manoscritti Raccolta Mazzetti Carte e documenti dell'archivio vescovile di Trento a cura di Massimo Scandola Fondazione Bruno Kessler - Istituto storico italo-germanico 2 Premessa La schedatura è stata eseguita nel corso del progetto di ricerca "Frammenti dell'archivio del Principato vescovile nel Fondo Manoscritti della Biblioteca Comunale di Trento (secc. XV-XVIII)" promosso dall’Istituto storico italo-germanico della Fondazione Bruno Kessler e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’università di Trento, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Trento. La ricerca ha individuato e successivamente schedato la documentazione fuoriuscita dall’archivio vescovile in seguito alla secolarizzazione del Principato del 1803 e custodita oggi nella "Raccolta Mazzetti" del Fondo Manoscritti della Biblioteca Comunale di Trento. Essa comprende atti amministrativi, relazioni e memorie, documentazione diplomatica, inventari e materiali diversi acquistati dal barone Antonio Mazzetti nel mercato antiquario nei primi decenni dell'Ottocento. Alla documentazione amministrativa, contabile e giudiziaria si affianca il nucleo della "Corrispondenza", per buona parte riconducibile al carteggio personale dei vescovi e pertinente all’attività diplomatica. Essa si compone di circa 7200 lettere, destinate ai principi-vescovi, ai segretari della segreteria personale e infine ai funzionari della cancelleria in temporalibus.