Mercenari E Compagnie Di Ventura
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Auguste Rodin's 'The Burghers of Calais' and The
www.amatterofmind.us From the desk of Pierre Beaudry Page 1 of 15 AUGUSTE RODIN’S ‘THE BURGHERS OF CALAIS’ AND THE BLACK DEATH POLICY OF THE ENGLISH How Auguste Rodin created an artistic composition of axiomatic change. by Pierre Beaudry October 20, 2014 FOREWORD ``If a Black Death could spread throughout the world once in every generation, survivors could procreate freely without making the world too full.'' Bertrand Russell – 1949 ``In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation.'' Queen Elizabeth's consort Prince Philip – 1988 This is wake-up time. This report is a wake-up call attempting to answer a simple but difficult axiomatic question: “Why is it that American leaders and citizens don’t see that the plague of Ebola that is being brought to their doorsteps at this time is being carried out by the same people who brought about the Black Death to Europe during the fourteenth century?” The answer to that question can be found in the situation that the population of France found themselves into, when the King of England, Edward III, laid siege to the French town of Calais in 1346. www.amatterofmind.us From the desk of Pierre Beaudry Page 2 of 15 INTRODUCTION In his Chronicles, Jean Froissart (1337-1405), A French writer at the court of the King of England, told the story of how the French town of Calais’ people were spared a horrible death by the heroic action of six of their leaders, who voluntarily accepted to give their lives to save them from famine. -

Tc Ankara Ünġversġtesġ Sosyal Bġlġmler Enstġtüsü
T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ORTAÇAĞ TARĠHĠ BĠLĠM DALI GEÇ ORTAÇAĞ’DA ĠTALYA’NIN SĠYASĠ DURUMU Yüksek Lisans Tezi Sait Emre ÇİFTÇİ Ankara-2019 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ORTAÇAĞ TARĠHĠ BĠLĠM DALI GEÇ ORTAÇAĞ’DA ĠTALYA’NIN SĠYASĠ DURUMU Yüksek Lisans Tezi Sait Emre ÇİFTÇİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Hatice ORUÇ Ankara-2019 II ONAY TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ORTAÇAĞ TARĠHĠ BĠLĠM DALI Sait Emre ÇİFTÇİ GEÇ ORTAÇAĞ’DA ĠTALYA’NIN SĠYASĠ DURUMU Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice ORUÇ Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Ġmzası .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ Tez Sınavı Tarihi .................................. III T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BĠLDĠRĠM Bu belge ile, tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak -
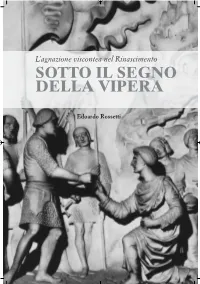
00-PRIME PP 2:Layout 1
L’agnazione viscontea nel Rinascimento SOTTO IL SEGNO DELLA VIPERA Edoardo Rossetti «In Milano la più degna e nobile fameglia è la Visconta» scriveva nel 1520 l’oratore veneto Gianiacopo Caroldo. Quella che rimaneva, nonostante l’estinzione del ramo ducale, la più importante agnazione di Milano non è stata sinora adeguatamente studiata, né nella geografia castel- lana delle sue numerose signorie, né nelle articolazioni delle sue iniziative politiche, né nella sua presenza culturale nello stato di Milano. È specialmente su quest’ultimo as- petto che si incentra questo volume. Attraverso un’ampia ricerca archivistica e iconografica largamente inedita ven- gono ricostruiti importanti episodi di committenza delle famiglie principali della parentela viscontea che si intrec- ciano a comporre una politica artistica di ampio respiro, tale da incidere profondamente sul territorio: da Milano a Somma Lombardo, da Pallanza a Brignano, da Vignate a Santa Maria del Monte sopra Varese. Edoardo Rossetti (Varese, 1979) si è laureato nel 2006 in Storia presso l’Università degli Studi di Milano è autore di numerosi saggi sulla storia politica, sociale, artistica e cul- turale del Rinascimento lombardo; coordina la collana Scaglie d’archivio dell’Archivio di Stato di Milano, per la quale ha curato il volume Squarci d’interni. FESR Fondo europeo di sviluppo regionale - Le opportunità non hanno confini Sotto il segno della vipera In copertina Gian Cristoforo Romano e collaboratori, Gian Galeazzo Visconti riceve la signoria di Milano, particolare del Monumento -

Nuova Gabbia
Luchino Visconti, Jacopo da Bologna and Petrarch: Courting a Patron* Elena Abramov-van Rijk In the musical repertory of the Trecento, no more than four compositions are unequivocally dedicated to a contemporary secular ruler: two madrigals, Lo lume vostro and O in Italia , and two motets, Lux purpurata/Diligite iustitiam and Laudibus dignis . The addressee of all four is the Milanese ruler Luchino Visconti (ca. 1292- 1349): the madrigal Lo lume vostro contains the acrostic LUCHINUS, and the motets have LUCHINUS VICECOMES and LUCHINUS DUX respectively; the madrigal O in Italia provides information on the birth of Luchino’s twin sons, Luchino Novello and Giovanni, on Friday, August 4, 1346. Whereas the first three * The first part of this article was presented at the Medieval and Renaissance Music conference in Barcelona, July 2011. I am grateful to Dorothea Baumann and Aldo Menichetti for their help in the early stages of this work, to Lucia Marchi for her suggestions, and to Sergei Abir. I owe my special thanks to Bonnie Blackburn and Leofranc Holford-Strevens for their comments and advice, and my kind regards to Biblioteca Medicea Laurenziana in Florence and Biblioteca Uni - versitaria in Padua for the permission of reproducing. Abbreviations used: FP Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Panciatichiano 26 Pit Paris, Bibliothèque Nationale de France, f. it. 568 Reina Paris, Bibliothèque Nationale de France, n. acq. fr. 6771 (Reina Codex) SL Firenze, San Lorenzo, Archivio Capitolare 2211 Sq Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Palatino 87 (Squarcialupi Codex) 7 elena abramov-van rijk compositions are known to have been written by Jacopo da Bologna, the motet Laudibus dignis is transmitted anonymously and fragmentarily: only one voice, apparently a triplum , has survived. -

Decreto Del Direttore Amministrativo N
Corso di Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’Età Contemporanea Tesi di Laurea LA BATTAGLIA DEL CASTAGNARO 11 MARZO 1387 TRACOLLO DEI SIGNORI DELLA SCALA Relatore Ch. Prof. Giorgio Ravegnani Co Relatori Ch Prof Luciano Pezzolo Ch Prof. Sergio Zamperetti Laureando Cristian Sartori Matricola 690798 Anno Accademico 2013 / 2014 INDICE INTRODUZIONE Pag. 2 SGUARDO D’INSIEME Pag. 3 VERONA E GLI SCALIGERI Pag. 12 PADOVA E I CARRARESI Pag. 79 LA PRECEDENTE CAMPAGNA Pag. 99 GLI ESERCITI RIVALI Pag. 108 I CAPITANI Pag. 126 LA BATTAGLIA Pag. 140 IL CAMPO DI BATTAGLIA OGGI Pag. 171 CONCLUSIONI Pag. 173 BIBLIOGRAFIA Pag. 180 1 INTRODUZIONE Penso di essere una persona fortunata perché, nel corso della mia formazione scolastica, ho avuto la fortuna d’incontrare sempre degli insegnanti molto capaci e ricordo, con particolare gratitudine, tra i miei maestri elementari, quello che mi ha contagiato con la sua passione per lo studio della storia. Avevo da poco imparato a leggere e, fra i primi regali, ricevetti un libro di storia che parlava di cavalieri, campi di battaglia, di schieramenti di eserciti; ne sono rimasto molto colpito e ho continuato, nel tempo, a cercare e leggere saggi di storia militare. Proprio assecondando questa passione, nei primi anni ’90, allora studente di ben altra facoltà, giurisprudenza, iniziai ad acquistare dei piccoli volumi, tradotti dall’inglese, che parlavano di eserciti ed episodi bellici nelle varie epoche. In uno di questi, m’imbattei in una breve descrizione della battaglia del Castagnaro che veniva definita l’esempio classico delle battaglie combattute in Italia nel periodo oggetto di questa ricerca. -

Les Compagnies D'aventure En Italie. Ascenseurs Sociaux Et Mondes
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by HAL-ENS-LYON Les compagnies d'aventure en Italie. Ascenseurs sociaux et mondes parall`elesau milieu du XIVe si`ecle Armand Jamme To cite this version: Armand Jamme. Les compagnies d'aventure en Italie. Ascenseurs sociaux et mondes parall`eles au milieu du XIVe si`ecle.Le petit peuple dans l'Occident m´edi´eval. Terminologies, perceptions, r´ealit´es,PU Sorbonne, pp.347-363, 2002. <halshs-00270084> HAL Id: halshs-00270084 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00270084 Submitted on 3 Apr 2008 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Les compagnies d'aventure en Italie : ascenseurs sociaux et mondes parallèles au milieu du XIV e siècle. L'histoire des compagnies d'aventure est souvent résumée par le destin des condottieri, personnages emblématiques des difficultés politiques de la péninsule italienne, voire témoins d'une démilitarisation de la société citadine sur fond de crise des valeurs communales 1. L'accent mis sur ces ambitieux capitaines a inexorablement tourné les regards vers leur âge d'or, le Quattrocento, et attribué aux siècles précédents un rôle de faire-valoir introductif 2. -

Cesare Cantù
Cesare Cantù Margherita Pusterla: racconto storico - Lettor mio, hai tu spasimato? - No. - Questo libro non è per te. 1833. CAPITOLO PRIMO. Entrando il marzo del 1340, i Gonzaga signori di Mantova avevano aperta una corte bandita nella loro città, con tavole disposte a chiunque venisse, con musici, saltambanchi, buffoni, fontane che sprizzavano vino, tutta insomma la pompa colla quale i tirannelli, surrogatisi ai liberi governi in Lombardia, procuravano di stordire i generosi, allettare i vani, ed abbagliare la plebe, sempre ingorda dietro a queste luccicanti apparenze. Fra i tremila cavalieri concorsi a quella festa con grande sfoggio d'abiti, colle più belle armadure che uscissero dalle fucine di Milano, con destrieri ferrati persino d'argento, v'erano comparsi molti Milanesi per fare la corte al giovinetto Bruzio, figliuolo naturale di Luchino Visconti, signor di Milano. Sono fra essi ricordati Giacomo Aliprando, Matteo Visconti fratello di Galeazzo e di Bernabò, che poi divennero principi; il Possidente di Gallarate, il Grande de' Crivelli, e sovra gli altri segnalato Franciscolo Pusterla, il più ricco possessore di Lombardia, e sarebbesi potuto dire il più felice, se la felicità potesse con beni umani assicurarsi, e se da quella non fosse precipitato al fondo d'ogni miseria, come il processo del nostro racconto dimostrerà. Questi campioni milanesi avevano riportato il premio della giostra ivi combattutasi, il quale consisteva in un superbo puledro del valore di 400 zecchini, nero come una pece, colla gualdrappa color di cielo, ricamata ad argento; in un altro, mezzano di grossezza, baio di colore e balzano di due piedi: oltre a due abiti, uno di scarlatto, l'altro di sciamito foderato di vaio. -

A Construção De Um Modelo Ideal No Príncipe De Nicolau Maquiavel (1532)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ LUCCA ZANETTI LEÕES E RAPOSAS: A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO IDEAL NO PRÍNCIPE DE NICOLAU MAQUIAVEL (1532) CURITIBA 2017 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ LUCCA ZANETTI LEÕES E RAPOSAS: A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO IDEAL NO PRÍNCIPE DE NICOLAU MAQUIAVEL (1532) Dissertaçãoapresentada como requisito à obtenção do grau de Mestre em História no curso do Programa de Pós-Graduação em História, PPGHIS,do Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná. Orientadora: Prof.ªDr.ª Fátima Regina Fernandes CURITIBA 2017 Catalogação na publicação Mariluci Zanela – CRB 9/1233 Biblioteca de Ciências Humanas e Educação - UFPR Zanetti, Lucca Leões e raposas: a construção de um modelo ideal no Príncipe de Nicolau Maquiavel (1532) / Lucca Zanetti – Curitiba, 2017. 112 f.; 29 cm. Orientadora: Fátima Regina Fernandes Dissertação (Mestrado em História) – Setor de Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná. 1. Machiavelli, Niccolo, 1469-1527 - Critica e interpretação. O príncipe. 2. Teoria política – Idade Média - História. 3. Condottieri - História. I. Título. CDD 320.1 Agradecimentos A redação desta dissertação foi trabalho longo e árduo, e conforme toda conquista séria demandou disciplina e dedicação. Foram muitos os momentos de autoquestionamento, de dúvida e incerteza e mesmo inépcia durante a redação desta pesquisa, mas também o foram os momentos de reafirmação das escolhas que fiz pertinentes a tomar a longa e árdua estrada da pesquisa científica no Brasil, nossa condição particular como pesquisadores da História enquanto Ciência repetidamente questionada. A sociedade questiona nossa função constantemente, e espero que meu esforço para a compreensão dessa figura um tanto enigmática sobre a qual me debrucei aqui seja aproveitado por muitos interessados no assunto. -

The Return of Private Armies and the Emergence of Neomedievalism
DURABLE DISORDER The Return of Private Armies and the Emergence of Neomedievalism Sean McFate A thesis submitted to the Department of International Relations of the London School of Economics and Political Science for the degree of Doctor of Philosophy 1 August 2011 DECLARATION I certify that the thesis I have presented for examination for the MPhil/PhD degree of the London School of Economics and Political Science is solely my own work other than where I have clearly indicated that it is the work of others (in which case the extent of any work carried out jointly by me and any other person is clearly identified in it). The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without the prior written consent of the author. I warrant that this authorization does not, to the best of my belief, infringe the rights of any third party. ii TABLE OF CONTENTS 1. Medieval Modernity 1 2. Evidence of Globalised Neomedievalism 50 3. The Return of Private Armies 188 4. The New Market for Force 212 5. Liberia: A Neomedieval Tale 295 6. Back to the Future 415 Glossary 426 Annexes 431 Annex A: Comprehensive Peace Agreement 431 Annex B: IDIQ Contract (S-LMAQM-03-00034) 433 Annex C: Contract Amendment (Raises Contract Ceiling) 439 Annex D: Liberia Military DDR-SSR Program Timeline 445 Bibliography 450 iii TABLES AND FIGURES Table 1: Typology of the Private Military Industry 248! Table 2: Conceptual Framework of the Security Sector 335! Figure 1: The -

Les Compagnies D'aventure En Italie. Ascenseurs Sociaux Et Mondes
Les compagnies d’aventure en Italie. Ascenseurs sociaux et mondes parallèles au milieu du XIVe siècle Armand Jamme To cite this version: Armand Jamme. Les compagnies d’aventure en Italie. Ascenseurs sociaux et mondes parallèles au milieu du XIVe siècle. Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités, PU Sorbonne, pp.347-363, 2002, 10.4000/books.psorbonne.14007. halshs-00270084 HAL Id: halshs-00270084 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00270084 Submitted on 3 Apr 2008 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Les compagnies d'aventure en Italie : ascenseurs sociaux et mondes parallèles au milieu du XIV e siècle. L'histoire des compagnies d'aventure est souvent résumée par le destin des condottieri, personnages emblématiques des difficultés politiques de la péninsule italienne, voire témoins d'une démilitarisation de la société citadine sur fond de crise des valeurs communales 1. L'accent mis sur ces ambitieux capitaines a inexorablement tourné les regards vers leur âge d'or, le Quattrocento, et attribué aux siècles précédents un rôle de faire-valoir introductif 2. Certes, on a voulu trouver les premiers condottieri dans l'Italie du second XIII e siècle; mais ils ne sont encore que de petits entrepreneurs maintenus dans les limites strictes d'un marché militaire, défini par des contrats déjà relativement standardisés 3. -

L U I I Storia Ii' Europa
B 510675 I s I CAMILLO MANFRONI L U I I STORIA II’ EUROPA E SPECIALMENTE D’ITALIA V o l u m e I I DAI TEMPI DI DANTE ALLA PACE DI ACQUISGRANA 1313-1748 Iconio i programmi del secondo corso.liceale Seconda edizione LIVORNO RAFFAELLO GIUSTI, EDITORE LIBRAIO-TIPOGRAFO 49-50. Ortu Carboni S. — Sunto di geometria elementare. Stereometria . L. 1 — 51. Pìttoni L. — Principi di prospettiva. 3a edizione ...................................... B — 50 52-53. Lazzeri G. — Manuale di trigonometria s fe r ic a ........ „ 1 — 54-55. Ortu Carboni S. — Esercizi di geometria elementare . „ 1 — 56. Bizzarrini G. — Nozioni di storia naturale. - I. Zoologia. 3»edizione . B — 50 57. Falorsi G. — Storia antica. - I. Storia greca. 2* edizione . „ — 50 58-59. —— Storia antica. - II. Storia romapa. 2a edizione . n 1 — 60. ...... M itologia. 2R e d i z i o n e .............................................................................................„ — 50 61. Gatti G. M. — Deutsche Granimatile . „ — 50 62. Cervi A. — La Metrica di Orazio per tavole sinottiche . „ — 50 63. Pierotti G. — Tavole sinottiche per analisi logica e sintassi della propo sizione nelle lingue italiana, latina e greca . „ — 50 64. Bizzarrini G. — Nozioni di storia naturale. - II. Botanica. 3a edizione . „ — 50 65. Cappelletti L. — Storia d'Italia dal 1493 al 1815. 2a edizione . B — 50 66-67. Visftlli P. — A lg e b r a .......................................................' ..............................................„ 1 — 68. Bizzarrini G. — Nozioni di storia naturale. - III. Mineralogia, geografia fisica e geologia. 2a e d iz io n e ...................................................................................„ — 50 69-70. Vigo P. — Storia generale del Medio Evo. 3a edizione . „ 1 — 71. Culi solo V. — Scienza delle fin a n z e _ 50 72. -
Italianpod101.Com Learn Italian with FREE Podcasts
1 ItalianPod101.com Learn Italian with FREE Podcasts Newbie 2 Italian Lessons 1-24 1-24 2 ItalianPod101.com Learn Italian with FREE Podcasts Introduction This is Innovative Language Learning. Go to InnovativeLanguage.com/audiobooks to get the lesson notes for this course and sign up for your FREE lifetime account. The course consists of lessons centered on a practical, real-life conversation. In each lesson, first, we'll introduce the background of the conversation. Then, you'll hear the conversation two times: One time at natural native speed and one time with the English translation. After the conversation, you'll learn carefully selected vocabulary and key grammar concepts. Next, you'll hear the conversation 1 time at natural native speed at the end of the lesson. Finally, practice what you have learned with the review track. In the review track, a native speaker will say a word or phrase from the dialogue, wait three seconds, and then give you the English translation. Say the word aloud during the pause. Halfway through the review track, the order will be reversed. The English translation will be provided first, followed by a three-second pause, and then the word or phrase from the dialogue. Repeat the words and phrases you hear in the review track aloud to practice pronunciation and reinforce what you have learned. Before starting the lessons, go to InnovativeLanguage.com/audiobooks to get the lesson notes for this course and sign up for your FREE lifetime account. LC: ABS_S1L1-25 © www.ItalianPod101.com - All Rights Reserved ItalianPod101.com Learn Italian with FREE Podcasts Newbie Lesson Have You Read Montale’s Poems? Italian 2 English 2 1 Vocabulary 2 Grammar Points 3 Cultural Insight 4 ItalianPod101.com Learn Italian with FREE Podcasts Italian Laura Hai letto le poesie di Eugenio Montale? John Ho preso la raccolta di poesie, ma io preferisco leggere la narrativa.