00-PRIME PP 2:Layout 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Auguste Rodin's 'The Burghers of Calais' and The
www.amatterofmind.us From the desk of Pierre Beaudry Page 1 of 15 AUGUSTE RODIN’S ‘THE BURGHERS OF CALAIS’ AND THE BLACK DEATH POLICY OF THE ENGLISH How Auguste Rodin created an artistic composition of axiomatic change. by Pierre Beaudry October 20, 2014 FOREWORD ``If a Black Death could spread throughout the world once in every generation, survivors could procreate freely without making the world too full.'' Bertrand Russell – 1949 ``In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation.'' Queen Elizabeth's consort Prince Philip – 1988 This is wake-up time. This report is a wake-up call attempting to answer a simple but difficult axiomatic question: “Why is it that American leaders and citizens don’t see that the plague of Ebola that is being brought to their doorsteps at this time is being carried out by the same people who brought about the Black Death to Europe during the fourteenth century?” The answer to that question can be found in the situation that the population of France found themselves into, when the King of England, Edward III, laid siege to the French town of Calais in 1346. www.amatterofmind.us From the desk of Pierre Beaudry Page 2 of 15 INTRODUCTION In his Chronicles, Jean Froissart (1337-1405), A French writer at the court of the King of England, told the story of how the French town of Calais’ people were spared a horrible death by the heroic action of six of their leaders, who voluntarily accepted to give their lives to save them from famine. -

Storico - Artistica
GUIDA STORICO - ARTISTICA DELL OSPITALE MAGGIORE DI MILANO. MILANO TIPOGRAFIA DI PIETRO AGNELLI Contr.’ del Morone N. 1166. 1857. GUIDA STORICO - ARTISTICA DELL’OSPITALE MAGGIORE DI MILANO. Il presente Libro è posto sotto la tutela delle vegliami Leggi, essendosi adempiuto a quanto esse prescrivono. Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti implorano ed ottengono da Pio II (Piccolomini) di erigere in Ospitale il loro palazzo, 1446. (L originale è nella chiesa dell’ ospitale). NOTIZIE STORICHE D E L GRAND’OSPITALE DI MILANO PROSPETTO CRONOLOGICO DEI RITRATTI DE' SUOI BENEF A T T ORI COLL’ELENCO DEGLI AUTORI E DESCRIZIONE DEI MONUMENTI DEDICATI A DIVERSI DISTINTI MEDICI E CHIRURGHI MILANO TIPOGRAFIA DI PIETRO AGNELLI Contr.'' del Morone N. 1166. 1857. PREFAZIONE V enne più volle ed ampiamente descritta e illustrala da eccellenti autori Ï architettura dell' Ospitale Maggiore di Milano. Tutto ciò che concerne così le rendite di que sto Stabilimento ed il modo con cui vengono erogate, come il numero degli infermi ai quali estende la sua beneficen za, la quantità delle malattie che si sono curate, il modo ed il risultamento delle cure, l'interno ordinamento di esso anche nei riguardi economici, con tutte le notizie statistiche e mediche relative a questo Nosocomio fu già esposto, e lo è di continuo, specialmente col mezzo dei dotti e ben ela borati rendiconti che l'esimia Direzione pubblica ogni anno. Ma, oltre agli accennati oggetti principali questo grande asilo della carità Milanese altri ne offre meritevoli della attenzione pubblica, e sui quali anzi è già desta la curiosità dei cittadini, che prendono a buon diritto vivo interessamento a tutto ciò che tocca i patrii monumenti. -

Sulla Riscoperta Di Ludovico De Donati: Spunti Dal Fondo Caffi *
SULLA RISCOPERTA DI LUDOVICO DE DONATI: SPUNTI DAL FONDO CAFFI * Come nel caso di altri artisti minori, Ludovico (o Alvise) de Donati rimase a lungo ignoto e la ricostruzione della sua carriera, precisata in maniera soddi- sfacente solo nell’arco degli ultimi decenni, iniziò nella metà del XVIII secolo 1. Il nome dell’artista sembra essere apparso per la prima volta nel 1752, quando il padre domenicano Agostino Maria Chiesa, spinto da intenti diversi dall’amore per l’arte, descrisse il trittico della chiesa di San Benigno a Berbenno (Sondrio) riportando l’iscrizione che lo dichiarava opera di «Aluisius de Donatis» 2. Questo ricordo tuttavia passò inosservato a causa della natura agiografica del testo. Al contrario fu prontamente registrato e godette di ampia diffusione il passo della Storia pittorica d’Italia (1795-1796) di Luigi Lanzi dove il pittore venne presentato come Luigi De Donati, comasco e discepolo del Civerchio, autore di non meglio specificate «tavole autentiche» 3. Come Lanzi stesso ammetteva, il giudizio su *) Desidero ringraziare il prof. Giovanni Agosti, per le preziose indicazioni bibliografiche, e Laura Andreozzi, per i suoi competenti consigli sulla stesura dell’Appendice. 1) Su Ludovico vd. Natale - Shell 1987, pp. 656-660; Porro 1990, pp. 399-416; Mascetti 1993, p. 91; Gorini 1993, pp. 449-450; Battaglia 1996, pp. 209-241; Natale 1998, pp. 65-68; Partsch 2001, pp. 499-502; Baiocco 2004, pp. 167-168. Riprende il problema dell’attività giovanile di Ludovico Bentivoglio Ravasio 2006, pp. 100-104. 2) Chiesa 1752, p. 170; già segnalato in Porro 1990, p. 416 nt. 52. -

Parrocchia Di San Giorgio in Jerago
Parrocchia di San Giorgio in Jerago Elenco dei Parroci A far tempo dal 1455 - Nel 1455 Macchi Dionigi Rettore - Dal 1559 al 1567 Uggeri Gerolamo - “ 1568 1587 Giussani Camillo - “ 1588 1596 Soldano Lazzaro - “ 1597 1601 Gattoni Gabriele - “ 1602 1609 Mazzucchelli Tommaso - “ 1609 1626 Curioni Antonio - “ 1626 1636 Coerezio Francesco - “ 1636 1675 Bonomi Giovanni - “ 1675 1704 Onetti Giuseppe - “ 1705 1732 Pozzi Carlo Francesco - “ 1732 1750 Mazzucchelli G. Battista - “ 1750 1784 Fontana Carlo Antonio - “ 1784 1797 Pellegatta Giuseppe Maria - “ 1797 1824 Castagnola Giovanni - “ 1824 1869 Moroni G.Battista - “ 1870 1873 Rossi Carlo - “ 1874 1881 Pessina Giuseppe - “ 1881 1916 Nebuloni Angelo - “ 1917 1945 Cervini Massimo - “ 1945 1952 Crespi Carlo - “ 1952 1987 Mauri Luigi - “ 1987 2006 Cassani Angelo - - “ dal 2007 è Parroco Ciapparella Remo Fin verso il 1800 il Parroco di Orago era vice parroco di Jerago Coadiutori o Vice-Parroci - Dal 1955 al 1962 Don Ausonio Colombo ( nato 20-11-1931) Parroco a Clivio - Dal 1962 al 1965 Don Luigi Colnaghi ( poi parroco di Cocquio Trevisago) Vicario per aiuto domenicale - Dal 1965 al 1974 Don Mario Panizza ( dott. Prof. Presso il Seminario Maggiore) 1 Visite pastorali - Mons Gabriele Sforza, 3-5 agosto 1455 - Card. Carlo Borromeo, 2 luglio 1570 - Mons Gaspare Visconti , 12 agosto 1586 - Card Federico Borromeo, 18 novembre 1606 - Card Federico Borromeo ottobre 1620 - Card Cesare Monti 21 settembre 1646 - Card Federico Visconti 29 giugno 1684 - Card Giuseppe Pozzobonelli 18 maggio 1750 - Card Andrea Carlo Ferrari 18-19 gennaio 1899 - Card Andrea Carlo Ferrari 18-19 ottobre 1903 - Card Andrea Carlo Ferrari 24-25 ottobre 1911 - Card Andrea Carlo Ferrari 26-27 luglio 1917 - Card Eugenio Tosi 20-21 agosto 1927 - Card Ildefonso Schuster 13-14 sett.1932 - Card Ildefonso Schuster 26-27 ottobre 1938 - Card Ildefonso Schuster 10-11 ottobre 1948 - Card Ildefonso Schuster 13-14 ottobre 1953 - Card. -

Tc Ankara Ünġversġtesġ Sosyal Bġlġmler Enstġtüsü
T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ORTAÇAĞ TARĠHĠ BĠLĠM DALI GEÇ ORTAÇAĞ’DA ĠTALYA’NIN SĠYASĠ DURUMU Yüksek Lisans Tezi Sait Emre ÇİFTÇİ Ankara-2019 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ORTAÇAĞ TARĠHĠ BĠLĠM DALI GEÇ ORTAÇAĞ’DA ĠTALYA’NIN SĠYASĠ DURUMU Yüksek Lisans Tezi Sait Emre ÇİFTÇİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Hatice ORUÇ Ankara-2019 II ONAY TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ORTAÇAĞ TARĠHĠ BĠLĠM DALI Sait Emre ÇİFTÇİ GEÇ ORTAÇAĞ’DA ĠTALYA’NIN SĠYASĠ DURUMU Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice ORUÇ Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Ġmzası .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ Tez Sınavı Tarihi .................................. III T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BĠLDĠRĠM Bu belge ile, tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak -

R. Deputazione Di Storia Patria Per La Liguria
R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA LIGURIA SEZIONE DI SAVONA ATTI Vol. XXIII SAVONA Tipografia Savonese Piana Monlicello, 2 1941 - A. XIX $ . Biblioteca Storia Patria SV s-sv-sv 0001 SSSP sv 03 023 SVAGHI STORICI L' AREA EDILIZIA DI SAVONA DALLE ORIGINI AL SEC. XIX — Barriliana — Un’opera inedita di B. Mat- tiauda — La pitonessa di Celle — Un frate CRONISTA IN PIENO RlSORGIMENTO. PER ITALO SCOVAZZI 1. L’area edilizia di Savona dalle origini al sec. XIX. I l forestiero che, dopo aver letto una storia di Savona, ad esempio quella più ampia e recente di I. Scovazzi e F. No- berasco, sentisse vaghezza di visitare il teatro della più che bimillenaria vita savonese, e di interrogare le pietre, testi moni eloquentissimi, resterebbe forse deluso. Le devasta zioni genovesi e gli ultimi cento anni hanno distrutto più che dieci incursioni di Longobardi e di Saraceni. Tuttavia col sussidio dei pochi monumenti rimasti, di anticaglie dissepolte, di testimonianze lontane, possiamo for marci un’idea abbastanza precisa della città, quale essa era nei secoli dell’ età media. E’ ormai indubbio che il promontorio di Priamar, unito al Monticeli© da un sottile istmo e perciò asilo sicuro con tro gli assalti degli uomini e delle fiere, fu sede di Liguri sin dall’età della pietra. Il luogo, romanizzato, fu durante l’Impero soverchiato da Vado; tracce sicuramente romane vennero in luce, ed altre potranno scoprirsi con scavi diligenti nella nostra archeologica. Il porto di Savona, che compare già durante la seconda guerra punica, dovette certo, fin dall’età romana, estendere f oppido dal promontorio a parte dell’ istmo e provocare la costruzione di nuove opere. -

Nuova Gabbia
Luchino Visconti, Jacopo da Bologna and Petrarch: Courting a Patron* Elena Abramov-van Rijk In the musical repertory of the Trecento, no more than four compositions are unequivocally dedicated to a contemporary secular ruler: two madrigals, Lo lume vostro and O in Italia , and two motets, Lux purpurata/Diligite iustitiam and Laudibus dignis . The addressee of all four is the Milanese ruler Luchino Visconti (ca. 1292- 1349): the madrigal Lo lume vostro contains the acrostic LUCHINUS, and the motets have LUCHINUS VICECOMES and LUCHINUS DUX respectively; the madrigal O in Italia provides information on the birth of Luchino’s twin sons, Luchino Novello and Giovanni, on Friday, August 4, 1346. Whereas the first three * The first part of this article was presented at the Medieval and Renaissance Music conference in Barcelona, July 2011. I am grateful to Dorothea Baumann and Aldo Menichetti for their help in the early stages of this work, to Lucia Marchi for her suggestions, and to Sergei Abir. I owe my special thanks to Bonnie Blackburn and Leofranc Holford-Strevens for their comments and advice, and my kind regards to Biblioteca Medicea Laurenziana in Florence and Biblioteca Uni - versitaria in Padua for the permission of reproducing. Abbreviations used: FP Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Panciatichiano 26 Pit Paris, Bibliothèque Nationale de France, f. it. 568 Reina Paris, Bibliothèque Nationale de France, n. acq. fr. 6771 (Reina Codex) SL Firenze, San Lorenzo, Archivio Capitolare 2211 Sq Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Palatino 87 (Squarcialupi Codex) 7 elena abramov-van rijk compositions are known to have been written by Jacopo da Bologna, the motet Laudibus dignis is transmitted anonymously and fragmentarily: only one voice, apparently a triplum , has survived. -

Castelli, Rocche E Torri
“Popoli abituati da secoli a governarsi da sé, “Populations for centuries used to governing popoli ricchi di tradizioni proprie, sviluppatesi themselves, rich populations with their own in lunghi secoli di vita politica autonoma, popo- traditions, developed over centuries of independent li disciplinati nel loro spirito di libertà, …”. political life, populations that are disciplined in their (Emile Chanoux, da “Federalismo e Autonomie”, freedom…”. 1943). (Emile Chanoux, from “Federalism and Autonomy”, 1943). La provincia di Varese è territorio di frontiera, con- The province of Varese is a borderland that was tesa dalle moltissime signorie del luogo tra l’XI e il contended by many seignories between the 11th XV secolo. I castelli e le torri di segnalazione and 15th centuries. It is a land dotted with castles segnano il territorio profondamente. Hanno ormai and lookout towers that have now lost their role as perduto le caratteristiche di strutture difensive, defensive structures, becoming “delightful villas” for diventando " ville di delizie " per lo svago dei the lords that built them. Nevertheless, due to the signori che le avevano edificate. Ma proprio per la very fact that they mark the territory, they represent caratteristica di aver segnato il territorio, costitui- a still visible system that shapes a land of lakes, scono un sistema ancora percepibile, che dà plains and mountains and bear witness to the wealth forma alla terra situata tra laghi, pianure e monta- and industriousness of the past. gne, a testimonianza della ricchezza e della labo- riosità del passato. Castiglione Olona: La Collegiata Affreschi di Masolino da Panicale 1 ANGERA Rocca Borromeo (Info: 0331 931300) La Rocca sorge su uno sperone roccioso in vista Rocca Borromeo of Angera di Arona, del Lago Maggiore e del territorio vare- sino. -

Conservation of the Courthouse of Milan
POLITECNICO DI MILANO Laurea Magistrale (MSc) in Building and Architectural Engineering CONSERVATION OF THE COURTHOUSE OF MILAN Supervisor: PROF. ARCH. Elisabetta ROSINA Thesis by : Baris Demirel - 840553 Liu Yuheng - 840629 Lu Shan - 832833 INDEX ABSTRACT 1 ABSTRACT (Italian Version) 2 1. INTRODUCTION 3 1.1 - Information on Milan 3 1.1.1 - Geographical context 3 1.1.1.1 - Climate 4 1.1.1.2 - Population 5 1.1.1.3 - Education 7 1.1.1.4 - Art & culture 9 1.1.1.5 - Economy 10 1.1.1.6 - Transportation 11 1.1.2 - The events leading to Courthouse of Milan 12 1.2 - Information on the Courthouse 16 1.2.1 - Historical synopsis 16 1.2.2 - Architectural information 29 1.2.2.1 - Design 29 1.2.2.2 - Distribution of the spaces 31 1.2.2.3 - Circulation in the environment 34 1.2.2.4 - Metric data 35 1.2.2.5 - Architectural drawings 36 1.2.2.5.1 - Plans 36 1.2.2.5.2 - Elevations 44 1.2.2.5.3 - Partial sections and elevations 45 1.2.3 - Technical information 47 1.2.3.1 - Construction 47 1.2.3.2 - Structure data and conditions 51 1.2.3.3 - Materials 53 1.2.3.4 - Technical equipments 54 1.2.3.4.1 - Doors and windows 54 1.2.3.4.2 - Lighting equipments 57 1.2.3.4.3 - Water and health services 58 1.2.3.4.4 - Heating and air-conditioning system 60 1.2.3.4.5 - Electrical system 62 1.2.4 - Courthouse of Milan as an art gallery 66 1.2.4.1 - Information 66 1.2.4.2 - Artworks on the ground floor 70 1.2.4.3 - Artworks on the first floor 71 1.2.4.4 - Artworks on the third floor 79 1.3 - SWOT analyses 89 1.3.1 - Analysis on Milan 89 1.3.2 - Analysis on the Courthouse 90 2. -

And Surrounding Mountains Sales Guide 2016
Lake Ma GGiore and SurroundinG MountainS Sales Guide 2016 . 2017 Sales Guide Highlights Quick Guide 2016 / 2017 Contents BORROMEO ISLANDS Central Lago incontrovertibly the heart of Lago Maggiore and a place of art “par excellence”: isola Bella, isola Madre and isola dei Pescatori. Situated in the Gulf of Borromeo, all three of them have fascinated people throughout history: with the art and culture of a great ruling dynasty: the General information 4 Borromeo family. there are so many attractions for the visitor to wonder at: grandiose ter- Map raced gardens with palazzo, an authentic fishing village with picturesque houses, one of the most spectacular botanic gardens anywhere in the world with many exotic plants – and so Travel information Isola dei Pescatori much more. Taxiboats, Shipyards and Boat Rental Services Coach Rental Services VILLA TARANTO Verbania-Pallanza Golf Courses a villa built in the 1830s by a Scot, Captain neil Mceacharn, and in the meantime one of the richest botanical gardens in the world. With thousands of plant species – eucalyptus, azalea, Events rhododendron, magnolia, maple, camellia and dahlia, it stretches over an area measuring 16 hectares. upper Lago 9 PARcO NAzIONALE VAL GRANDE Ossola Valleys Central Lago 13 this national park situated between the Val d’ossola, the Val Vigezzo and Lago Maggiore the Gardens of Villa Taranto measures 15,000 hectars and is noted as the largest integrated natural wild reserve in italy; Lower Lago 19 here nature has been preserved in all its primal wildness. east Shore and Varese 22 ISOLA DI S. GIuLIO Lake Orta Legend has it that S. -
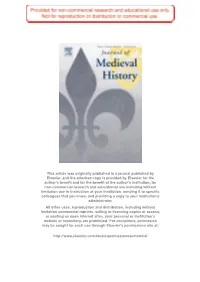
This Article Was Originally Published in a Journal Published by Elsevier
This article was originally published in a journal published by Elsevier, and the attached copy is provided by Elsevier for the author’s benefit and for the benefit of the author’s institution, for non-commercial research and educational use including without limitation use in instruction at your institution, sending it to specific colleagues that you know, and providing a copy to your institution’s administrator. All other uses, reproduction and distribution, including without limitation commercial reprints, selling or licensing copies or access, or posting on open internet sites, your personal or institution’s website or repository, are prohibited. For exceptions, permission may be sought for such use through Elsevier’s permissions site at: http://www.elsevier.com/locate/permissionusematerial Journal of Medieval History 33 (2007) 1e32 www.elsevier.com/locate/jmedhist Contra damnationis filios: the Visconti in fourteenth-century papal diplomacy Sharon Dale Humanities and Social Sciences, Penn State-Erie, The Behrend College, Station Road, Erie, PA 16363-1501, USA Abstract This article seeks to reappraise the relationship between the Avignon papacy and the Visconti lords of Milan during the fourteenth century. Avignon popes generally viewed the Visconti as the major obstacle to papal temporal power in Italy and thus fashioned propaganda that demonised them. This mythic portrayal, that was re-framed by Florence to justify its own imperialistic ambitions in Tuscany, has been accepted uncritically by modern historiography. Documents from the Vatican archive reveal a more complicated diplomacy. Papal policy toward the Visconti was far from consistent, as the curia welcomed Visconti money and Avignonese popes regularly granted the Visconti papal vicariates. -

Painting Practice in Milan in the 1490S: the Influence of Leonardo
National Gallery Technical Bulletin volume 32 Leonardo da Vinci: Pupil, Painter and Master National Gallery Company London Distributed by Yale University Press TB32 prelims exLP 10.8.indd 1 12/08/2011 14:40 This edition of the Technical Bulletin has been funded by the American Friends of the National Gallery, London with a generous donation from Mrs Charles Wrightsman Series editor: Ashok Roy Photographic credits © National Gallery Company Limited 2011 All photographs reproduced in this Bulletin are © The National Gallery, London unless credited otherwise below. All rights reserved. No part of this publication may be transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including BRISTOL photocopy, recording, or any storage and retrieval system, without © Photo The National Gallery, London / By Permission of Bristol City prior permission in writing from the publisher. Museum & Art Gallery: fig. 1, p. 79. Articles published online on the National Gallery website FLORENCE may be downloaded for private study only. Galleria degli Uffizi, Florence © Galleria deg li Uffizi, Florence / The Bridgeman Art Library: fig. 29, First published in Great Britain in 2011 by p. 100; fig. 32, p. 102. © Soprintendenza Speciale per il Polo Museale National Gallery Company Limited Fiorentino, Gabinetto Fotografico, Ministero per i Beni e le Attività St Vincent House, 30 Orange Street Culturali: fig. 1, p. 5; fig. 10, p. 11; fig. 13, p. 12; fig. 19, p. 14. © London WC2H 7HH Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, Gabinetto Fotografico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Photo Scala, www.nationalgallery. org.uk Florence: fig. 7, p.