VISCONTI (I-II) Inkl De ROTARIIS (Aus Revigliasco D' Asti)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Between Power and Rebellion: Rethinking Authority
EDGAR STRAEHLE* BETWEEN POWER AND REBELLION: RETHINKING AUTHORITY Entre poder e rebelião: repensar a autoridade Resumo Um dos principais objectivos deste escrito é dissociar e desembaraçar os conceitos de autoridade e poder à luz das insurreiçãos medievais e lutas na ciudade de Milão e, além disso, compreender na dimensão ambivalente e ambígua da autoridade. Ao analisar estes fatos históricos, vou tentar mostrar que a autoridade não pertence sempre ou necessariamente ao governo ou que somente pode ser um instrumento deste. De fato, é mais interessante explorar o outro lado desta questão: como o uso da autoridade pôde devenir um instrumento de contrapoder. Neste sentido, vou examinar como e porquê algumas rebeliões contestaram o poder não apenas combatendo a autoridade oficial mas reivindicando uma alternativa. Ou seja, como e porquê a categoria de auto- ridade pôde tornarse uma fonte de legitimidade da insurreição. Palavras-chave: autoridade; poder; rebelião. Authors: Santo Ambrósio; Hannah Arendt. * Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) and University of Barcelona (ADHUC). Email: [email protected]. This work has been written with the support of the research group «La transmisión desde el pensamiento filosófico femenino» (FFI2015-63828-P, MINECO/FEDER, UE) and the GRC «Creació i pensament de les dones» (2014 SGR44) of the University of Barcelona. The writing of this paper would have been impossible without the generous help of Emily McBride and Meritxell Joan. I am really indebted to them and I thank their tips and corrections. Filosofia. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 33 (2016) 273-285 273 DOI: http://dx.doi.org/10.21747/21836892/fil33a17 EDGAR STRAEHLE Abstract One of the main goals of this paper is to dissociate and disentangle the concepts of power and authority in light of the late medieval insurrections and fights in thecom - mune of Milan and, then, to comprehend the ambivalent and ambiguous dimension of authority. -

Bells and Trumpets, Jesters and Musici: Sounds and Musical Life in Milan Under the Visconti
Lorenzo Tunesi – Bells and Trumpets, Jesters and Musici 1 Bells and Trumpets, Jesters and Musici: Sounds and Musical life in Milan under the Visconti Or questa diciaria, Now [I conclude] my speech, perché l’Ave Maria since the Ave Maria sona, is ringing, serro la staciona I shut up shop nén più dico1 and I won’t talk anymore These verses, written by the Milanese poet and wealthy member of the ducal chancellery Bartolomeo Sachella, refer to a common daily sound in late Medieval Milan. The poet is quickly concluding his poem, since the Ave Maria is already sounding. When church-bells rang the Ave Maria, every citizen knew, indeed, that the working-day was over; thus, probably after the recitation of a brief prayer in honour of the Virgin, shops closed and workers went home. Church-bells were only one of the very large variety of sounds characterising Medieval cities. Going back over six-hundred years, we could have been surrounded by city-criers accompanied by trumpet blasts, people playing music or singing through the streets, beggars ringing their bells asking for charity, mothers’ and children’s voices, horses’ hoofs and many other sounds. All these sounds created what musicology has defined as ‘urban soundscape’, which, since the pioneering study by Reinhard Strohm, Music in Late Medieval Bruges (1985), has deeply intrigued music historians. The present essay aims to inquire into the different manifestations of musical phenomena in late Medieval Milan, relating them to the diverse social, cultural and historical contexts in which they used to take place. My research will focus on a time frame over a century, ca. -

Duchess and Hostage in Renaissance Naples: Letters and Orations
IPPOLITA MARIA SFORZA Duchess and Hostage in Renaissance Naples: Letters and Orations • Edited and translated by DIANA ROBIN and LYNN LARA WESTWATER Iter Press Toronto, Ontario Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Tempe, Arizona 2017 Sforza_book.indb 9 5/25/2017 10:47:22 AM Iter Press Tel: 416/978–7074 Email: [email protected] Fax: 416/978–1668 Web: www.itergateway.org Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Tel: 480/965–5900 Email: [email protected] Fax: 480/965–1681 Web: acmrs.org © 2017 Iter, Inc. and the Arizona Board of Regents for Arizona State University. All rights reserved. Printed in Canada. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Sforza, Ippolita, 1445-1488, author. | Robin, Diana Maury, editor, translator. | Westwater, Lynn Lara, editor, translator. Title: Duchess and hostage in Renaissance Naples : letters and orations / Ippolita Maria Sforza ; edited and translated by Diana Robin, Lynn Lara Westwater. Description: Tempe, Arizona : Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies ; Toronto, Ontario : Iter Press : Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2017. | Series: Medieval and Renaissance Texts and Studies ; 518 | Series: The Other Voice in Early Modern Europe. The Toronto Series, 55 | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2016059386 | ISBN 9780866985741 (pbk. : alk. paper) Subjects: LCSH: Sforza, Ippolita, 1445-1488—Correspondence. | Naples (Kingdom)—Court and courtiers—Correspondence. | Naples (Kingdom)—History—Spanish rule, 1442-1707--Sources. Classification: LCC DG848.112.S48 A4 2017 | DDC 945/.706092 [B]—dc23 LC record available at https://lccn.loc.gov/2016059386 Cover illustration: Pollaiuolo, Antonio del (1433-1498), Portrait of a Young Woman, ca. -

La Lotta Per Il Potere a Milano
LA GRANDE BATTAGLIA Nel corso del 1276, non si hanno notizie circa il periodo dell’anno, le forze viscontee cominciarono ad organizzare un attacco, nelle intenzioni decisivo, nei confronti dei Torriani. Goffredo da Langosco, alla testa dei fuoriusciti milanesi, occupò inizialmente Arona, unitamente ad alcune postazioni strategiche dell’Ossola, le cui popolazioni erano fedeli all’arcivescovo. Intanto Ottone Visconti riusciva a sbarcare ad Angera con tre-quattromila uomini e ad occuparne la rocca. Napo della Torre, benché colto di sorpresa, reagì inviando nella zona il figlio Cassone che, con una schiera di cinquecento tedeschi fornitagli dall’imperatore Rodolfo d’Asburgo, riuscì a mettere sotto assedio il castello di Angera. Nel frattempo Goffredo da Langosco, insieme ad un esercito di quattro-cinquemila armati composto da fuoriusciti milanesi, uomini del Seprio e di Pavia, oltre che da genovesi e spagnoli, ingrossato oltretutto da locali fedeli a Ottone, muovendo da Arona riuscì ad occupare buona parte del Seprio settentrionale dirigendosi poi verso Angera. Cassone della Torre aveva intanto preso posizione nella piana del torrente Guassera, nei pressi della riva del Lago Maggiore al confine tra gli odierni comuni di Ranco e Ispra. Il momento della verità era ormai arrivato… Le forze torriane furono all’improvviso raggiunte dall’esercito visconteo che proveniva da Nord e cioè dal territorio isprese. Goffredo da Langosco, sfruttando l’elemento sorpresa, non si lasciò sfuggire l’occasione di attaccare i soldati teutonici di Cassone mentre stavano ancora approntando l’accampamento. Durante l’attacco, superato di slancio dai Viscontei il rio Guassera, lo stesso capo dei tedeschi, Hans Lauser, venne ucciso: forse proprio da Goffredo in persona. -

Storico - Artistica
GUIDA STORICO - ARTISTICA DELL OSPITALE MAGGIORE DI MILANO. MILANO TIPOGRAFIA DI PIETRO AGNELLI Contr.’ del Morone N. 1166. 1857. GUIDA STORICO - ARTISTICA DELL’OSPITALE MAGGIORE DI MILANO. Il presente Libro è posto sotto la tutela delle vegliami Leggi, essendosi adempiuto a quanto esse prescrivono. Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti implorano ed ottengono da Pio II (Piccolomini) di erigere in Ospitale il loro palazzo, 1446. (L originale è nella chiesa dell’ ospitale). NOTIZIE STORICHE D E L GRAND’OSPITALE DI MILANO PROSPETTO CRONOLOGICO DEI RITRATTI DE' SUOI BENEF A T T ORI COLL’ELENCO DEGLI AUTORI E DESCRIZIONE DEI MONUMENTI DEDICATI A DIVERSI DISTINTI MEDICI E CHIRURGHI MILANO TIPOGRAFIA DI PIETRO AGNELLI Contr.'' del Morone N. 1166. 1857. PREFAZIONE V enne più volle ed ampiamente descritta e illustrala da eccellenti autori Ï architettura dell' Ospitale Maggiore di Milano. Tutto ciò che concerne così le rendite di que sto Stabilimento ed il modo con cui vengono erogate, come il numero degli infermi ai quali estende la sua beneficen za, la quantità delle malattie che si sono curate, il modo ed il risultamento delle cure, l'interno ordinamento di esso anche nei riguardi economici, con tutte le notizie statistiche e mediche relative a questo Nosocomio fu già esposto, e lo è di continuo, specialmente col mezzo dei dotti e ben ela borati rendiconti che l'esimia Direzione pubblica ogni anno. Ma, oltre agli accennati oggetti principali questo grande asilo della carità Milanese altri ne offre meritevoli della attenzione pubblica, e sui quali anzi è già desta la curiosità dei cittadini, che prendono a buon diritto vivo interessamento a tutto ciò che tocca i patrii monumenti. -

Parrocchia Di San Giorgio in Jerago
Parrocchia di San Giorgio in Jerago Elenco dei Parroci A far tempo dal 1455 - Nel 1455 Macchi Dionigi Rettore - Dal 1559 al 1567 Uggeri Gerolamo - “ 1568 1587 Giussani Camillo - “ 1588 1596 Soldano Lazzaro - “ 1597 1601 Gattoni Gabriele - “ 1602 1609 Mazzucchelli Tommaso - “ 1609 1626 Curioni Antonio - “ 1626 1636 Coerezio Francesco - “ 1636 1675 Bonomi Giovanni - “ 1675 1704 Onetti Giuseppe - “ 1705 1732 Pozzi Carlo Francesco - “ 1732 1750 Mazzucchelli G. Battista - “ 1750 1784 Fontana Carlo Antonio - “ 1784 1797 Pellegatta Giuseppe Maria - “ 1797 1824 Castagnola Giovanni - “ 1824 1869 Moroni G.Battista - “ 1870 1873 Rossi Carlo - “ 1874 1881 Pessina Giuseppe - “ 1881 1916 Nebuloni Angelo - “ 1917 1945 Cervini Massimo - “ 1945 1952 Crespi Carlo - “ 1952 1987 Mauri Luigi - “ 1987 2006 Cassani Angelo - - “ dal 2007 è Parroco Ciapparella Remo Fin verso il 1800 il Parroco di Orago era vice parroco di Jerago Coadiutori o Vice-Parroci - Dal 1955 al 1962 Don Ausonio Colombo ( nato 20-11-1931) Parroco a Clivio - Dal 1962 al 1965 Don Luigi Colnaghi ( poi parroco di Cocquio Trevisago) Vicario per aiuto domenicale - Dal 1965 al 1974 Don Mario Panizza ( dott. Prof. Presso il Seminario Maggiore) 1 Visite pastorali - Mons Gabriele Sforza, 3-5 agosto 1455 - Card. Carlo Borromeo, 2 luglio 1570 - Mons Gaspare Visconti , 12 agosto 1586 - Card Federico Borromeo, 18 novembre 1606 - Card Federico Borromeo ottobre 1620 - Card Cesare Monti 21 settembre 1646 - Card Federico Visconti 29 giugno 1684 - Card Giuseppe Pozzobonelli 18 maggio 1750 - Card Andrea Carlo Ferrari 18-19 gennaio 1899 - Card Andrea Carlo Ferrari 18-19 ottobre 1903 - Card Andrea Carlo Ferrari 24-25 ottobre 1911 - Card Andrea Carlo Ferrari 26-27 luglio 1917 - Card Eugenio Tosi 20-21 agosto 1927 - Card Ildefonso Schuster 13-14 sett.1932 - Card Ildefonso Schuster 26-27 ottobre 1938 - Card Ildefonso Schuster 10-11 ottobre 1948 - Card Ildefonso Schuster 13-14 ottobre 1953 - Card. -
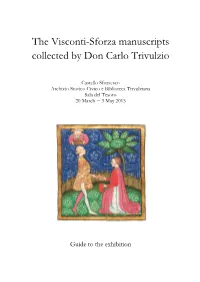
The Visconti-Sforza Manuscripts Collected by Don Carlo Trivulzio
The Visconti-Sforza manuscripts collected by Don Carlo Trivulzio Castello Sforzesco Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana Sala del Tesoro 20 March ~ 3 May 2015 Guide to the exhibition I manoscritti visconteo sforzeschi di don Carlo Trivulzio Una pagina illustre di collezionismo librario nella Milano del Settecento Milano · Castello Sforzesco Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana · Sala del Tesoro 20 marzo ~ 3 maggio 2015 Sindaco Mostra a cura di Giuliano Pisapia Isabella Fiorentini, Marzia Pontone Assessore alla Cultura Testi di Filippo Del Corno Marzia Pontone Direttore Centrale Cultura Redazione e revisione Giuliana Amato Loredana Minenna Direttore Settore Soprintendenza Castello, Manutenzione conservativa Musei Archeologici e Musei Storici Stefano Dalla Via Claudio Salsi Segreteria amministrativa Ufficio Stampa Luca Devecchi Elena Conenna Coordinamento logistico e sicurezza Luigi Spinelli Allestimenti CSC Media Soprintendente Castello Sforzesco Claudio Salsi Traduzioni Promoest Srl – Ufficio Traduzioni Milano Responsabile Servizio Castello Giovanna Mori Fotografie Comunicazione Officina dell’immagine, Luca Postini Maria Grazia Basile Saporetti Immagini d’arte Colomba Agricola Servizio di custodia Corpo di Guardia del Castello Sforzesco Archivio Storico Civico Biblioteca Trivulziana Si ringraziano Rachele Autieri, Lucia Baratti, Piera Briani, Mariella Chiello, Civica Stamperia, Ilaria De Palma, Funzionario Responsabile Benedetta Gallizia di Vergano, Isabella Fiorentini Maria Leonarda Iacovelli, Arlex Mastrototaro, -
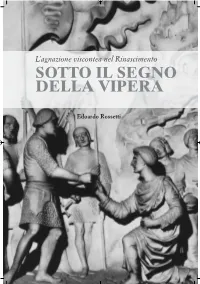
00-PRIME PP 2:Layout 1
L’agnazione viscontea nel Rinascimento SOTTO IL SEGNO DELLA VIPERA Edoardo Rossetti «In Milano la più degna e nobile fameglia è la Visconta» scriveva nel 1520 l’oratore veneto Gianiacopo Caroldo. Quella che rimaneva, nonostante l’estinzione del ramo ducale, la più importante agnazione di Milano non è stata sinora adeguatamente studiata, né nella geografia castel- lana delle sue numerose signorie, né nelle articolazioni delle sue iniziative politiche, né nella sua presenza culturale nello stato di Milano. È specialmente su quest’ultimo as- petto che si incentra questo volume. Attraverso un’ampia ricerca archivistica e iconografica largamente inedita ven- gono ricostruiti importanti episodi di committenza delle famiglie principali della parentela viscontea che si intrec- ciano a comporre una politica artistica di ampio respiro, tale da incidere profondamente sul territorio: da Milano a Somma Lombardo, da Pallanza a Brignano, da Vignate a Santa Maria del Monte sopra Varese. Edoardo Rossetti (Varese, 1979) si è laureato nel 2006 in Storia presso l’Università degli Studi di Milano è autore di numerosi saggi sulla storia politica, sociale, artistica e cul- turale del Rinascimento lombardo; coordina la collana Scaglie d’archivio dell’Archivio di Stato di Milano, per la quale ha curato il volume Squarci d’interni. FESR Fondo europeo di sviluppo regionale - Le opportunità non hanno confini Sotto il segno della vipera In copertina Gian Cristoforo Romano e collaboratori, Gian Galeazzo Visconti riceve la signoria di Milano, particolare del Monumento -

Sir John Hawkwood (L'acuto) Story of a Condottiere; Translated from The
SIR JOHN HAWKWOOD. Only Five hundred copies have been printed of " " Sir John Hawkwood, one hundred reserved for presentation to the Public Libraries, the Press, and Friends and hundred , Four numbered copies for the Public of which this is N 5. \IHIh JMVSIAOtAETAIfc SIR JOHN HAWKWOOD (V ACUTO). STORY OF A CONDOTTIERE TRANSLATED FROM THE ITALIAN OF JOHN TEMPLE-LEADER, ESQ. & SIG. GIUSEPPE MARCOTT1 BY LEADKR SCOTT. Bonbon, T. FISHEE UNWIN 26, PATERNOSTER SQUARE. 1889. [All rights reserved.} ^. FLORENCE : PRINTED BY . BARBERA, VIA FAENZA, 66. H4-L4- PREFACE. Alius alio jdttra incenire potest, nemo ontnia. Ausomus. The history of the mercenary companies in Italy no longer re- mains to be told it been in 1844 Ercole Ricotti ; having published by ; however, several successive monographs on the same subject have produced such a wealth of information from new sources that Ri- cotti's work, estimable as it is, almost requires to be rewritten. The Archlvio Storico Italiano has already recognised this by dedicat- ing an entire volume to Documents for the history of Italian ivarfare, from the 13"1 to the 16"1 centuries collected by Giuseppe Canestrini. These are of but even all great importance ; taking into account we owe to them, and to all that later historical researches have brought to light, the theme is not yet exhausted : truth is like happiness, and though as we approach we see it shining more intensely, and becom- ing clearer in outline, yet we can never feel, that we have obtained full possession of it. One of the most celebrated condottieri -

Sir John Hawkwood (L'acuto) : Story of a Condottiere
' - J~" - - - - |^l rirUfriiil[jiiTlffuflfim]f^ i i THE LIBRARIES 1 | i COLUMBIA UNIVERSITY [^I | 11 I i | 1 I i General Library s I i 1 SIR JOHN HAWKWOOD. Only Five hundred copies have been printed of Sir John Hawkwood, " one hundred reserved for presentation to the Public Libraries, the Press, and Friends .• and Four hundred numbered copies for the Public of which this is N° 336. jS^jA^Mfr S I It JOHN HAWKWOOD (/: act TO). STORY OF A CONDOTTIERE I'KANSLATKI' FROM 11IK ITALIAN JOHN TEMPLE-LEADER. Esq. & Sis. GIUSEPPE MARCOTTI BY LEADER SCOTT. ITonbon, T. FISHER UN WIN 26. PATERNOSTBB SQUARE. 1889. [AN rights reserved.] L / FLORENi i PRINTED BY <. BARBERA, VIA FAENZA, 66 ; PREFACE. nemo ami \v- 'INK'S. The hi orj of.the mercenarj companies in ttalj ao longer re- mains to be told; if having been published in 1844 by Ercole Ricotti howe sive monographs on the same subject hi ve produced such a wealth of information from new sources thai Ri- i • cotti's work, . dmosi requires to be rewritten. The Archicio Stortco Italiano has already recognised this by dedicat- ing an entire volume to Documents for the history of Italian war\ from tin 13"' to the 16"' centuries collected by Giuseppe Canestrini. These re oi Sfreat importance; but even taking into account all we owe to them, and to all thai later historical researches have brought to light, the theme is not yet exhausted: truth is like happiness, and though as we approach we see it shining mure intensely, and becom- ing clearer in outline, yel we can never feel, thai we have obtained full possession of it. -

Castelli, Rocche E Torri
“Popoli abituati da secoli a governarsi da sé, “Populations for centuries used to governing popoli ricchi di tradizioni proprie, sviluppatesi themselves, rich populations with their own in lunghi secoli di vita politica autonoma, popo- traditions, developed over centuries of independent li disciplinati nel loro spirito di libertà, …”. political life, populations that are disciplined in their (Emile Chanoux, da “Federalismo e Autonomie”, freedom…”. 1943). (Emile Chanoux, from “Federalism and Autonomy”, 1943). La provincia di Varese è territorio di frontiera, con- The province of Varese is a borderland that was tesa dalle moltissime signorie del luogo tra l’XI e il contended by many seignories between the 11th XV secolo. I castelli e le torri di segnalazione and 15th centuries. It is a land dotted with castles segnano il territorio profondamente. Hanno ormai and lookout towers that have now lost their role as perduto le caratteristiche di strutture difensive, defensive structures, becoming “delightful villas” for diventando " ville di delizie " per lo svago dei the lords that built them. Nevertheless, due to the signori che le avevano edificate. Ma proprio per la very fact that they mark the territory, they represent caratteristica di aver segnato il territorio, costitui- a still visible system that shapes a land of lakes, scono un sistema ancora percepibile, che dà plains and mountains and bear witness to the wealth forma alla terra situata tra laghi, pianure e monta- and industriousness of the past. gne, a testimonianza della ricchezza e della labo- riosità del passato. Castiglione Olona: La Collegiata Affreschi di Masolino da Panicale 1 ANGERA Rocca Borromeo (Info: 0331 931300) La Rocca sorge su uno sperone roccioso in vista Rocca Borromeo of Angera di Arona, del Lago Maggiore e del territorio vare- sino. -

Conservation of the Courthouse of Milan
POLITECNICO DI MILANO Laurea Magistrale (MSc) in Building and Architectural Engineering CONSERVATION OF THE COURTHOUSE OF MILAN Supervisor: PROF. ARCH. Elisabetta ROSINA Thesis by : Baris Demirel - 840553 Liu Yuheng - 840629 Lu Shan - 832833 INDEX ABSTRACT 1 ABSTRACT (Italian Version) 2 1. INTRODUCTION 3 1.1 - Information on Milan 3 1.1.1 - Geographical context 3 1.1.1.1 - Climate 4 1.1.1.2 - Population 5 1.1.1.3 - Education 7 1.1.1.4 - Art & culture 9 1.1.1.5 - Economy 10 1.1.1.6 - Transportation 11 1.1.2 - The events leading to Courthouse of Milan 12 1.2 - Information on the Courthouse 16 1.2.1 - Historical synopsis 16 1.2.2 - Architectural information 29 1.2.2.1 - Design 29 1.2.2.2 - Distribution of the spaces 31 1.2.2.3 - Circulation in the environment 34 1.2.2.4 - Metric data 35 1.2.2.5 - Architectural drawings 36 1.2.2.5.1 - Plans 36 1.2.2.5.2 - Elevations 44 1.2.2.5.3 - Partial sections and elevations 45 1.2.3 - Technical information 47 1.2.3.1 - Construction 47 1.2.3.2 - Structure data and conditions 51 1.2.3.3 - Materials 53 1.2.3.4 - Technical equipments 54 1.2.3.4.1 - Doors and windows 54 1.2.3.4.2 - Lighting equipments 57 1.2.3.4.3 - Water and health services 58 1.2.3.4.4 - Heating and air-conditioning system 60 1.2.3.4.5 - Electrical system 62 1.2.4 - Courthouse of Milan as an art gallery 66 1.2.4.1 - Information 66 1.2.4.2 - Artworks on the ground floor 70 1.2.4.3 - Artworks on the first floor 71 1.2.4.4 - Artworks on the third floor 79 1.3 - SWOT analyses 89 1.3.1 - Analysis on Milan 89 1.3.2 - Analysis on the Courthouse 90 2.