Parrocchia Di San Giorgio in Jerago
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

VILLA I TAT TI Via Di Vincigliata 26, 50135 Florence, Italy
The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies VILLA I TAT TI Via di Vincigliata 26, 50135 Florence, Italy Volume 30 E-mail: [email protected] / Web: http://www.itatti.it Tel: +39 055 603 251 / Fax: +39 055 603 383 Autumn 2010 or the eighth and last time, I fi nd Letter from Florence to see art and science as sorelle gemelle. Fmyself sitting on the Berenson gar- The deepening shadows enshroud- den bench in the twilight, awaiting the ing the Berenson bench are conducive fi reworks for San Giovanni. to refl ections on eight years of custodi- In this D.O.C.G. year, the Fellows anship of this special place. Of course, bonded quickly. Three mothers and two continuities are strong. The community fathers brought eight children. The fall is still built around the twin principles trip took us to Rome to explore the scavi of liberty and lunch. The year still be- of St. Peter’s along with some medieval gins with the vendemmia and the fi ve- basilicas and baroque libraries. In the minute presentation of Fellows’ projects, spring, a group of Fellows accepted the and ends with a nostalgia-drenched invitation of Gábor Buzási (VIT’09) dinner under the Tuscan stars. It is still a and Zsombor Jékeley (VIT’10) to visit community where research and conver- Hungary, and there were numerous visits sation intertwine. to churches, museums, and archives in It is, however, a larger community. Florence and Siena. There were 19 appointees in my fi rst In October 2009, we dedicated the mastery of the issues of Mediterranean year but 39 in my last; there will be 31 Craig and Barbara Smyth wing of the encounter. -

Mario Enrico Delpini
INFORMATORE PARROCCHIALE SETTEMBRE 2017 - Anno 112 - Numero 8 Ingresso in Diocesi del nuovo vescovo Mario Enrico Delpini 24 settembre 2017 Settembre - 1 ITINERARI DI PREPARAZIONE CONTATTI TELEFONICI AL SANTO BATTESIMO Don Eugenio Folcio tel: 0341 681593 cell: 347 2632909 Domenica 3 settembre: ore 16.00, in Oratorio (sala fax: 0341 681593 mons. Colombo), incontro di preparazione con i genitori, padrini e madrine. Don Andrea Mellera cell. 3471871296 Sabato 16 settembre: ore 18.00, in Chiesa parroc- Don Angelo Ronchi cell. 329 1330573 chiale, presentazione dei battezzandi alla Comunità. Asilo di via Marconi tel: 0341 681610 Domenica 1 ottobre: ore 11.00 e ore 16.00 in Chie- Oratorio tel: 0341 681511 sa parrocchiale, celebrazione del S. Battesimo. Casa di Riposo tel: 0341 6534100 CONTATTI MAIL Editoriale Parrocchia [email protected] www.parrocchiaolginate.it Oratorio [email protected] CREDO, AIUTAMI NELLA MIA INCREDULITÀ Don Andrea [email protected] Chierichetti [email protected] Gruppo Famiglie [email protected] Nel dialogo tra un credente e un ateo, Achille Campanile famoso per il suo umorismo paradossale, ci offre una battuta Gruppo InCanto [email protected] molto graffiante: Runners [email protected] Il credente: “Io sono credente, signore, afflitto dal dubbio che Dio non esista.” Redazione [email protected] L’ateo: “Io, peggio. Sono un ateo, signore, afflitto dal dubbio che Dio, invece, esista realmente.” È terribile. La Voce È la nostra perenne condizione. Attraversati dal dubbio, ogni giorno dobbiamo abbeverarci alle fontane della fede e Teatro Jolly: [email protected] della incredulità. Con parole incisive il grande scrittore Dostoevskij analizza lo stato interiore, spesso lacerante, del credente. -

2017 Annual Report
Report of the Board of Directors and the 2017 Annual Accounts/Financial Statements 2017 began with the Madrid Consultation organised in collaboration with the Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE and the BBVA Group. The Consultation was held January 25 to 27 on the subject Economic and financial ethics in the digital age. The Foundation then worked on the May 18- 20 International Conference in the Vatican centred on the theme Constructive alternatives at a time of global upheaval: employment and human dignity in the digital age. The future of work and Christian ethics in the context of the digital revolution was further discussed in two conferences: the first in Italian held in Turin 23 September on People and Organisations in the era of the digital revolution. Transformations of work, competitiveness and inequality and the second in German in Berlin 15 - 16 November where the topic was Christian Social Ethics in the Digital Age. These meetings were stages in a process that aims to project into the future the experiences gained gradually over the years, as in 2017 we are approaching the threshold of the 25th anniversary of the establishment of the Foundation through St. John Paul II’s 1993 Motu Proprio. The ceremony for the third edition of the International "Business and Society" Award held May 18 and chaired by the Cardinal Secretary of State Pietro Parolin in the presence of the authors, the chairman of the Jury Cardinal Reinhard Marx and the secretary of the award committee Prof. Fr. Michael Konrad. The award ceremony was part of the Foundation’s international conference. -

Sezione 1 Anagrafe 1569
INTRODUZIONE STORICO ARCHIVISTICA I Storia della parrocchia di S. Francesco in Moggio L’edificazione di una chiesa dedicata a S. Francesco d’Assisi in Moggio risale, come giustamente osservato dallo Zastrow, alla metà del sec. XIII, data mediana tra la diffusione della devozione successiva alla canonizzazione nel 1228 e la prima attestazione dell’edificio nel Liber Notitiae di Goffredo da Bussero (morto poco dopo il 1289). Non si può escludere nemmeno un’influenza indiretta esercitata da Leone da Perego (+1257), frate francescano a quel tempo arcivescovo di Milano Con la formazione ed il definitivo consolidamento delle strutture parrocchiali, avvenuto nel corso del sec. XV, la cura d’anime del luogo di Moggio venne affidata ai rettori della chiesa di S. Giorgio in Cremeno. La visita pastorale condotta nel luglio 1455 dall’arcivescovo Gabriele Sforza conferma: “Ecclesia Sancti Francisci de Modio tenetur per rectore de Cremeno”. Quattro anni dopo si ha notizia di un intervento di decorazione della chiesa di S. Francesco. --- o --- A più di un secolo di distanza giunse in visita pastorale l’arcivescovo Carlo Borromeo. Nella prima visita pastorale del 1566 rilevò come la rendita annua (legati esclusi) della chiesa di S. Francesco ammontasse a £. 50 e venisse in parte impiegata per la manutenzione ed in parte per l’officiatura festiva da parte di un cappellano che però risultava essere vacante. Ordinò quindi al parroco di Cremeno un maggior impegno nei confronti della comunità di Moggio. Ma il desiderio di una maggiore e definitiva autonomia da Cremeno spinsero la comunità di Moggio ad intavolare una trattativa con l’autorità ecclesiastica che portò alla definitiva erezione parrocchiale nell’autunno del 1569, con territorio smembrato dalla cura di S. -
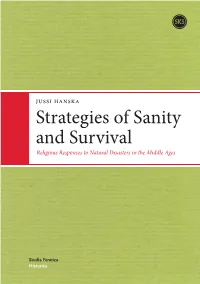
Strategies of Sanity and Survival Religious Responses to Natural Disasters in the Middle Ages
jussi hanska Strategies of Sanity and Survival Religious Responses to Natural Disasters in the Middle Ages Studia Fennica Historica The Finnish Literature Society (SKS) was founded in 1831 and has, from the very beginning, engaged in publishing operations. It nowadays publishes literature in the fields of ethnology and folkloristics, linguistics, literary research and cultural history. The first volume of the Studia Fennica series appeared in 1933. Since 1992, the series has been divided into three thematic subseries: Ethnologica, Folkloristica and Linguistica. Two additional subseries were formed in 2002, Historica and Litteraria. The subseries Anthropologica was formed in 2007. In addition to its publishing activities, the Finnish Literature Society maintains research activities and infrastructures, an archive containing folklore and literary collections, a research library and promotes Finnish literature abroad. Studia fennica editorial board Anna-Leena Siikala Rauno Endén Teppo Korhonen Pentti Leino Auli Viikari Kristiina Näyhö Editorial Office SKS P.O. Box 259 FI-00171 Helsinki www.finlit.fi Jussi Hanska Strategies of Sanity and Survival Religious Responses to Natural Disasters in the Middle Ages Finnish Literature Society · Helsinki Studia Fennica Historica 2 The publication has undergone a peer review. The open access publication of this volume has received part funding via a Jane and Aatos Erkko Foundation grant. © 2002 Jussi Hanska and SKS License CC-BY-NC-ND 4.0. International A digital edition of a printed book first published in 2002 by the Finnish Literature Society. Cover Design: Timo Numminen EPUB Conversion: eLibris Media Oy ISBN 978-951-746-357-7 (Print) ISBN 978-952-222-818-5 (PDF) ISBN 978-952-222-819-2 (EPUB) ISSN 0085-6835 (Studia Fennica) ISSN 0355-8924 (Studia Fennica Historica) DOI: http://dx.doi.org/10.21435/sfh.2 This work is licensed under a Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0. -

E AVONAE EX TYPOGRAPHIA A
COLLECTIO SCRIPTORUM UTRIUSQUE CONGREGATIONIS ET SEXUS P. F. Bartholomaei a S. Angelo Provinciae Longobardicae OPERA. ET SOLERTIA EXARATA CM ACCIDIT SUPPLEMENTUM SCRIPTORUM ORDINIS QUI AUT OBLITI FUERUNT AUT RECENTI! 8 VIXERUNT AUCTORE ET COLLECTORE F. F. Eeswlco M. % SS. Sacramsn.io Alumno Provincia? Genuensis. Accedunt insuper CATALOGUS EPISCOPORUM INDEX PREPOSITORUM GENERALIUM KT PROSPECTUS PROVINCIARUM ET CCENOBIORUM ORDINIS. Tomus primus e AVONAE EX TYPOGRAPHIA A. RICCI MDCCCI.XK1V. Digitized by Google Z- 7^4 0 c a- 'B 3 v, I Digitized by Google X UNX X F. HIERONYMUS M.* AB IMMACULATA CONCEPTIONE PRAEPOSITUS GENERALIS FRATRUM EXCALCEATORUM ORDINIS BEATISSIMI VIRGINIS MARII DE MONTE CARMELO EJFSDEMQUE SACRI MONTIS PRIOR. Cura Opus cui titulus ~ Collectio Scriptorum Ordinis Cai'melilarum Excalceatorum utriusque Congregationis et Seocus a R. P. Bartolouuoo a S. Angelo Sacerdote Provinciae Dongobardiae exaratum, et Supplementum ejusdem Operis a R. P. Henrico M.* a SS.““ Sacramento Magistro Novitiorum Provinciae N/“ Januensis compositum, duo e Nostris Theolo- gis examinaverint, nihilque in eo offenderint, quod Catholicae Fidei, et bonis moribus adversetur licentiam, quantum ad nos attinet concedimus ut typis edatur, servatis omnibus de Jure servandis. In cujus fidem etc. Datum Genua;, ex Conventu Nostro S. Annae die 4’ Octobris 1883. a F. HIERONYAIUS M. ab Immaculata Conceptione Prcvpositus Generalis. F. Seraphini s a S. Theresia — Sccrctarius. Digitized by Google PRAEFATIO AD LECTOREM CARMEUTAM DISCALCEATUM Cum,jam multis abhinc annis, benevole lector, manuscri- ptwm opusR. P. F. Bariholo?naei a S. Angelo N. Provinciae, Pongobardicae Alumni, repererim, quod ad trutinam revo- catum magni faciendum esse jure ac merito existimaverim, statim illud typis mandandum ex plurimorum nostrorum Religiosomim consilio in votis habui et statui. -

Terracotta Tableau Sculpture in Italy, 1450-1530
PALPABLE POLITICS AND EMBODIED PASSIONS: TERRACOTTA TABLEAU SCULPTURE IN ITALY, 1450-1530 by Betsy Bennett Purvis A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctorate of Philosophy Department of Art University of Toronto ©Copyright by Betsy Bennett Purvis 2012 Palpable Politics and Embodied Passions: Terracotta Tableau Sculpture in Italy, 1450-1530 Doctorate of Philosophy 2012 Betsy Bennett Purvis Department of Art University of Toronto ABSTRACT Polychrome terracotta tableau sculpture is one of the most unique genres of 15th- century Italian Renaissance sculpture. In particular, Lamentation tableaux by Niccolò dell’Arca and Guido Mazzoni, with their intense sense of realism and expressive pathos, are among the most potent representatives of the Renaissance fascination with life-like imagery and its use as a powerful means of conveying psychologically and emotionally moving narratives. This dissertation examines the versatility of terracotta within the artistic economy of Italian Renaissance sculpture as well as its distinct mimetic qualities and expressive capacities. It casts new light on the historical conditions surrounding the development of the Lamentation tableau and repositions this particular genre of sculpture as a significant form of figurative sculpture, rather than simply an artifact of popular culture. In terms of historical context, this dissertation explores overlooked links between the theme of the Lamentation, the Holy Sepulcher in Jerusalem, codes of chivalric honor and piety, and resurgent crusade rhetoric spurred by the fall of Constantinople in 1453. Reconnected to its religious and political history rooted in medieval forms of Sepulchre devotion, the terracotta Lamentation tableau emerges as a key monument that both ii reflected and directed the cultural and political tensions surrounding East-West relations in later 15th-century Italy. -
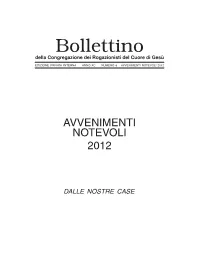
06.065 • N. 5 Avv. Notev
Bollettino della Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù EDIZIONE PRIVATA INTERNA – ANNO XC – NUMERO 6 – AVVENIMENTI NOTEVOLI 2012 AVVENIMENTI NOTEVOLI 2012 DALLE NOSTRE CASE 692 BOLLETTINO DELLA CONGREGAZIONE N. 6 Struttura Centrale ROMA - Curia Generalizia G ENNAIO 1 – P.Angelo A. Mezzari presiede la celebrazione di inizio del nuovo anno 2012. Sono presenti le Comunità della Parrocchia, dello Studentato e dell’Anto- niano. 3 – P.Epifani e P.Cabbia partecipano al Convegno organizzato dal Centro Na- zionale delle Vocazioni presso la Domus Mariae, Roma. 6 – P.Antonio Fiorenza parte per gli USA dove è stato assegnato alla Comunità di Van Nuys, California. Il Padre Generale consegna alla Comunità il nuovo testo delle Costituzioni e Norme. 7 – Il Padre Generale accompagnato dal P. Matteo Sanavio parte per Manila per dare inizio alla Visita Canonica alla Quasi Provincia Filippina. 13 – P. Bruno Rampazzo parte per Cochin, Kerala dove si reca per condurre, a nome del Superiore Generale, l’Apta Consultatio alla Quasi Provincia del- l’India. 31 – Le Comunità delle Figlie del Divino Zelo con la Superiora Generale, Madre Teolinda Salemi, si incontrano con le Comunità dei Rogazionisti presso la nostra Parrocchia dei Santi Antonio e Annibale per la Supplica al Nome Sa- cratissimo di Gesù. P. Rampazzo presiede la celebrazione eucaristica durante la quale il Fra- tello Antonio Vasta rinnova i voti religiosi presso la nostra Parrocchia di Piaz- za Asti. F EBBRAIO 5 – Il P. Adamo Calò, Superiore Provinciale della Provincia Italia Centro-Nord, insieme con i Padri Menegolli e Buccheri, arrivano da Padova per iniziare la Visita canonica delle Comunità di Roma e dintorni. -

San Josemaría Escrivá E Il Beato Ildefonso Schuster (1948-1954)
San Josemaría Escrivá e il beato Ildefonso Schuster (1948-1954) AlDo CApuCCI Abstract: San Josemaría Escrivá e il beato Alfredo Ildefonso Schuster, cardi- nale arcivescovo di Milano, si conobbero nel capoluogo lombardo il 14 gen- naio del 1948. L’incontro e gli eventi successivi dimostrano non soltanto la piena sintonia fra il fondatore dell’Opus Dei e i vescovi delle città nelle quali intendeva espandere il lavoro apostolico, ma anche, in questo caso, la profon- da e reciproca stima con il santo pastore di quella che allora era la diocesi più grande del mondo. La certezza dell’avvenuto incontro – messo in dubbio da una testimonianza della causa di canonizzazione del fondatore dell’Opus Dei, ma soprattutto dal riserbo dei protagonisti – viene qui acquisita e certificata attraverso documenti inediti, grazie ai quali è stato anche possibile ricostruir- ne i probabili contenuti, alla luce delle circostanze storiche di quegli anni. Keywords: Josemaría Escrivá – Alfredo Ildefonso Schuster – Opus Dei – Milano – 1948-1954 St. Josemaría Escrivá and Blessed Ildefonso Schuster (1948-1954): St. Jose- maría Escrivá and Blessed Ildefonso Cardinal Schuster –Archbishop of Milan- first met in the Lombard capital on January 4, 1948. This meeting, along with subsequent events, shows not only the perfect harmony which existed between the founder of Opus Dei and the bishops of the various cities in which Opus Dei planned to commence its apostolic activities, but also, in this case, the meeting shows the profound and reciprocal esteem between St. Josemaría and the holy Pastor of the diocese which was at that time the largest in the world. -

Storico - Artistica
GUIDA STORICO - ARTISTICA DELL OSPITALE MAGGIORE DI MILANO. MILANO TIPOGRAFIA DI PIETRO AGNELLI Contr.’ del Morone N. 1166. 1857. GUIDA STORICO - ARTISTICA DELL’OSPITALE MAGGIORE DI MILANO. Il presente Libro è posto sotto la tutela delle vegliami Leggi, essendosi adempiuto a quanto esse prescrivono. Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti implorano ed ottengono da Pio II (Piccolomini) di erigere in Ospitale il loro palazzo, 1446. (L originale è nella chiesa dell’ ospitale). NOTIZIE STORICHE D E L GRAND’OSPITALE DI MILANO PROSPETTO CRONOLOGICO DEI RITRATTI DE' SUOI BENEF A T T ORI COLL’ELENCO DEGLI AUTORI E DESCRIZIONE DEI MONUMENTI DEDICATI A DIVERSI DISTINTI MEDICI E CHIRURGHI MILANO TIPOGRAFIA DI PIETRO AGNELLI Contr.'' del Morone N. 1166. 1857. PREFAZIONE V enne più volle ed ampiamente descritta e illustrala da eccellenti autori Ï architettura dell' Ospitale Maggiore di Milano. Tutto ciò che concerne così le rendite di que sto Stabilimento ed il modo con cui vengono erogate, come il numero degli infermi ai quali estende la sua beneficen za, la quantità delle malattie che si sono curate, il modo ed il risultamento delle cure, l'interno ordinamento di esso anche nei riguardi economici, con tutte le notizie statistiche e mediche relative a questo Nosocomio fu già esposto, e lo è di continuo, specialmente col mezzo dei dotti e ben ela borati rendiconti che l'esimia Direzione pubblica ogni anno. Ma, oltre agli accennati oggetti principali questo grande asilo della carità Milanese altri ne offre meritevoli della attenzione pubblica, e sui quali anzi è già desta la curiosità dei cittadini, che prendono a buon diritto vivo interessamento a tutto ciò che tocca i patrii monumenti. -

Expo in Città Events Calendar Read Our Top Picks
Maps Events Restaurants Cafés Nightlife Sightseeing Shopping Hotels Milan SSummerummer 22015015 Expo in città events calendar Read our top picks inyourpocket.com Contents Arriving & Transport 8 City basics 13 History 17 Culture & Events 18 Restaurants 23 Cafés 27 Nightlife 28 Sightseeing 30 Shopping 39 Directory 42 Where to sleep 44 Maps & Index Public transport maps 47 City centre map 50 © Oskar Dariz Expo 2015 map 52 MUDEC Index 54 Publisher IYP Italia S.r.l. Via San Vincenzo 2 - XI piano 16121 Genoa, Italy Head offi ce Via Benigno Crespi 19 - MAC4 - IV piano 20159 Milan, Italy Tel. +39 02 00 69 71 41 Fax +39 02 00 69 71 01 [email protected] www.inyourpocket.com Printed by Graphicscalve S.p.A., Vilminore di Scalve, Italy Editor-in-Chief: Lorenzo Marsano Contributor: Adrienne Baumann Layout: Tomáš Haman Maps: Courtesy of Regione Lombardia, Touring Editore, Expo 2015 Cover photo © TownHouse Hotels Sales & Circulation Manager: Roberta Greco (mob. +39 344 082 93 44, [email protected]) Naviglio Grande © Comune di Milano Special Thanks Mariasole and Valentina IN YOUR POCKET TV Copyright Notice & Editor’s Note In Your Pocket goes into the movie business... Kind of... Text and photos (unless otherwise stated) © IYP Italia S.r.l. 2015. All rights reserved. No part of this publication may be Over the past few months we have gradually been reproduced in any form without written permission from the putting together some extensive video guides to In Your Pocket In Your Pocket copyright owner. The brand name is used under various cities, using our own editors, license from UAB In Your Pocket (Bernardinu 9-4, Vilnius, writers and local researchers as presenters. -

Paola Vismara Paola Vismara Les Splendeurs De La Dévotion À Milan
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by AIR Universita degli studi di Milano 1 Article paru dans le volume : Les Cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque © Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2009 Paola Vismara Les splendeurs de la dévotion à Milan. Du baroque aux Lumières Au centre de mon analyse et de mon exposition sur les cérémonies extraordinaires il y a Milan. Une ville entre autres, un diocèse entre autres ; mais très important à cette époque. Une ville et un diocèse dont Louis Châtellier a écrit: « Qu’on ne dise pas: ce n’est qu’une province de l’Europe. Mais quelle province! Celle qui fut modelée par Charles Borromée [...]. Milan est sur l’axe médian de l’Europe catholique [...] dans les terres de choix du catholicisme tridentin »1. Le renouveau catholique s’y implanta e y persista. Au coeur de ce renouveau il y a - bien sûr - Charles Borromée, mais sa spiritualité marquée par une forte rigueur est tout de suite après tempérée par son cousin Frédéric (qui ressent l’influence de Filippo Neri), et par l’enracinement de la spiritualité de la Compagnie de Jésus 2. De tout cela découle une spiritualité très simple, qui exalte la mediocritas , et, finalement, le fait d’être un bon chrétien dans la vie de chaque jour, au travail comme en famille. À côté de cela on peut constater, sans contradiction, un penchant vers la dévotion extérieure : deux facettes qui se correspondent et complètent parfaitement. Ce qui est évident dans les dévotions quotidiennes, même dans les rues et aux carrefours, par-devant les images, l’est encore plus dans les 1.