Annuario 2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
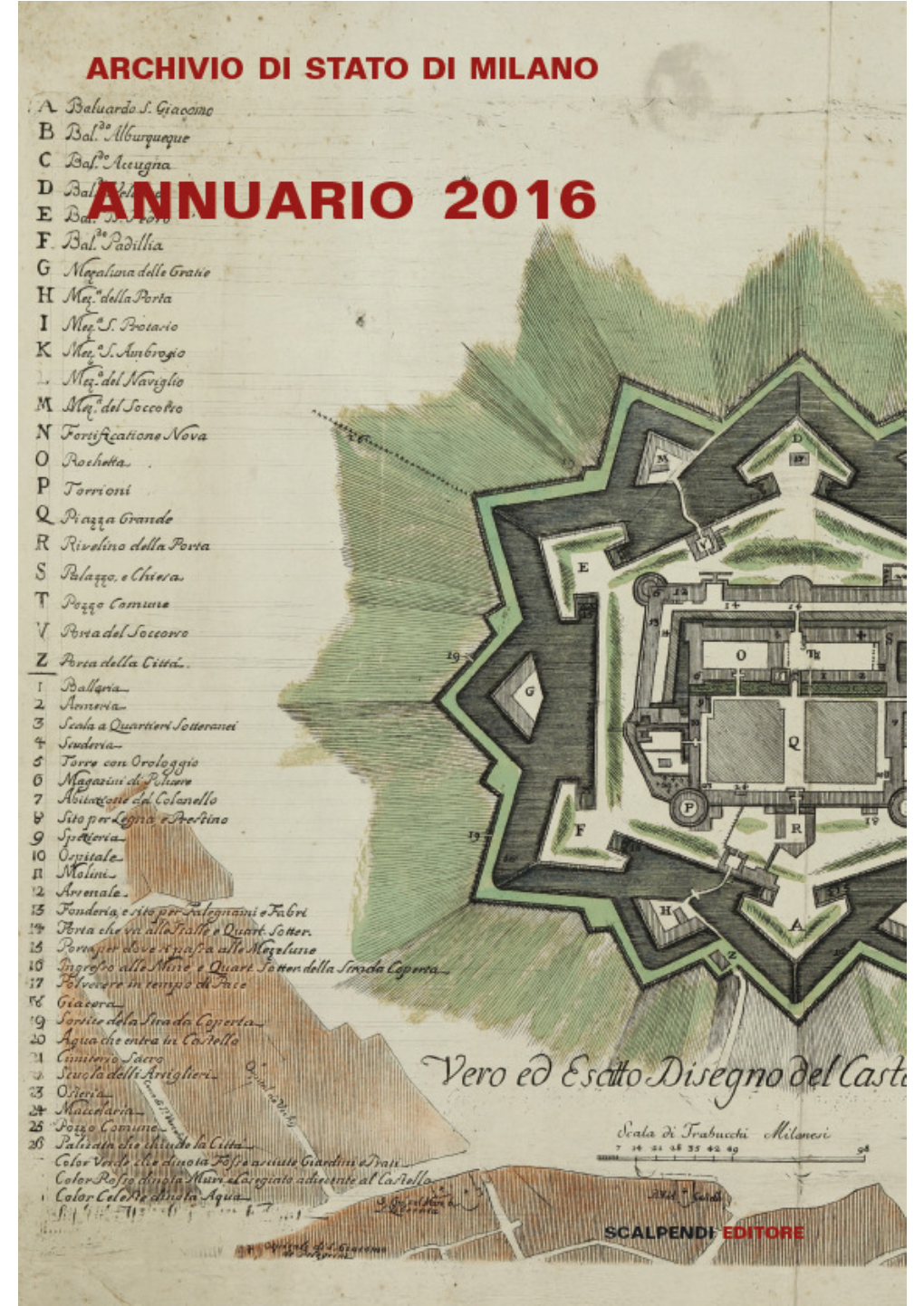
Load more
Recommended publications
-

Between Power and Rebellion: Rethinking Authority
EDGAR STRAEHLE* BETWEEN POWER AND REBELLION: RETHINKING AUTHORITY Entre poder e rebelião: repensar a autoridade Resumo Um dos principais objectivos deste escrito é dissociar e desembaraçar os conceitos de autoridade e poder à luz das insurreiçãos medievais e lutas na ciudade de Milão e, além disso, compreender na dimensão ambivalente e ambígua da autoridade. Ao analisar estes fatos históricos, vou tentar mostrar que a autoridade não pertence sempre ou necessariamente ao governo ou que somente pode ser um instrumento deste. De fato, é mais interessante explorar o outro lado desta questão: como o uso da autoridade pôde devenir um instrumento de contrapoder. Neste sentido, vou examinar como e porquê algumas rebeliões contestaram o poder não apenas combatendo a autoridade oficial mas reivindicando uma alternativa. Ou seja, como e porquê a categoria de auto- ridade pôde tornarse uma fonte de legitimidade da insurreição. Palavras-chave: autoridade; poder; rebelião. Authors: Santo Ambrósio; Hannah Arendt. * Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) and University of Barcelona (ADHUC). Email: [email protected]. This work has been written with the support of the research group «La transmisión desde el pensamiento filosófico femenino» (FFI2015-63828-P, MINECO/FEDER, UE) and the GRC «Creació i pensament de les dones» (2014 SGR44) of the University of Barcelona. The writing of this paper would have been impossible without the generous help of Emily McBride and Meritxell Joan. I am really indebted to them and I thank their tips and corrections. Filosofia. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 33 (2016) 273-285 273 DOI: http://dx.doi.org/10.21747/21836892/fil33a17 EDGAR STRAEHLE Abstract One of the main goals of this paper is to dissociate and disentangle the concepts of power and authority in light of the late medieval insurrections and fights in thecom - mune of Milan and, then, to comprehend the ambivalent and ambiguous dimension of authority. -

La Lotta Per Il Potere a Milano
LA GRANDE BATTAGLIA Nel corso del 1276, non si hanno notizie circa il periodo dell’anno, le forze viscontee cominciarono ad organizzare un attacco, nelle intenzioni decisivo, nei confronti dei Torriani. Goffredo da Langosco, alla testa dei fuoriusciti milanesi, occupò inizialmente Arona, unitamente ad alcune postazioni strategiche dell’Ossola, le cui popolazioni erano fedeli all’arcivescovo. Intanto Ottone Visconti riusciva a sbarcare ad Angera con tre-quattromila uomini e ad occuparne la rocca. Napo della Torre, benché colto di sorpresa, reagì inviando nella zona il figlio Cassone che, con una schiera di cinquecento tedeschi fornitagli dall’imperatore Rodolfo d’Asburgo, riuscì a mettere sotto assedio il castello di Angera. Nel frattempo Goffredo da Langosco, insieme ad un esercito di quattro-cinquemila armati composto da fuoriusciti milanesi, uomini del Seprio e di Pavia, oltre che da genovesi e spagnoli, ingrossato oltretutto da locali fedeli a Ottone, muovendo da Arona riuscì ad occupare buona parte del Seprio settentrionale dirigendosi poi verso Angera. Cassone della Torre aveva intanto preso posizione nella piana del torrente Guassera, nei pressi della riva del Lago Maggiore al confine tra gli odierni comuni di Ranco e Ispra. Il momento della verità era ormai arrivato… Le forze torriane furono all’improvviso raggiunte dall’esercito visconteo che proveniva da Nord e cioè dal territorio isprese. Goffredo da Langosco, sfruttando l’elemento sorpresa, non si lasciò sfuggire l’occasione di attaccare i soldati teutonici di Cassone mentre stavano ancora approntando l’accampamento. Durante l’attacco, superato di slancio dai Viscontei il rio Guassera, lo stesso capo dei tedeschi, Hans Lauser, venne ucciso: forse proprio da Goffredo in persona. -

Competing Sovereignties in 14Th Century Milan
University of Nebraska at Omaha DigitalCommons@UNO Medieval/Renaissance Studies Faculty Publications Medieval/Renaissance Studies 2011 The Prince and the Prostitute: Competing Sovereignties in 14th Century Milan Martina Saltamacchia Rutgers University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unomaha.edu/medrenstudfacpub Part of the Medieval Studies Commons Recommended Citation “The Prince and the Prostitute: Competing Sovereignties in Fourteenth-Century Milan” in Law and Sovereignty in the Middle Ages and Renaissance, Robert Sturges, ed. (Turnhout: Brepols, 2011), 173-191. This Article is brought to you for free and open access by the Medieval/Renaissance Studies at DigitalCommons@UNO. It has been accepted for inclusion in Medieval/Renaissance Studies Faculty Publications by an authorized administrator of DigitalCommons@UNO. For more information, please contact [email protected]. The following is a post-print manuscript of “The Prince and the Prostitute: Competing Sovereignties in Fourteenth-Century Milan” that appeared in Law and Sovereignty in the Middle Ages and Renaissance, Robert Sturges, ed. Full citation: Martina Saltamacchia, “The Prince and the Prostitute: Competing Sovereignties in Fourteenth-Century Milan” in Law and Sovereignty in the Middle Ages and Renaissance, Robert Sturges, ed. (Turnhout: Brepols, 2011), 173-191. 2 The Prince and the Prostitute: Competing Sovereignties in 14th Century Milan Martina Saltamacchia, Rutgers University On the morning of November 27, -

Milan and the Lakes Travel Guide
MILAN AND THE LAKES TRAVEL GUIDE Made by dk. 04. November 2009 PERSONAL GUIDES POWERED BY traveldk.com 1 Top 10 Attractions Milan and the Lakes Travel Guide Leonardo’s Last Supper The Last Supper , Leonardo da Vinci’s 1495–7 masterpiece, is a touchstone of Renaissance painting. Since the day it was finished, art students have journeyed to Milan to view the work, which takes up a refectory wall in a Dominican convent next to the church of Santa Maria delle Grazie. The 20th-century writer Aldous Huxley called it “the saddest work of art in the world”: he was referring not to the impact of the scene – the moment when Christ tells his disciples “one of you will betray me” – but to the fresco’s state of deterioration. More on Leonardo da Vinci (1452–1519) Crucifixion on Opposite Wall Top 10 Features 9 Most people spend so much time gazing at the Last Groupings Supper that they never notice the 1495 fresco by Donato 1 Leonardo was at the time studying the effects of Montorfano on the opposite wall, still rich with colour sound and physical waves. The groups of figures reflect and vivid detail. the triangular Trinity concept (with Jesus at the centre) as well as the effect of a metaphysical shock wave, Example of Ageing emanating out from Jesus and reflecting back from the 10 Montorfano’s Crucifixion was painted in true buon walls as he reveals there is a traitor in their midst. fresco , but the now barely visible kneeling figures to the sides were added later on dry plaster – the same method “Halo” of Jesus Leonardo used. -

Expo in Città Events Calendar Read Our Top Picks
Maps Events Restaurants Cafés Nightlife Sightseeing Shopping Hotels Milan SSummerummer 22015015 Expo in città events calendar Read our top picks inyourpocket.com Contents Arriving & Transport 8 City basics 13 History 17 Culture & Events 18 Restaurants 23 Cafés 27 Nightlife 28 Sightseeing 30 Shopping 39 Directory 42 Where to sleep 44 Maps & Index Public transport maps 47 City centre map 50 © Oskar Dariz Expo 2015 map 52 MUDEC Index 54 Publisher IYP Italia S.r.l. Via San Vincenzo 2 - XI piano 16121 Genoa, Italy Head offi ce Via Benigno Crespi 19 - MAC4 - IV piano 20159 Milan, Italy Tel. +39 02 00 69 71 41 Fax +39 02 00 69 71 01 [email protected] www.inyourpocket.com Printed by Graphicscalve S.p.A., Vilminore di Scalve, Italy Editor-in-Chief: Lorenzo Marsano Contributor: Adrienne Baumann Layout: Tomáš Haman Maps: Courtesy of Regione Lombardia, Touring Editore, Expo 2015 Cover photo © TownHouse Hotels Sales & Circulation Manager: Roberta Greco (mob. +39 344 082 93 44, [email protected]) Naviglio Grande © Comune di Milano Special Thanks Mariasole and Valentina IN YOUR POCKET TV Copyright Notice & Editor’s Note In Your Pocket goes into the movie business... Kind of... Text and photos (unless otherwise stated) © IYP Italia S.r.l. 2015. All rights reserved. No part of this publication may be Over the past few months we have gradually been reproduced in any form without written permission from the putting together some extensive video guides to In Your Pocket In Your Pocket copyright owner. The brand name is used under various cities, using our own editors, license from UAB In Your Pocket (Bernardinu 9-4, Vilnius, writers and local researchers as presenters. -
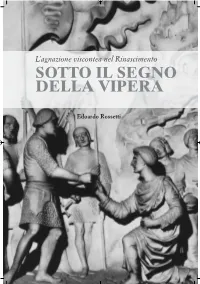
00-PRIME PP 2:Layout 1
L’agnazione viscontea nel Rinascimento SOTTO IL SEGNO DELLA VIPERA Edoardo Rossetti «In Milano la più degna e nobile fameglia è la Visconta» scriveva nel 1520 l’oratore veneto Gianiacopo Caroldo. Quella che rimaneva, nonostante l’estinzione del ramo ducale, la più importante agnazione di Milano non è stata sinora adeguatamente studiata, né nella geografia castel- lana delle sue numerose signorie, né nelle articolazioni delle sue iniziative politiche, né nella sua presenza culturale nello stato di Milano. È specialmente su quest’ultimo as- petto che si incentra questo volume. Attraverso un’ampia ricerca archivistica e iconografica largamente inedita ven- gono ricostruiti importanti episodi di committenza delle famiglie principali della parentela viscontea che si intrec- ciano a comporre una politica artistica di ampio respiro, tale da incidere profondamente sul territorio: da Milano a Somma Lombardo, da Pallanza a Brignano, da Vignate a Santa Maria del Monte sopra Varese. Edoardo Rossetti (Varese, 1979) si è laureato nel 2006 in Storia presso l’Università degli Studi di Milano è autore di numerosi saggi sulla storia politica, sociale, artistica e cul- turale del Rinascimento lombardo; coordina la collana Scaglie d’archivio dell’Archivio di Stato di Milano, per la quale ha curato il volume Squarci d’interni. FESR Fondo europeo di sviluppo regionale - Le opportunità non hanno confini Sotto il segno della vipera In copertina Gian Cristoforo Romano e collaboratori, Gian Galeazzo Visconti riceve la signoria di Milano, particolare del Monumento -

ERBA CASTLE* * Building Totally Or Partially in Ruins
ERBA CASTLE* * building totally or partially in ruins You can find this point of interest in Erba - Path 1 - Stage 4 DESCRIPTION (Silvia Fasana) Erba castle was probably built between the 10th and 11th century, in a strategic position to control the Pian d'Erba and the Brianza lakes. The first owners were the Ghibelline family of the De Herba or Erba, who later transferred it to the Parravicinis of Parravicino. The people of Erba Castle had an important moment of glory in 1160 during the Battle of Tassera between Frederick Barbarossa and the Milanese. It was when the fortunes of the battle were becoming favourable to the imperial forces and their allies that the inhabitants of Erba and Orsenigo, rebelling against their masters Parravicini, rushed to the rescue of the Milanese, offering their decisive contribution and forcing Barbarossa to flee. Historian Angelo Bassi from Erba wrote: «For this aid, Milan granted Erba the citizenship of Milan, an honour subsequently renewed by all governments that ruled Milan until the French invasion of 1796; for this reason Erba preserves the coat of arms and flag of the Municipality of Milan, i.e. a red cross on a white background». During the battles between the Torriani and Visconti families, in 1278 the castle was besieged and temporarily conquered by Cassone della Torre, who had laid siege to the castle as revenge against the people of Erba castle who had became allies with his opponent, Archbishop Ottone Visconti, in the Battle of Desio in 1277. In 1404 Giovanni da Carcano, an ally of the Viscontis, held prisoner in the castle two members of the Rusca family, Franchino and Ottone, until the peace between Milan and Como was concluded; a few years later, in 1407, when the castle was taken by leader Pandolfo Malatesta, Giovanni Visconti ordered it to be besieged by another famous man of arms of the time, Facino Cane. -

Conservation of the Courthouse of Milan
POLITECNICO DI MILANO Laurea Magistrale (MSc) in Building and Architectural Engineering CONSERVATION OF THE COURTHOUSE OF MILAN Supervisor: PROF. ARCH. Elisabetta ROSINA Thesis by : Baris Demirel - 840553 Liu Yuheng - 840629 Lu Shan - 832833 INDEX ABSTRACT 1 ABSTRACT (Italian Version) 2 1. INTRODUCTION 3 1.1 - Information on Milan 3 1.1.1 - Geographical context 3 1.1.1.1 - Climate 4 1.1.1.2 - Population 5 1.1.1.3 - Education 7 1.1.1.4 - Art & culture 9 1.1.1.5 - Economy 10 1.1.1.6 - Transportation 11 1.1.2 - The events leading to Courthouse of Milan 12 1.2 - Information on the Courthouse 16 1.2.1 - Historical synopsis 16 1.2.2 - Architectural information 29 1.2.2.1 - Design 29 1.2.2.2 - Distribution of the spaces 31 1.2.2.3 - Circulation in the environment 34 1.2.2.4 - Metric data 35 1.2.2.5 - Architectural drawings 36 1.2.2.5.1 - Plans 36 1.2.2.5.2 - Elevations 44 1.2.2.5.3 - Partial sections and elevations 45 1.2.3 - Technical information 47 1.2.3.1 - Construction 47 1.2.3.2 - Structure data and conditions 51 1.2.3.3 - Materials 53 1.2.3.4 - Technical equipments 54 1.2.3.4.1 - Doors and windows 54 1.2.3.4.2 - Lighting equipments 57 1.2.3.4.3 - Water and health services 58 1.2.3.4.4 - Heating and air-conditioning system 60 1.2.3.4.5 - Electrical system 62 1.2.4 - Courthouse of Milan as an art gallery 66 1.2.4.1 - Information 66 1.2.4.2 - Artworks on the ground floor 70 1.2.4.3 - Artworks on the first floor 71 1.2.4.4 - Artworks on the third floor 79 1.3 - SWOT analyses 89 1.3.1 - Analysis on Milan 89 1.3.2 - Analysis on the Courthouse 90 2. -

Galvano Fiamma, Francesco Petrarca E I Cavalli Dei
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 199 GALVANO FIAMMA , F RANCESCO PETRARCA EICAVALLI DEI VISCONTI GRAZIANO ALFREDO VERGANI Banco di prova privilegiato per lo sviluppo del linguaggio rinascimentale quattrocentesco, il tema del monumento equestre ha avuto in Italia una notevole fortuna già nel Trecento, in relazione con il maturare delle istituzioni signorili e con il diffondersi di una nuova sensibilità, intrisa di contenuti cavallereschi e proto umanistici. Esemplare è il caso di Verona con il celebre complesso delle arche scaligere, su cui sfilano, in una parata cerimoniale tra cielo e terra, le statue a cavallo di Cangrande, Mastino e Cansignorio della Scala 1. Un altro caso è Milano, dove risulterebbero essere stati realizzati nel Trecento i monumenti equestri di almeno due Visconti, signori della città: Azzone e Bernabò. Il condizionale è d’obbligo, poiché mentre quello di Bernabò, sistemato sopra il suo sarcofago, fa ancora mostra di sé in una sala del Castello Sforzesco (figg. 1-2) – dove giunse nel 1898 dalla ex chiesa di Santa Maria di Brera, sede del Museo Patrio Archeologico, pro - venendo da quella di San Giovanni in Conca, per la quale era stato creato 2 –, del monumento equestre di Azzone non resta invece traccia alcuna ed è mia opinio - ne che l’unica fonte che lo ricordi non fornisca elementi sufficienti a comprovar - ne l’effettiva realizzazione. La fonte in questione è l’ Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et Johan - ne Vicecomitibus di Galvano Fiamma, amico e familiare dell’arcivescovo Giovan - ni Visconti, la cui redazione va fissata entro il 1342-43 3. -

STORIE DI VITA E DI MALAVITA Criminali, Poveri E Altri Miserabili Nelle Carceri Di Milano Alla Fine Del Medioevo
30 STORIE DI VITA E DI MALAVITA Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo Il volume affronta un tema non comune nella medievistica: la prigione e i suoi abitanti. Nel carcere medievale i prigionieri – incarcerati prima della Marina Gazzini Marina Gazzini sentenza, oppure rimasti “dentro” perché indebitati, socialmente perico- losi, riconosciuti colpevoli di un delitto – non erano abbandonati a loro stessi; delle loro esigenze si facevano carico le famiglie, la Chiesa, i laici devoti, gli stessi pubblici poteri. Nel caso di Milano il sistema carcerario e STORIE DI VITA E DI MALAVITA il rapporto tra carcerati, giustizia e misericordia assume sfumature pecu- liari. Le prigioni (anche private) sono numerose e disperse nella città: la MALAVITA VITASTORIE E DI DI Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano più grande è un carcere-ospedale, che rinchiude certo, ma lascia intendere alla fine del medioevo che è utile (per motivi economici) aiutare la sopravvivenza del reo e il suo ritorno in società. I milanesi del Quattrocento sono poi consci dei rischi di abbandonare i detenuti (uomini e donne) a una giustizia che, per i suoi costi, tutela solo i più forti. Ecco dunque i Protettori dei carcerati: utili non solo ai deboli rinchiusi in carcere, ma anche al dominus, che li sostiene. Interessato a porre rimedio agli eccessi del sistema, il duca è infatti anche (e forse soprattutto) desideroso di mostrarsi misericordioso, e in quanto tale superiore alla legge. Indagare la condizione dei carcerati si rivela dunque un modo per cogliere non solo le dinamiche di esclusione e di inclusione sociale pertinenti al controllo della devianza, ma anche i meccanismi di relazione tra governanti e governati nel tardo medioevo. -

Reti Medievali E-Book 30 Reti Medievali E-Book
Reti Medievali E-Book 30 Reti Medievali E-Book Comitato scientifico Enrico Artifoni (Università di Torino) Giorgio Chittolini (Università di Milano) William J. Connell (Seton Hall University) Pietro Corrao (Università di Palermo) Élisabeth Crouzet-Pavan (Université Paris IV-Sorbonne) Roberto Delle Donne (Università di Napoli “Federico II”) Stefano Gasparri (Università “Ca’ Foscari” di Venezia) Jean-Philippe Genet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Knut Görich (Ludwig-Maximilians-Universität München) Paola Guglielmotti (Università di Genova) Julius Kirshner (University of Chicago) Giuseppe Petralia (Università di Pisa) Francesco Stella (Università di Siena) Gian Maria Varanini (Università di Verona) Giuliano Volpe (Università di Foggia) Chris Wickham (All Souls College, Oxford) Andrea Zorzi (Università di Firenze) Peer-review Tutti gli E-Book di Reti Medievali sono sottoposti a peer-review secondo la modalità del “doppio cieco”. I nomi dei referee sono inseriti nell’elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all’indirizzo: http://www.rmojs.unina.it/ index.php/rm/about/displayMembership/4. I pareri dei referee sono archiviati. All published e-books are double-blind peer reviewed at least by two referees. Their list is regularly updated at URL: http://www.rmojs.unina.it/index.php/ rm/about/displayMembership/4. Their reviews are archived. Marina Gazzini Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo Firenze University Press 2017 Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del medioevo / Marina Gazzini Firenze : Firenze University Press, 2017 (Reti Medievali E-Book, 30) Accesso alla versione elettronica http://www.ebook.retimedievali.it http://digital.casalini.it/9788864536156 ISBN 978-88-6453-614-9 (print) ISBN 978-88-6453-615-6 (online PDF) ISBN 978-88-6453-616-3 (online EPUB) In copertina: Maestro di Alkmaar, Le sette opere di misericordia, olio su tela, pannello: visitare i carcerati, 1504, Rijksmuseum, Amsterdam ( public domain). -

Università Degli Studi Di Milano
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO SCUOLA DI DOTTORATO Humanae Litterae DIPARTIMENTO Studi Storici CORSO DI DOTTORATO IN STUDI STORICI E DOCUMENTARI Età medievale, moderna, contemporanea XXVII ciclo L'EPISCOPATO DI BRESCIA NEL TARDO MEDIOEVO. SISTEMA DOCUMENTARIO, ARTICOLAZIONE ISTITUZIONALE, VICENDE POLITICHE E PATRIMONIALI. M-Sto/01 Fabrizio PAGNONI matricola n. R09474 TUTOR: chiar.mo prof. Andrea GAMBERINI COORDINATORE: chiar.ma prof.ssa Paola VISMARA A.A. 2013-2014 1 INDICE IL CONTESTO DI FONDO 1. IL QUADRO STORIOGRAFICO……………………………………………………………………p. 5 1.1. Inquadramento…………………………………………………………………………….p. 5 1.2. Aspetti religiosi e pastorali…………...……………………………………………….......p. 7 1.3. Economia e fonti censuarie……………………………………………………………...p. 10 1.4. Scritture, notai, burocrazia vescovile…………………………………………………....p. 13 1.5. Il potere dei vescovi tra Chiesa e laicato………………………………………………...p. 15 2. OBIETTIVI E STRUTTURA DELLA RICERCA…………………………………………………......p. 21 3. UNA PANORAMICA INTRODUTTIVA…………………………………………………………...p. 25 3.1. L’eredità di Berardo…………………………………………………..............................p. 25 3.2. Le difficoltà trecentesche…………………………………………………......................p. 27 3.3. Episcopati viscontei…………………………………………………...............................p. 29 3.4. Gli strumenti: fondi d’archivio, registri, pergamene………………………………….…p. 32 PARTE I: LA DOCUMENTAZIONE 1. LE SCRITTURE…………………………………………………………………………………p. 36 1.1. Uno strumento per l’archivio? l’inventario di metà Trecento…………………………...p. 37 1.1.1. L’ inventario: caratteristiche codicologiche e redazionali……………………....p.