L U I I Storia Ii' Europa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Auguste Rodin's 'The Burghers of Calais' and The
www.amatterofmind.us From the desk of Pierre Beaudry Page 1 of 15 AUGUSTE RODIN’S ‘THE BURGHERS OF CALAIS’ AND THE BLACK DEATH POLICY OF THE ENGLISH How Auguste Rodin created an artistic composition of axiomatic change. by Pierre Beaudry October 20, 2014 FOREWORD ``If a Black Death could spread throughout the world once in every generation, survivors could procreate freely without making the world too full.'' Bertrand Russell – 1949 ``In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solving overpopulation.'' Queen Elizabeth's consort Prince Philip – 1988 This is wake-up time. This report is a wake-up call attempting to answer a simple but difficult axiomatic question: “Why is it that American leaders and citizens don’t see that the plague of Ebola that is being brought to their doorsteps at this time is being carried out by the same people who brought about the Black Death to Europe during the fourteenth century?” The answer to that question can be found in the situation that the population of France found themselves into, when the King of England, Edward III, laid siege to the French town of Calais in 1346. www.amatterofmind.us From the desk of Pierre Beaudry Page 2 of 15 INTRODUCTION In his Chronicles, Jean Froissart (1337-1405), A French writer at the court of the King of England, told the story of how the French town of Calais’ people were spared a horrible death by the heroic action of six of their leaders, who voluntarily accepted to give their lives to save them from famine. -

Tc Ankara Ünġversġtesġ Sosyal Bġlġmler Enstġtüsü
T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ORTAÇAĞ TARĠHĠ BĠLĠM DALI GEÇ ORTAÇAĞ’DA ĠTALYA’NIN SĠYASĠ DURUMU Yüksek Lisans Tezi Sait Emre ÇİFTÇİ Ankara-2019 T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ORTAÇAĞ TARĠHĠ BĠLĠM DALI GEÇ ORTAÇAĞ’DA ĠTALYA’NIN SĠYASĠ DURUMU Yüksek Lisans Tezi Sait Emre ÇİFTÇİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Hatice ORUÇ Ankara-2019 II ONAY TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ORTAÇAĞ TARĠHĠ BĠLĠM DALI Sait Emre ÇİFTÇİ GEÇ ORTAÇAĞ’DA ĠTALYA’NIN SĠYASĠ DURUMU Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice ORUÇ Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı Ġmzası .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ .................................................................... ........................................ Tez Sınavı Tarihi .................................. III T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BĠLDĠRĠM Bu belge ile, tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak -
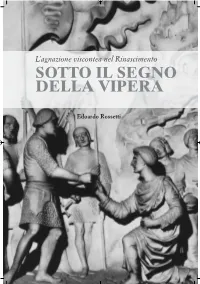
00-PRIME PP 2:Layout 1
L’agnazione viscontea nel Rinascimento SOTTO IL SEGNO DELLA VIPERA Edoardo Rossetti «In Milano la più degna e nobile fameglia è la Visconta» scriveva nel 1520 l’oratore veneto Gianiacopo Caroldo. Quella che rimaneva, nonostante l’estinzione del ramo ducale, la più importante agnazione di Milano non è stata sinora adeguatamente studiata, né nella geografia castel- lana delle sue numerose signorie, né nelle articolazioni delle sue iniziative politiche, né nella sua presenza culturale nello stato di Milano. È specialmente su quest’ultimo as- petto che si incentra questo volume. Attraverso un’ampia ricerca archivistica e iconografica largamente inedita ven- gono ricostruiti importanti episodi di committenza delle famiglie principali della parentela viscontea che si intrec- ciano a comporre una politica artistica di ampio respiro, tale da incidere profondamente sul territorio: da Milano a Somma Lombardo, da Pallanza a Brignano, da Vignate a Santa Maria del Monte sopra Varese. Edoardo Rossetti (Varese, 1979) si è laureato nel 2006 in Storia presso l’Università degli Studi di Milano è autore di numerosi saggi sulla storia politica, sociale, artistica e cul- turale del Rinascimento lombardo; coordina la collana Scaglie d’archivio dell’Archivio di Stato di Milano, per la quale ha curato il volume Squarci d’interni. FESR Fondo europeo di sviluppo regionale - Le opportunità non hanno confini Sotto il segno della vipera In copertina Gian Cristoforo Romano e collaboratori, Gian Galeazzo Visconti riceve la signoria di Milano, particolare del Monumento -

Nuova Gabbia
Luchino Visconti, Jacopo da Bologna and Petrarch: Courting a Patron* Elena Abramov-van Rijk In the musical repertory of the Trecento, no more than four compositions are unequivocally dedicated to a contemporary secular ruler: two madrigals, Lo lume vostro and O in Italia , and two motets, Lux purpurata/Diligite iustitiam and Laudibus dignis . The addressee of all four is the Milanese ruler Luchino Visconti (ca. 1292- 1349): the madrigal Lo lume vostro contains the acrostic LUCHINUS, and the motets have LUCHINUS VICECOMES and LUCHINUS DUX respectively; the madrigal O in Italia provides information on the birth of Luchino’s twin sons, Luchino Novello and Giovanni, on Friday, August 4, 1346. Whereas the first three * The first part of this article was presented at the Medieval and Renaissance Music conference in Barcelona, July 2011. I am grateful to Dorothea Baumann and Aldo Menichetti for their help in the early stages of this work, to Lucia Marchi for her suggestions, and to Sergei Abir. I owe my special thanks to Bonnie Blackburn and Leofranc Holford-Strevens for their comments and advice, and my kind regards to Biblioteca Medicea Laurenziana in Florence and Biblioteca Uni - versitaria in Padua for the permission of reproducing. Abbreviations used: FP Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Panciatichiano 26 Pit Paris, Bibliothèque Nationale de France, f. it. 568 Reina Paris, Bibliothèque Nationale de France, n. acq. fr. 6771 (Reina Codex) SL Firenze, San Lorenzo, Archivio Capitolare 2211 Sq Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Palatino 87 (Squarcialupi Codex) 7 elena abramov-van rijk compositions are known to have been written by Jacopo da Bologna, the motet Laudibus dignis is transmitted anonymously and fragmentarily: only one voice, apparently a triplum , has survived. -

Decreto Del Direttore Amministrativo N
Corso di Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’Età Contemporanea Tesi di Laurea LA BATTAGLIA DEL CASTAGNARO 11 MARZO 1387 TRACOLLO DEI SIGNORI DELLA SCALA Relatore Ch. Prof. Giorgio Ravegnani Co Relatori Ch Prof Luciano Pezzolo Ch Prof. Sergio Zamperetti Laureando Cristian Sartori Matricola 690798 Anno Accademico 2013 / 2014 INDICE INTRODUZIONE Pag. 2 SGUARDO D’INSIEME Pag. 3 VERONA E GLI SCALIGERI Pag. 12 PADOVA E I CARRARESI Pag. 79 LA PRECEDENTE CAMPAGNA Pag. 99 GLI ESERCITI RIVALI Pag. 108 I CAPITANI Pag. 126 LA BATTAGLIA Pag. 140 IL CAMPO DI BATTAGLIA OGGI Pag. 171 CONCLUSIONI Pag. 173 BIBLIOGRAFIA Pag. 180 1 INTRODUZIONE Penso di essere una persona fortunata perché, nel corso della mia formazione scolastica, ho avuto la fortuna d’incontrare sempre degli insegnanti molto capaci e ricordo, con particolare gratitudine, tra i miei maestri elementari, quello che mi ha contagiato con la sua passione per lo studio della storia. Avevo da poco imparato a leggere e, fra i primi regali, ricevetti un libro di storia che parlava di cavalieri, campi di battaglia, di schieramenti di eserciti; ne sono rimasto molto colpito e ho continuato, nel tempo, a cercare e leggere saggi di storia militare. Proprio assecondando questa passione, nei primi anni ’90, allora studente di ben altra facoltà, giurisprudenza, iniziai ad acquistare dei piccoli volumi, tradotti dall’inglese, che parlavano di eserciti ed episodi bellici nelle varie epoche. In uno di questi, m’imbattei in una breve descrizione della battaglia del Castagnaro che veniva definita l’esempio classico delle battaglie combattute in Italia nel periodo oggetto di questa ricerca. -

The States of Italy History of Verona Am
www.cristoraul.org THE STATES OF ITALY HISTORY OF VERONA A. M. ALLEN 1 www.cristoraul.org PREFACE THERE is no need to explain the origin of this attempt to write the history of Verona, the inherent fascination of the subject speaks for itself. But I cannot let this volume appear without expressing my sincere thanks to all who have assisted me during its preparation. First and foremost I desire to thank the cavaliere Gaetano da Re, of the Biblioteca Comunale at Verona, who, during my two visits to Verona, in 1904 and 1906, placed at my disposal the treasures both of the library and of his learning with the most generous kindness, and since then has settled more than one difficult point. From the other officials of this library, and those of the other libraries I visited, the Biblioteca Capitolare at Verona, the Biblioteca Marciana and the Archivio di Stato (in the Frari) at Venice, and the Archivio Gonzaga at Mantua, I met with the same unfailing and courteous assistance. Among modern works I have found Count Carlo Cipolla’s writings on Verona and his scholarly edition of the early Veronese chroniclers invaluable, while J. M. Gittermann’s Ezzelino III. da Romano, E. Salzer’s Ueber die Anfange der Signorie in Oberitalien, and H. Spangenberg’s Cangrande I are all of the first importance for various periods of Veronese history. My thanks are also due to Miss Croom-Brown, who constructed the three maps, the result of much careful research, and to my cousin, Mr. Alfred Jukes Allen, who read the proofs with minute accuracy. -

Les Compagnies D'aventure En Italie. Ascenseurs Sociaux Et Mondes
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by HAL-ENS-LYON Les compagnies d'aventure en Italie. Ascenseurs sociaux et mondes parall`elesau milieu du XIVe si`ecle Armand Jamme To cite this version: Armand Jamme. Les compagnies d'aventure en Italie. Ascenseurs sociaux et mondes parall`eles au milieu du XIVe si`ecle.Le petit peuple dans l'Occident m´edi´eval. Terminologies, perceptions, r´ealit´es,PU Sorbonne, pp.347-363, 2002. <halshs-00270084> HAL Id: halshs-00270084 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00270084 Submitted on 3 Apr 2008 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Les compagnies d'aventure en Italie : ascenseurs sociaux et mondes parallèles au milieu du XIV e siècle. L'histoire des compagnies d'aventure est souvent résumée par le destin des condottieri, personnages emblématiques des difficultés politiques de la péninsule italienne, voire témoins d'une démilitarisation de la société citadine sur fond de crise des valeurs communales 1. L'accent mis sur ces ambitieux capitaines a inexorablement tourné les regards vers leur âge d'or, le Quattrocento, et attribué aux siècles précédents un rôle de faire-valoir introductif 2. -

Cesare Cantù
Cesare Cantù Margherita Pusterla: racconto storico - Lettor mio, hai tu spasimato? - No. - Questo libro non è per te. 1833. CAPITOLO PRIMO. Entrando il marzo del 1340, i Gonzaga signori di Mantova avevano aperta una corte bandita nella loro città, con tavole disposte a chiunque venisse, con musici, saltambanchi, buffoni, fontane che sprizzavano vino, tutta insomma la pompa colla quale i tirannelli, surrogatisi ai liberi governi in Lombardia, procuravano di stordire i generosi, allettare i vani, ed abbagliare la plebe, sempre ingorda dietro a queste luccicanti apparenze. Fra i tremila cavalieri concorsi a quella festa con grande sfoggio d'abiti, colle più belle armadure che uscissero dalle fucine di Milano, con destrieri ferrati persino d'argento, v'erano comparsi molti Milanesi per fare la corte al giovinetto Bruzio, figliuolo naturale di Luchino Visconti, signor di Milano. Sono fra essi ricordati Giacomo Aliprando, Matteo Visconti fratello di Galeazzo e di Bernabò, che poi divennero principi; il Possidente di Gallarate, il Grande de' Crivelli, e sovra gli altri segnalato Franciscolo Pusterla, il più ricco possessore di Lombardia, e sarebbesi potuto dire il più felice, se la felicità potesse con beni umani assicurarsi, e se da quella non fosse precipitato al fondo d'ogni miseria, come il processo del nostro racconto dimostrerà. Questi campioni milanesi avevano riportato il premio della giostra ivi combattutasi, il quale consisteva in un superbo puledro del valore di 400 zecchini, nero come una pece, colla gualdrappa color di cielo, ricamata ad argento; in un altro, mezzano di grossezza, baio di colore e balzano di due piedi: oltre a due abiti, uno di scarlatto, l'altro di sciamito foderato di vaio. -

Nodi Politici (E Intertestuali) Tra Boccaccio E Petrarca
Heliotropia 12–13 (2015–16) http://www.heliotropia.org Nodi politici (e intertestuali) tra Boccaccio e Petrarca no studio dedicato ai rapporti tra Petrarca e Boccaccio sul piano po- litico potrebbe essere così ampio e ricco da trasformarsi quasi in una U storia del Trecento attraverso lo sguardo di due testimoni che furono profondamente coinvolti nella realtà del loro tempo, e che vissero due esi- stenze tanto intrecciate quanto distanti: basti pensare all’incrocio dei loro destini nella Napoli di re Roberto, teatro della giovinezza e delle prime opere di Boccaccio e “trampolino” per l’incoronazione capitolina di Petrarca, o al loro primo incontro, nel 1350, che segnò anche il primo ingresso del padre dell’umanesimo a Firenze, la patria in cui il “municipale” Boccaccio avrebbe tentato invano di riportare il “cosmopolita” Petrarca, che invece pochi anni dopo scelse di vivere il resto della sua vita nell’Italia del Nord, divenendo quello che “potrebbe essere considerato il primo grande scrittore padano.”1 Io qui mi limiterò a porre l’attenzione su alcuni contatti che chiamano in causa affinità e soprattutto divergenze nel pensiero e nell’atteggiamento dei due autori, nella convinzione che le accorte strategie attraverso cui Petrarca costruisce un’immagine di sé e del proprio percorso biografico e le modalità con cui Boccaccio prende talvolta le distanze dallo stesso Petrarca richie- dano di indagare nelle pieghe dei testi. Le mie considerazioni dunque si muoveranno soprattutto sul terreno dell’intertestualità, con tutti i problemi che comportano l’accreditamento e la definizione della pertinenza dei ri- scontri. Essendo anzi pienamente consapevole dei possibili rischi di soprav- valutazione, tengo ad avvertire che non ho la pretesa di segnalare tanto con- tatti intenzionali o la cui direzione sia facilmente determinabile, quanto di illuminare i risvolti concettuali che emergono facendo reagire tra loro i te- sti.2 1 Santagata 1992, 21. -

Mercenari E Compagnie Di Ventura
PE DRO NAVARRO E I CORSARI DEL TIRRENO MATERIALI DI APPROFONDIMENTO MERCENARI E COMPAGNIE DI VENTURA ra la fine del duecento e i primi del trecento, nascono le prime (masnade) mercenarie, non sono più i liberi cittadini dei comuni, che in armi fanno quadrato attorno al car- roccio, ma non sono ancora i professionisti della guerra, che vedremo in seguito. Sono cavalieri senza terra, esuli, vagabondi, contadini, servi o schiavi fuggiaschi, disposti ad uccidere per campare. Molti appartengono a quelle truppe mercenarie, calate in Italia al seguito dei vari re e imperatori, la loro terra d’origine è la Germania e il Brabante, perciò molti sono chiamati (brabanzoni) ovvero l’Aragona e la Castiglia. Il loro abbigliamento è va- riegato, un breve saio, un berretto di cuoio, lo zaino sulle spalle con il cibo, al fianco una spada tcorta e acuta, e una lancia. Non conoscono la disciplina, non avevano uno stipendio e vivevano di rapine e di saccheggi. Scorrazzavano per la penisola, a volte si prestavano al soldo di qualche capitano del popolo, che li chiamava a combattere per questo o per quel comune. Occorrerebbe una disciplina, Pisa ci prova stendendo un codice di comportamento, ma per questi masnadieri la legge scritta è inutile, vivono alla giornata, non vogliono imposizioni dra- stiche, un rapido ingaggio, e al termine liberi come il vento. Alcuni mercenari venuti in Italia al seguito di Giovanni di Boemia nel 1333, si raccolgono in gruppo nel piacentino alla Badia della Colomba, sotto il nome di Cavalieri della Colomba, vivono di rapina, Perugia li chiama vuole liberarsi dal giogo d’Arezzo. -

Gian Maria Varanini
Gian Maria Varanini Bibliografia degli scritti (1978-2008) • Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. • Ricerche recenti sulla storia dell'Università di Padova (Recensione a "Quaderni per la storia dell'Università di Padova", nn. 1-6), in "Scriptorium", XXXII (1978), pp. 100-106. • I beni feudali di Pradelle di Gazzo e la villa Montanari. Nota d'archivio , in "Vita veronese", XXXII (1979), pp. 132-137. • La Curia di Nogarole nella pianura veronese fra Tre e Quattrocento. Paesaggio, amministrazione, economia e società , in "Studi di storia medioevale e di diplomatica", IV (1979), pp. 45-263. • Note sui consigli civici veronesi (sec. XIV-XV). In margine ad una ricerca di J. E. Law , in "Archivio veneto", s. V, CXII (1979), pp. 5-32. • L'autore dell'arca Guantieri in S. Maria della Scala a Verona , in "Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona", s. VI, XXXI (1979-80), pp. 239-251 (ristampato in La cappella Guantieri in S. Maria della Scala a Verona. Il restauro degli affreschi di Giovanni Badile e dell'arca , a cura di M. Cova, Verona 1989, pp. 113-121). • Un codice trascritto in casa di Pietro Del Monte studente a Padova , in "Quaderni per la storia dell'Università di Padova", XIII (1980), pp. 147-149. • Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati , Verona 1980. • Venezia e la terraferma nel Quattrocento e nel Cinquecento (Cronaca del 'Seminario di ricerche sui rapporti fra Venezia e la terraferma nei secoli XV-XVI', Padova 1979), in "Critica storica", XVII (1980), pp. -

Una Regina a Parabiago
Ecomuseo del Paesaggio Città di Parabiago Assessorato alle politiche ambientali Una regina a Parabiago 300 anni dalla visita di Elisabetta Cristina di Brunswick a Parabiago Gli e-book dell’Ecomuseo Ecomuseo del Paesaggio Città di Parabiago Assessorato alle politiche ambientali Una regina a Parabiago 300 anni dalla visita di Elisabetta Cristina di Brunswick a Parabiago a cura di: Alessandra Colonna (stagista Ist. Maggiolini), Simone Rossoni (ufficio Agenda 21), Raul Dal Santo (coordinatore Ecomuseo del paesaggio) FONTI BIBLIOGRAFICHE Marco Ceriani “ Storia di Parabiago ”, Parabiago 1948 Alessandro Giulini “ Soggiorno di Elisabetta Cristina nel Convento dei Cistercensi di Parabiago ”, dall'Archivio Storico Lombardo (1901), vol. XV, pag. 354, Riportato da Marco Ceriani “ Storia di Parabiago ”, 1948. M.L. Gatti Perer “ La chiesa ed il convento di S.Ambrogio della Vttoria a Parabiago ”, Milano, 1966, ed. La Rete E. Turri “Il Paesaggio come teatro ”, Marsilio, 2003 Immagini e informazioni nei riquadri tratte da: www.wikipedia.it l’enciclopedia libera sul web e da http://commons.wikimedia.org/ . Per maggiori informazioni sull’Ecomuseo del Paesaggio: www.comune.parabiago.mi.it link “agenda 21” – “Ecomuseo” L’Ecomuseo del Paesaggio è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 13/2007 1. Introduzione Questo opuscolo rientra tra le attività previste dal Piano di Azione dell’Ecomuseo del Paesaggio (Azione 3 –“Riabita il passato”), ed è il tentativo di far rivivere pagine di storia “positiva” e magari dimenticata che ha interessato la città di Parabiago. «La storia come la vita» scrive la signora Maria Luisa Ciprandi di San Lorenzo di Parabiago «spesso privilegia i fatti bellicosi, piuttosto che i fatti di pace, di festa e di gioia.