Camera Dei Deputati Senato Della Repubblica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La-Banda-Della-Magliana.Pdf
INDICE 1. La Banda della Magliana.................................................................................................................... 2. La struttura criminale della Banda della Magliana............................................................................. 3. Banda della Magliana......................................................................................................................... 4. Una Banda tra mafia, camorra e servizi segreti.................................................................................. 5. I rapporti tra la Banda della Magliana e Licio Gelli........................................................................... 6. I ricatti della Banda............................................................................................................................ 7. Gli intrecci pericolosi della Banda della Magliana............................................................................ 8. Dall’assassinio di Carmine Pecorelli alla fuga di Calvi..................................................................... 9. La mala romana e la Mafia................................................................................................................. 10. Vita e morte della gang romana........................................................................................................ 11. Banda della Magliana: i padroni di Roma........................................................................................ 12. Omicidio di Roberto Calvi.............................................................................................................. -
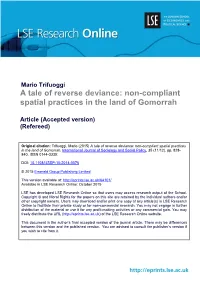
A Tale of Reverse Deviance: Non-Compliant Spatial Practices in the Land of Gomorrah
Mario Trifuoggi A tale of reverse deviance: non-compliant spatial practices in the land of Gomorrah Article (Accepted version) (Refereed) Original citation: Trifuoggi, Mario (2015) A tale of reverse deviance: non-compliant spatial practices in the land of Gomorrah. International Journal of Sociology and Social Policy, 35 (11/12). pp. 828- 840. ISSN 0144-333X DOI: 10.1108/IJSSP-10-2014-0076 © 2015 Emerald Group Publishing Limited This version available at: http://eprints.lse.ac.uk/64101/ Available in LSE Research Online: October 2015 LSE has developed LSE Research Online so that users may access research output of the School. Copyright © and Moral Rights for the papers on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. Users may download and/or print one copy of any article(s) in LSE Research Online to facilitate their private study or for non-commercial research. You may not engage in further distribution of the material or use it for any profit-making activities or any commercial gain. You may freely distribute the URL (http://eprints.lse.ac.uk) of the LSE Research Online website. This document is the author’s final accepted version of the journal article. There may be differences between this version and the published version. You are advised to consult the publisher’s version if you wish to cite from it. A TALE OF REVERSE DEVIANCE: NON-COMPLIANT SPATIAL PRACTICES IN THE LAND OF GOMORRAH Mario Trifuoggi [email protected] Abstract Racketeering local activities, though less relevant in terms of financial turnover, still represents a distinctive feature of mafia-like organisations for it provides them with striking social power. -

Sul Concetto Di “Contronome” in Gomorra Di Roberto Saviano
ONOMÀSTICA 4 (2018): 49–62 | RECEPCIÓ 7.1.2018 | ACCEPTACIÓ 27.7.2018 Sul conceto di “contronome” in Gomorra di Roberto Saviano Giacomo Giuntoli [email protected] Abstract: Nel 2006 Mondadori pubblica Gomorra, libro di Roberto Saviano che presto diventa un caso editoriale fnendo per varcare anche i confni nazionali. Alcuni fra gli aspeti a torto meno studiati di questo romanzo sono i nomi presenti in esso e un con- ceto che merita di essere con atenzione analizzato, quello di “contronome”, cioè il soprannome che gli afliati alle cosche mafose danno ai membri di spicco. Questo è un conceto fondamentale per comprendere la rifessione onomastica che sta alla base del libro di Saviano. L*obietivo di questo saggio è spiegare questo conceto complesso atraverso alcuni esempi sia onomastici che toponomastici come quelli di Francesco Schiavone, deto “Sandokan” o di Las Vegas, una zona degradata di Napoli Nord che prende il nome dalla famosa cità americana. Parole chiave: Roberto Saviano, onomastica leteraria, toponomastica, “contronome”, soprannome, leteratura italiana On the Concept of “Countername” in Roberto Saviano’s Gomorra Abstract: In 2006 Mondadori published Gomorra, a book by Roberto Saviano that soon became a literary sensation and thanks to which the young Italian writer became fa- mous all over the world. Some of the least studied aspects of this fction are prop- er names and a concept that deserves to be carefully analyzed, that of “contronome” (countername). “Contronome” refers to the nickname that the members of the mafa gangs used to give to their most important members. Tis is a fundamental concept to understand the onomastic refection that underlies Saviano’s book. -

Analysis of Organized Crime: Camorra
PREGLEDNI ČLANCI UDK 343.974(450) Prihvaćeno: 12.9.2018. Elvio Ceci, PhD* The Constantinian University, New York ANALYSIS OF ORGANIZED CRIME: CAMORRA Abstract: Organized crime is a topic that deserves special attention, not just in criminal science. In this paper, the author analyzes Italian crime organizations in their origins, features and relationships between them. These organizations have similar patterns that we will show, but the main one is the division between government and governance. After the introductory part, the author gives a review of the genesis of the crime, but also of the main functions of criminal organizations: control of the territory, monopoly of violence, propensity for mediation and offensive capability. The author also described other organizations that act on the Italian soil (Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Napolitan Camora i Apulian Sacra Coroina Unita). The central focus of the paper is on the Napolitan mafia, Camorra, and its most famous representative – Cutolo. In this part of the paper, the author describes this organization from the following aspects: origin of Camorra, Cutulo and the New Organized Camorra, The decline of the New Organized Camorra and Cutolo: the figure of leader. Key words: mafia, governance, government, Camorra, smuggling. INTRODUCTION Referring to the “culturalist trend” in contemporary criminology, for which the “criminal issue” must include what people think about crime, certain analysts study- ing this trend, such as Benigno says, “it cannot be possible face independently to cultural processes which define it”.1 Concerning the birth of criminal organizations, a key break occured in 1876 when the left party won the election and the power of the State went to a new lead- ership. -

Camorra: È Di Nuovo «Guerra» Ieri a Napoli Massacrati in 4
t f *T V 1>*S •" -^ ** *\7' •*! .,-«, _*. ^ * *«£, -*•- • F**JtX » - * ì • • *- *"* » •«.*•*-•>* - * -- f *•*•; PAG. 2 l'Unità ATTUALITÀ Sabato 3 aprile 1982 Ottaviano, dove finisce lo Stato Dopo l'assassinio di Semerari è finita la singolare «tregua» degli ultimi giorni 200 mila lire Camorra: è di nuovo «guerra» per un metro di terra Ieri a Napoli massacrati in 4 Salgono così a 88 le vittime dall'inizio dell'anno - Nel 1981, alla stessa data, i morti erano 51 - La «sorpresa» La metà per che Cutolo aveva preparato alla Nuova Famiglia per Pasqua e che doveva trasformarsi in un massacro Dalla nostra redazione Con questi quattro omicidi NAPOLI — Puntuale, come la «lista» dei «morti di morte sfondo anch'esso sanguino violenta» a Napoli e in pro un omicidio so del «misterioso» caso Se- vincia, si allunga — quest* merari-Cirillo, è arrivata u- anno - a 88. Lo scorso anno, n'altra strage delle Camorre. quando già si levavano alte Dopo quindici giorni di cal le grida d'allarme, erano (al ma, inspiegabilmente rispet la stessa data) solo 51. La *> \ «iv^KSOSK^^ VNV tata in questi ultimi giorni guerra tra le bande, che ave dell'affare Cirillo, è riesplosa va trovato una strana «pau :| la tempesta. In poco meno di sa» (la stessa registrata du ventiquattro ore altri quat rante i giorni del rapimento tro personaggi di media e Cirillo, a causa della presen piccola «taglia* nelle gerar za di un grosso spiegamento chie della criminalità orga di forze dell'ordine) negli ul nizzata, sono stati ammazza timi quindici giorni, è dun ti —anzi «massacrati» — a que ripresa con la «quotidia colpi di pistola e di lupara. -

Luciano Violante
<pre> PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE indi DEL VICEPRESIDENTE PAOLO CABRAS indice</pre> <pre>Comunicazioni del presidente: Violante Luciano, Presidente 2657, 2658, 2659 2660, 2661, 2665, 2666, 2667 Brutti Massimo 2658, 2666 Buttitta Antonino 2663 Cabras Paolo 2661, 2666 D'Amato Carlo 2666 Frasca Salvatore 2659, 2660, 2661, 2666, 2667 Matteoli Altero 2661 Sorice Vincenzo 2664 Tripodi Girolamo 2664 Discussione della relazione sulla criminalità in Puglia: Violante Luciano, Presidente 2667, 2670, 2673, 2674 2675, 2676, 2677, 2678 Brutti Massimo 2677, 2678 Cafarelli Francesco 2670, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676 D'Amato Carlo 2676 Frasca Salvatore 2677, 2678 Matteoli Altero 2668 Robol Alberto, Relatore 2667, 2668, 2675 Sorice Vincenzo 2672, 2676 Allegati: Documenti prodotti dall'onorevole Francesco Cafarelli 2679 Pag.2656 Pag.2657 La seduta comincia alle19. (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente). Comunicazioni del presidente. PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei dare una informativa riguardante sia le date e l'organizzazione dei nostri lavori, sia il prosieguo della nostra attività in seguito all'audizione del dottor Parisi e del generale Mei. In ordine alle date, avverto che esiste un problema per la missione a Bologna della prossima settima. Il dottor Latini, procuratore della Repubblica di Bologna, dovendosi presentare dinanzi al Consiglio superiore della magistratura il 21 settembre avrebbe preferito partire un giorno prima. Personalmente il dottor Latini non mi ha detto nulla, tanto che il problema è stato sottolineato dal prefetto. Tra l'altro, anche il collega Cabras ha segnalato la sua impossibilità ad assicurare la sua presenza per il 20 settembre. Se i colleghi fossero d'accordo, si potrebbe spostare il sopralluogo in Emilia-Romagna al 27 e 28 settembre, anticipando la visita a Barcellona Pozzo di Gotto al 20 settembre: ciò consentirebbe al dottor Latini di superare le difficoltà incontrate. -

Litorale Domizio Con Grattacieli E Funivie Masterplan Di Sogni Per Una Terra Desolata
anno XVIII n.1 14 novembre 2018 Periodico della Scuola di Giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli diretto da Marco Demarco Reportage Gli inviati di Inchiostro da Ischitella a Sessa Aurunca. L’emergenza immigrazione, i progetti e le oasi verdi Litorale domizio con grattacieli e funivie Masterplan di sogni per una terra desolata. Sarà firmato dall’archistar Andreas Kipar L’EDITORIALE Il litorale della vergogna in un polo di attrazione turi- Il cinema stica. La riviera romagnola del Sud. È l’intenzione del La storia Dopo i registi governatore Vincenzo De Luca. Il lungo declino La grande ascesa Per questo motivo, la Regione ha presentato un Master- gli architetti plan di riqualificazione della costa domizio-flegrea. del litorale del set d’autore Tra i progetti presentati, uno particolarmente ambizio- Marco Demarco Una storia lunga oltre duemila Castel Volturno è diventata so: quello del Comune di Mondragone. ome Norma Desmond in anni: da centro termale di epo- la nuova frontiera del cine- Il piano è trasformare l’ex Idac Food da gigantesco eco- Viale del tramonto anche il ca romana a terra di camorra, ma impegnato. Con il profes- mostro ad albergo di lusso, con tanto di funivia diretta C litorale domizio sogna i bei cementificazione e immigra- sor Lando, una panoramica al porto. tempi di una volta, quando dai zione incontrollata. sull’importanza di questo set. Campi Flegrei al Garigliano era Messina e Damato a pagg. 2-3 Sorice a pag. 4 Iadanza a pag. 12 tutto un susseguirsi di spiagge, pi- nete e stabilimenti balneari. Al tempo delle prime Cinquecen- to e dei mangiadischi, la festa si ce- lebrava nei picnic del fine settima- na. -

L'inferno Dei Viventi Non E` Qualcosa Che Sara`
Camera dei Deputati —8— Senato della Repubblica XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI INTRODUZIONE 1. Viaggio nell’inferno « L’inferno dei viventi non e` qualcosa che sara`; se ce n’e` uno, e` quello che e` gia` qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo piu` . Il secondo e` rischioso e esige attenzione e appren- dimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non e` inferno e farlo durare, e dargli spazio », cosı` Italo Calvino nelle sue « citta` invisibili ». Anche il vasto universo della camorra napoletana si presenta come un inferno e, quel che piu` conta, rende inferno tutto cio` su cui si dispiega e anche in questo caso vi sono due modi per non soffrirne: accettare l’inferno magari negativizzan- dolo in maniera assoluta, senza tentare di indagarne le sue articolate ramificazioni, oppure impegnarsi in una analisi specifica dei suoi tratti caratterizzanti, dei suoi nuclei essenziali, dei suoi nodi fondamentali, perche´ l’inferno sia sempre piu` ridotto e, in prospettiva, eliminato nella sua configurazione e, ancor piu` decisivamente, nelle sue cause. E` questa seconda opzione la scelta che appare necessaria ed urgente, una scelta che non e` solo necessaria ma anche possibile per la corrispondenza e l’alimento che essa certamente ritrova nelle grandi energie del popolo di Napoli e della Campania, nelle risorse anche culturali e morali della citta` e della regione, nelle ricche esperienze di rinnovamento di tante citta` e tanti comuni. -

Le Cosche Tornano a Colpire. Ucciso Il Sindaco Anti-Camorra
Questo è l'articolo scritto da Roberto Saviano dieci anni fa dopo il delitto del sindaco di Pollica Angelo Vassallo da la Repubblica del 5 settembre 2020 Le cosche tornano a colpire: ucciso il sindaco anti-camorra di ROBERTO SAVIANO DUE pistole che sparano, le pallottole che colpiscono al petto, un agguato che sembra essere anche un messaggio. Così uccidono i clan. Così hanno ucciso Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, in provincia di Salerno. Si muore quando si è soli, e lui - alla guida di una lista civica - si opponeva alle licenze edilizie, al cemento che in Cilento dilaga a scapito di una magnifica bellezza. Ma Angelo Vassallo rischia di morire per un giorno soltanto e di essere subito dimenticato. Come se fosse normale, fisiologico per un sindaco del meridione essere vittima dei clan. E invece è uno scandalo della democrazia. Del resto - si dice - è così che va nel sud, accade da decenni. «Veniamo messi sulla cartina geografica solo quando sparano. O quando si deve scegliere dove andare in vacanza», mi dice un vecchio amico cilentano. In questo caso le cose coincidono. Terra di vacanze, terra di costruzioni, terra di business edilizio che «il sindaco-pescatore» voleva evitare a tutti i costi. Questa estate è iniziata all' insegna degli slogan del governo sui risultati ottenuti nella lotta contro le mafie. Risultati sbandierati, urlati, commettendo il grave errore di contrapporre l' antimafia delle parole a quella dei fatti. Ma ci si deve rendere conto che non è possibile delegare tutto alle sole manette o al buio delle celle. Senza racconto dei fatti non c' è possibilità di mutare i fatti. -

La Tesi Camorra Non Spiega Tutto Nel Carcere Dove Cutolo Detta Legge
Sabato 3 aprile 1982 ATTUALITÀ l'Unità PAG. 3 Gli scritti inviati al boss Cutolo e alla segretaria Altre due lettere di Semerari Continua così l'oscura regia? La tesi camorra non spiega tutto Gli investigatori battono la pista delle bande criminali e sospettano don Raffaele - Un appunto del professore che, prima di essere assassinatoissinato, rinnega un'intervista — Contraddizioni — I probabili rapporti con Rotondi ASCOLI — Una panoramica del carcere Dal nostro inviato da Semerari come un uomo Cosa effettivamente Se selvaggiamente il professore poi procedere alla sanguino NAPOLI — Il professor Aldo di spiccata intelligenza, di e- merari affermi nelle due sono stati gli uomini dì Um sa esecuzione. Semerari probabilmente co levate capacità, un uomo ca missive non si sa. I carabi berto Ammattirò (clan della Ma non s'era detto che a Così vivono camorristi e terroristi ad Ascoli nosceva bene l'uomo chiave pace di persuadere e di tra nieri sono convinti, comun «Nuova Famiglia») o quelli di prelevare il professore dall' del «giallo-, l'ambiguo Luigi scinare la gente e che non que, che siano state scritte sì Raffaele Cutolo (clan della albergo di via Caracciolo e- Franco Rotondi. Semerari dovrebbe stare in carcere ma da Semerari, ma in assoluto «Nuova Camorra.)? Una rano stati gli uomini dì Am- era in buoni rapporti, al di là dovrebbe ricevere le cure di stato di costrizione. Insom chiave — si osserva — po maturo, il boss che aveva bi dei suoi interessi professio cui ha bisogno. Nell'appunto ma, lettere estorte, quasi det trebbe essere il messaggio al sogno, anche lui, di un refer nali, con il boss Raffaele Cu to medico? E l'assegno di due Nel carcere dove Cutolo Semerari accusa la Trapani tate. -
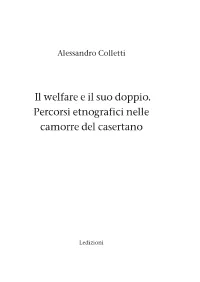
Il Welfare E Il Suo Doppio. Percorsi Etnografici Nelle Camorre Del Casertano
Alessandro Colletti Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Ledizioni © 2016 Ledizioni LediPublishing Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy www.ledizioni.it [email protected] Alessandro Colletti, Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Prima edizione: febbraio 2016 ISBN Cartaceo: 978-88-6705-426-8 Copertina e progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni I ricavi dai diritti d’autore saranno devoluti al Comitato Don Peppe Diana di Casal di Principe Indice Prefazione di Antonio La Spina 5 Introduzione 11 Metodi e fonti 17 Parte Prima. Un’analisi delle forme di egemonia delle mafie: tra controllo e assistenza 27 1. Il controllo territoriale nella storia delle camorre 29 Il riconoscimento istituzionale del potere camorrista 34 Il controllo territoriale nell’area campana 39 2. Forme organizzative e redistributive: la “cassa comune” 49 Le mafie come organizzazioni professionali 50 Il funzionamento della “cassa comune” 53 I capi cambiano, la struttura resta: dal “clan Bardellino-Iovine” al “clan dei casalesi” 63 3. La protezione sociale delle camorre casertane 73 Il clan La Torre 76 Il clan Belforte 82 I clan Schiavone e Bidognetti: alleati, federati, separati 89 Gerarchia e livelli stipendiali: il clan Schiavone 94 Forme di assistenza nei clan del casertano 101 Parte Seconda. Le politiche socio-assistenziali nella provincia di Caserta: un welfare (s)finito 113 1. Analisi delle forme di welfare pubblico: il sistema italiano 115 I territori del welfare: dallo Stato agli enti locali 118 Il livello territoriale dei servizi sociali 123 2. Zona di contatto: servizi alla persona nella provincia casertana 135 La dimensione territoriale dei servizi nella governance regionale 140 Uno sguardo alle pratiche locali di welfare nell’area casertana 143 Il welfare raccontato da chi lo dirige: le interviste ai coordinatori degli Uffici di Piano 148 3. -

La Traduzione Di Gomorra, Dal Libro Al Film. Un'analisi Relativa a Italiano
Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Tjapke Van Quickenborne La traduzione di Gomorra, dal libro al film. Un’analisi relativa a italiano, francese e nederlandese. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in het Vertalen 2016 Promotor Prof. Dr. Manuela Caniato Vakgroep Vertalen Tolken Communicatie ABSTRACT Questo studio analizza la traduzione di due categorie di realia, cioè i soprannomi e i titoli, nelle versioni nederlandese e francese del libro Gomorra di Roberto Saviano e nei sottotitoli nederlandesi e francesi dell’omonimo film diretto da Matteo Garrone. In questa tesi si esamina quali sono le strategie traduttive utilizzate per la resa dei soprannomi e dei titoli e con quale frequenza esse vengono impiegate. L’individuazione delle strategie traduttive è basata sulla classificazione presentata da Pedersen (2011). L’analisi è basata su un corpus che contiene tutte le frasi e le loro traduzioni in nederlandese e francese in cui sono presenti soprannomi o titoli, sia nel film che nel libro. Oltre all’analisi quantitativa delle strategie traduttive, viene fatta anche un’analisi qualitativa di alcuni esempi. L’analisi dimostra principalmente che nella sottotitolazione l’omissione viene impiegata frequentemente per rendere i soprannomi e i titoli, sia in nederlandese che in francese. Nel libro invece ci sono maggiori differenze tra le due lingue. Nel caso dei soprannomi, la ritenzione è la strategia più frequentemente utilizzata in entrambe le lingue. Questo è anche il caso in nederlandese per la resa dei titoli onorifici e professionali, mentre in francese si opta più spesso per la sostituzione. Anche la strategia della traduzione diretta viene impiegata con una frequenza abbastanza alta in entrambe le lingue per la resa dei titoli.