L'inferno Dei Viventi Non E` Qualcosa Che Sara`
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sul Concetto Di “Contronome” in Gomorra Di Roberto Saviano
ONOMÀSTICA 4 (2018): 49–62 | RECEPCIÓ 7.1.2018 | ACCEPTACIÓ 27.7.2018 Sul conceto di “contronome” in Gomorra di Roberto Saviano Giacomo Giuntoli [email protected] Abstract: Nel 2006 Mondadori pubblica Gomorra, libro di Roberto Saviano che presto diventa un caso editoriale fnendo per varcare anche i confni nazionali. Alcuni fra gli aspeti a torto meno studiati di questo romanzo sono i nomi presenti in esso e un con- ceto che merita di essere con atenzione analizzato, quello di “contronome”, cioè il soprannome che gli afliati alle cosche mafose danno ai membri di spicco. Questo è un conceto fondamentale per comprendere la rifessione onomastica che sta alla base del libro di Saviano. L*obietivo di questo saggio è spiegare questo conceto complesso atraverso alcuni esempi sia onomastici che toponomastici come quelli di Francesco Schiavone, deto “Sandokan” o di Las Vegas, una zona degradata di Napoli Nord che prende il nome dalla famosa cità americana. Parole chiave: Roberto Saviano, onomastica leteraria, toponomastica, “contronome”, soprannome, leteratura italiana On the Concept of “Countername” in Roberto Saviano’s Gomorra Abstract: In 2006 Mondadori published Gomorra, a book by Roberto Saviano that soon became a literary sensation and thanks to which the young Italian writer became fa- mous all over the world. Some of the least studied aspects of this fction are prop- er names and a concept that deserves to be carefully analyzed, that of “contronome” (countername). “Contronome” refers to the nickname that the members of the mafa gangs used to give to their most important members. Tis is a fundamental concept to understand the onomastic refection that underlies Saviano’s book. -

Donne E Potere: Nuovi Ruoli Femminili Nell’Organizzazione Camorristica
Corso di laurea in Comunicazione e società DONNE E POTERE: NUOVI RUOLI FEMMINILI NELL’ORGANIZZAZIONE CAMORRISTICA Relatore: Prof. Fernando DALLA CHIESA Tesi di laurea di: Viola BIANCHESSI Matricola: 797010 Anno accademico 2013/2014 INDICE RINGRAZIAMENTI ……………………………….……………pag. 3 PREFAZIONE …………………………….…………..…………..pag. 5 I. DONNA E AMBIENTE SOCIALE 1.1 La camorra…………………………………………………….…..pag. 8 1.2 Società clan e famiglia…………………………………………...pag. 12 1.3 L’ambiente e la storia in cui nasce la donna camorrista…………pag. 15 1.3.1 La donna camorrista nell’Ottocento…………….….pag. 15 1.3.2 La donna camorrista oggi……………………..……pag. 17 1.4 Profili delle donne camorriste…………………………………...pag. 20 II. DONNE DI CAMORRA, COSA NOSTRA E ‘NDRANGHETA A CONFRONTO 2.1 Donne “invisibili”………………………………………….....….pag. 25 2.2 Strutture organizzative…………………………………………...pag. 26 2.3 Figure femminili a confronto…………………………………….pag. 29 2.3.1 Ruolo materno e riproduzione della cultura………..pag. 29 2.3.2 Violenza agita…………………………………….....pag.31 2.3.3 Custodi del potere maschile…………………..……pag. 34 III. DONNE E POTERE 3.1 La scalata ai vertici………………………………………………pag. 37 3.2 Capesse: casi empirici……………………………………………pag. 40 3.3 Donne “emancipate”…?............................................................... pag. 44 IV. DONNE DI CAMORRA E PENTITISMO 4.1 Collaboratori e testimoni di giustizia: l’evoluzione giuridica……pag. 47 4.1.1 Carmelina Prisco………………………….………..pag. 50 4.2 Donne che “non parlano”………………………………………...pag. 52 4.3 Le prime collaboratrici di giustizia……………………...………..pag.54 4.3.1 Anna Carrino e Angela Barra………………………pag. 55 4.3.2 Antonella Madonna………………………………...pag. 57 - 1 - CONCLUSIONI ………………………………………………….pag. 59 BIBLIOGRAFIA ………….……….....………………….……….pag. 62 SITOGRAFIA E ALTRE FONTI ……...…………………….…pag. 64 - 2 - RINGRAZIAMENTI Vorrei esprimere i miei ringraziamenti alla professoressa Gabriella Gribaudi e al Dottor Isaia Sales. -

Commissione Parlamentare D'inchiesta
SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI XIV LEGISLATURA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITA` ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA 73ª SEDUTA MERCOLEDI` 20 LUGLIO 2005 Presidenza del Presidente Roberto CENTARO TIPOGRAFIA DEL SENATO (320) Senato della Repubblica–2– Camera dei deputati XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI INDICE Seguito della discussione del documento su Napoli PRESIDENTE: CENTARO (FI), senatore ..............Pag. 3, 6, 14 e passim BOBBIO (AN), senatore ...............46, ...., ...., e passim DALLA CHIESA (Margh-U), senatore .... 19 FLORINO (AN), senatore ..............37, 43, 57 LUMIA (DS-U), onorevole .............23, 37, 52 e passim NAPOLI Angela (AN), onorevole ........ 43 NOVI (FI), senatore .................. 14 SINISI (Margh-U), onorevole ........... 3, 6 Sull’ordine dei lavori PRESIDENTE: CENTARO (FI), senatore ..............Pag.63 LUMIA (DS-U), onorevole ............. 62 Senato della Repubblica–3– Camera dei deputati XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI I lavori hanno inizio alle ore 20,35. Seguito della discussione del documento su Napoli PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione sul documento di Napoli, sospesa nella seduta del 12 luglio scorso. SINISI. Voglio anzitutto ringraziare la Commissione per avere voluto accogliere la proposta di affrontare la questione riguardante Napoli e la sua Provincia non attraverso una rituale discussione della pura documen- tazione acquisita all’esito delle audizioni, ma affrontando un dibattito, an- che con celerita`. Credo sia doveroso esprimere un ringraziamento per avere accettato questo metodo. Signor Presidente, articolero` il mio intervento in tre parti: la prima riguarda la bozza di relazione che ci e` stata presentata; la seconda con- cerne proposte integrative rispetto alla relazione; la terza parte riguarda proposte specifiche di intervento. -

Bardellino, Infatti, Viene Legalizzato E Si Lega Con Il Gruppo All'epoca
Camera dei Deputati —33— Senato della Repubblica XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Bardellino, infatti, viene legalizzato e si lega con il gruppo all’epoca dominante in Sicilia facente capo a Stefano Bontade. Lo stesso Bardellino, coadiuvato dall’altro diarca del clan Mario Iovine, accresce notevolmente il suo peso quando si schiera all’interno della Nuova Famiglia con una posizione anche di preminenza, nella lotta ai cutoliani. I cutoliani che pure erano riusciti a fare proseliti nel casertano vengono completamente annientati – ad eccezione di pochi soggetti, lasciati confluire nelle fila dei casalesi (si v. il gruppo Di Girolamo di Aversa) ed ad eccezione del gruppo operante in Marcianise e zone viciniori di cui si parlera` – ed il gruppo dei casalesi acquisisce la forza sufficiente per porsi come il principale referente di tutte le organiz- zazioni delinquenziali casertane. Con Bardellino nasce una struttura di tipo confederativo; i clan anche operanti in realta` piu` distanti – si pensi a quelli dell’area mondragonese o sessana – vengono di fatto risucchiati nella struttura unitaria, che pur lasciando una sua autonomia alle singole entita`si organizza con una sorta di cupola, il cui centro e` proprio nel gruppo dei casalesi. L’organizzazione camorristica casertana ruoto`, unita e compatta, intorno alla figura di Antonio Bardellino fino alla fine del 1987. E con Bardellino che il clan opera il salto di qualita` e comincia ad intessere significativi rapporti con il mondo della locale politica e delle istitu- zioni, controllando, ad esempio, le attivita` dei comuni di Casale e di San Cipriano. Ai primi del 1988, inizio`, con l’omicidio di Domenico Iovine, all’interno di essa, un conflitto tra i gruppi egemoni facenti capo ad Antonio Bardellino e a Mario Iovine, che culmino` nell’uccisione di Bardellino, nel maggio del 1988, in Brasile, da parte di Mario Iovine. -

Le Cosche Tornano a Colpire. Ucciso Il Sindaco Anti-Camorra
Questo è l'articolo scritto da Roberto Saviano dieci anni fa dopo il delitto del sindaco di Pollica Angelo Vassallo da la Repubblica del 5 settembre 2020 Le cosche tornano a colpire: ucciso il sindaco anti-camorra di ROBERTO SAVIANO DUE pistole che sparano, le pallottole che colpiscono al petto, un agguato che sembra essere anche un messaggio. Così uccidono i clan. Così hanno ucciso Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, in provincia di Salerno. Si muore quando si è soli, e lui - alla guida di una lista civica - si opponeva alle licenze edilizie, al cemento che in Cilento dilaga a scapito di una magnifica bellezza. Ma Angelo Vassallo rischia di morire per un giorno soltanto e di essere subito dimenticato. Come se fosse normale, fisiologico per un sindaco del meridione essere vittima dei clan. E invece è uno scandalo della democrazia. Del resto - si dice - è così che va nel sud, accade da decenni. «Veniamo messi sulla cartina geografica solo quando sparano. O quando si deve scegliere dove andare in vacanza», mi dice un vecchio amico cilentano. In questo caso le cose coincidono. Terra di vacanze, terra di costruzioni, terra di business edilizio che «il sindaco-pescatore» voleva evitare a tutti i costi. Questa estate è iniziata all' insegna degli slogan del governo sui risultati ottenuti nella lotta contro le mafie. Risultati sbandierati, urlati, commettendo il grave errore di contrapporre l' antimafia delle parole a quella dei fatti. Ma ci si deve rendere conto che non è possibile delegare tutto alle sole manette o al buio delle celle. Senza racconto dei fatti non c' è possibilità di mutare i fatti. -
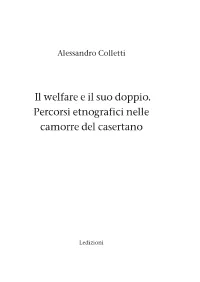
Il Welfare E Il Suo Doppio. Percorsi Etnografici Nelle Camorre Del Casertano
Alessandro Colletti Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Ledizioni © 2016 Ledizioni LediPublishing Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy www.ledizioni.it [email protected] Alessandro Colletti, Il welfare e il suo doppio. Percorsi etnografici nelle camorre del casertano Prima edizione: febbraio 2016 ISBN Cartaceo: 978-88-6705-426-8 Copertina e progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni I ricavi dai diritti d’autore saranno devoluti al Comitato Don Peppe Diana di Casal di Principe Indice Prefazione di Antonio La Spina 5 Introduzione 11 Metodi e fonti 17 Parte Prima. Un’analisi delle forme di egemonia delle mafie: tra controllo e assistenza 27 1. Il controllo territoriale nella storia delle camorre 29 Il riconoscimento istituzionale del potere camorrista 34 Il controllo territoriale nell’area campana 39 2. Forme organizzative e redistributive: la “cassa comune” 49 Le mafie come organizzazioni professionali 50 Il funzionamento della “cassa comune” 53 I capi cambiano, la struttura resta: dal “clan Bardellino-Iovine” al “clan dei casalesi” 63 3. La protezione sociale delle camorre casertane 73 Il clan La Torre 76 Il clan Belforte 82 I clan Schiavone e Bidognetti: alleati, federati, separati 89 Gerarchia e livelli stipendiali: il clan Schiavone 94 Forme di assistenza nei clan del casertano 101 Parte Seconda. Le politiche socio-assistenziali nella provincia di Caserta: un welfare (s)finito 113 1. Analisi delle forme di welfare pubblico: il sistema italiano 115 I territori del welfare: dallo Stato agli enti locali 118 Il livello territoriale dei servizi sociali 123 2. Zona di contatto: servizi alla persona nella provincia casertana 135 La dimensione territoriale dei servizi nella governance regionale 140 Uno sguardo alle pratiche locali di welfare nell’area casertana 143 Il welfare raccontato da chi lo dirige: le interviste ai coordinatori degli Uffici di Piano 148 3. -

La Traduzione Di Gomorra, Dal Libro Al Film. Un'analisi Relativa a Italiano
Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Tjapke Van Quickenborne La traduzione di Gomorra, dal libro al film. Un’analisi relativa a italiano, francese e nederlandese. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in het Vertalen 2016 Promotor Prof. Dr. Manuela Caniato Vakgroep Vertalen Tolken Communicatie ABSTRACT Questo studio analizza la traduzione di due categorie di realia, cioè i soprannomi e i titoli, nelle versioni nederlandese e francese del libro Gomorra di Roberto Saviano e nei sottotitoli nederlandesi e francesi dell’omonimo film diretto da Matteo Garrone. In questa tesi si esamina quali sono le strategie traduttive utilizzate per la resa dei soprannomi e dei titoli e con quale frequenza esse vengono impiegate. L’individuazione delle strategie traduttive è basata sulla classificazione presentata da Pedersen (2011). L’analisi è basata su un corpus che contiene tutte le frasi e le loro traduzioni in nederlandese e francese in cui sono presenti soprannomi o titoli, sia nel film che nel libro. Oltre all’analisi quantitativa delle strategie traduttive, viene fatta anche un’analisi qualitativa di alcuni esempi. L’analisi dimostra principalmente che nella sottotitolazione l’omissione viene impiegata frequentemente per rendere i soprannomi e i titoli, sia in nederlandese che in francese. Nel libro invece ci sono maggiori differenze tra le due lingue. Nel caso dei soprannomi, la ritenzione è la strategia più frequentemente utilizzata in entrambe le lingue. Questo è anche il caso in nederlandese per la resa dei titoli onorifici e professionali, mentre in francese si opta più spesso per la sostituzione. Anche la strategia della traduzione diretta viene impiegata con una frequenza abbastanza alta in entrambe le lingue per la resa dei titoli. -

900-Criminale-2.0.Pdf
A cura dell’Associazione Lapsus 2 INDICE Prefazione 6. I riti della Mafia 1. Introduzione alla mostra 7. Gli anni settanta 7.1 POLITICA, CONFLITTI E MASSONERIA: LA 2. Italia liberale ‘NDRANGHETA SI ESPANDE 2.1 LE ORIGINI DELLA ‘NDRANGHETA: LA 7.2 L’ASCESA DELLA NUOVA CAMORRA PICCIOTTERIA CALABRESE ORGANIZZATA 2.2 LA BELLA SOCIETÀ RIFORMATA 7.3 LA CONQUISTA MAFIOSA DEL NARCOTRAFFICO 2.3 LA GENESI DELLA MAFIA: UN “CRIMINOSO 7.4 LEONARDO VITALE: IL PENTITO SODALIZIO” 2.4 UN OMICIDIO ECCELLENTE IL DELITTO 8. Pentitismo e Omertà NOTARBARTOLO 9. Gli anni ottanta 2.5 LA FINE DELLA BELLA CAMORRA 9.1 IL CONSOLIDAMENTO DEL POTERE 3. Il ventennio fascista ‘NDRANGHETISTA 3.1 ‘NDRANGHETA E FASCISMO: CONFLITTO E 9.2 IL CONFLITTO TRA NUOVA FAMIGLIA E NCO INTEGRAZIONE 9.3 L’ESCALATION DELLA VIOLENZA: LA SECONDA 3.2 IL “MAGGIORE DI FERRO” GUERRA DI MAFIA 3.3 LA MAFIA AI FERRI CORTI 9.4 IL TERREMOTO DEL 1980 IN CAMPANIA E IL 3.4 SBARCO ALLEATO SISTEMA DEGLI APPALTI 9.5 GIANCARLO SIANI 4. Il dopoguerra 4.1 L’ITALIA SCOPRE LA “‘NDRANGHITA” 10. Gli anni novanta 4.2 TRA CONTRABBANDO E AGGIOTAGGIO: LA 10.1 DA SAN LUCA A DUISBURG UN PRIMATO RINASCITA DELLA CAMORRA MONDIALE 4.3 TRA CITTÀ E CAMPAGNA: IL RIASSETTO DELLA 10.2 I NUOVI EQUILIBRI IN TERRA DI CAMORRA: MAFIA L’ASCESA DEI CASALESI 4.4 LA STRAGE DI PORTELLA DELLA GINESTRA 10.3 LE STRAGI DI MAFIA E L’AVVENTO DELLA 4.5 LA MAFIA “BUONA” SECONDA REPUBBLICA 10.4 IL MAXIPROCESSO 5. -

CHAPTER I – Bloody Saturday………………………………………………………………
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY SCHREYER HONORS COLLEGE DEPARTMENT OF JOURNALISM ITALIAN WHITE-COLLAR CRIME IN THE GLOBALIZATION ERA RICCARDO M. GHIA Spring 2010 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for a baccalaureate degree in Journalism with honors in Journalism Reviewed and approved by Russell Frank Associate Professor Honors Adviser Thesis Supervisor Russ Eshleman Senior Lecturer Second Faculty Reader ABSTRACT At the beginning of the 2000s, three factories in Asti, a small Italian town, went broke and closed in quick succession. Hundreds of men were laid off. After some time, an investigation mounted by local prosecutors began to reveal what led to bankruptcy. A group of Italian and Spanish entrepreneurs organized a scheme to fraudulently bankrupt their own factories. Globalization made production more profitable where manpower and machinery are cheaper. A well-planned fraudulent bankruptcy would kill three birds with one stone: disposing of non- competitive facilities, fleecing creditors and sidestepping Italian labor laws. These managers hired a former labor union leader, Silvano Sordi, who is also a notorious “fixer.” According to the prosecutors, Sordi bribed prominent labor union leaders of the CGIL (Italian General Confederation of Labor), the major Italian labor union. My investigation shows that smaller, local scandals were part of a larger scheme that led to the divestments of relevant sectors of the Italian industry. Sordi also played a key role in many shady businesses – varying from awarding bogus university degrees to toxic waste trafficking. My research unveils an expanded, loose network that highlights the multiple connections between political, economic and criminal forces in the Italian system. -

Verbali Della Commissione Parlamentare Antimafia
<pre>CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA XI LEGISLATURA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI 51 SEDUTA DI MARTEDI' 13 LUGLIO 1993 Pagina 2217 (AUDIZIONE DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA PASQUALE GALASSO) PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE INDICE pag. Audizione del collaboratore di giustizia Pasquale Galasso: Violante Luciano, Presidente 2223, 2224, 2225 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326 2327 2328, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2340, 2343 2344, 2347, 2350, 2351, 2352 Bargone Antonio 2244, 2333 2334, 2335 Boso Erminio Enzo 2342, 2343 Borghezio Mario 2248, 2343, 2344, 2345 Brutti Massimo 2329, 2330 Butini Ivo 2330 Cabras Paolo 2229, 2239, 2243 2244, 2261 2265, 2269, 2293, 2297, 2299, 2300, 2309, 2310, 2312 2314, 2318, 2321, 2327, 2328, 2329, 2345, 2346, 2347 Cafarelli Francesco 2335, 2336 Calvi Maurizio 2298, 2329, 2350, 2351 Florino Michele 2332, 2348, 2349 Frasca Salvatore 2307, 2311, 2315, 2331 Galasso -

L'ospedale Nelle Mani Del Clan E La Visita Di Lady Camorra Di
Tiratura: 200.000 Quotidiano Data 10-12-2020 Domani Pagina 4 Foglio 1 LE MANI DEL CRIMINE SULLA SANITÀ L'ospedale nelle mani del clan e la visita di lady camorra MARIA LUISA IAVARON E E NELLO TROCCHIA A Napoli una strada divide l'ospe- ai suoi danni era stata annullata Chiha lavorato per annial San Gio- dale San Giovanni Bosco dal rione dal Tribunale del riesame che ha vanni Bosco e oggi è in pensione Amicizia, case popolari assegnate "rivisto"il suo ruolo di vertice.Sto- conosce vita, morte e miracoli di dal clan dove comanda l'Alleanza rie già viste. Nel 2001 fu arrestata quelluogo. Soprattutto i miracoli, di Secondigliano. L'alleanza è in dopo due anni di latitanza: era in- quelli compiuti da bravi medici origine una struttura criminale serita trai trenta ricercati più peri- che hanno salvato da morte sicura femmina,nata dal matrimonio di colosi, già in passato condannata centinaia di persone, che fossero tre sorelle. Si chiamano Anna,Ma- per la sua partecipazione al grup- criminali o innocenti. «Questo è ria eRita.Si sposano tre boss di ran- po criminale dell'Alleanza di Se- un ospedale di campo in una zona go,tre "omm" per dirla con le paro- condigliano. Ma non è la sola ad di guerra.Se vai a Manaus,in mez- le degli affiliati."Omm" significa aver ricevuto le cure del nosoco- zo alla foresta amazzonica,trovi il uomo ed essere omm significa ri- mio.Lì è stato assistito il padre del- triage, qui fino a qualche anno fa spetto e devozione.Le tre sorelle so- le sorelle Aieta, le tre sorelle che non c'era Arrivavie trovavi un vigi- no sposate con Francesco Maliar- hanno sposato tre boss. -

Dell'arma Dei Carabinieri
dell’Arma dei Carabinieri RassegnaQuaderno n. 5/2016 TESI DI LAUREA DEI FREQUENTATORI DEL 19° E 21° CORSO DI PERFEZIONAMENTO Anno Accademico 2012-2013 Anno Accademico 2014-2015 La teoria ecologica delle aree criminali Il caso Scampia: dal fallimento dell’urbanistica alle faide di camorra (Ten. Salvatore Beneduce) La gestione di quote societarie confiscate alla criminalità organizzata (Ten. Giovanni Riacà) Scuola Ufficiali Carabinieri, 2016 Radells’ArsmaedeigCaranbiniaeri Direttore Responsabile Gen. D. Vittorio Tomasone Redattore Capo Col. Giuseppe Arcidiacono Redazione Lgt. Remo Gonnella M.A. s.UPS. Alessio Rumori Brig. Mario Pasquale App. Sc. Lorenzo Buono Direzione e Amministrazione Via Aurelia, 511 - 00165 Roma - tel. 06-66394680 fax 06-66394746; e-mail:[email protected] Grafica, Fotocomposizione e Impaginazione a cura della Redazione Fonti iconografiche Ministero della Difesa Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Scuola Ufficiali Carabinieri La «Rassegna dell’Arma dei Carabinieri» è istituita per aggiornare la preparazione specifica dei Quadri dell’Arma offrendo loro argomenti originali sull’evoluzione del pensiero militare e delle discipline giuridiche, professionali e tecnico-scientifiche che più interessano il servizio d’Istituto. La collaborazione alla Rassegna dell’Arma è aperta a tutti. La Direzione è lieta di ricevere articoli o studi su argomenti di interesse, riservandosi il diritto di decidere la loro pubblicazione. Gli articoli di collaborazione diretta sono pubblicati sotto l’esclusiva responsabilità degli autori; le idee e le considerazioni sono personali, non hanno riferimento ad orientamenti ufficiali e non impegnano la Direzione della Rassegna. La Redazione si riserva il diritto di modificare il titolo e l’impostazione grafica degli articoli, secondo le proprie esigenze editoriali.