Senato Della Repubblica Camera Dei Deputati
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mandatory Data Retention by the Backdoor
statewatch monitoring the state and civil liberties in the UK and Europe vol 12 no 6 November-December 2002 Mandatory data retention by the backdoor EU: The majority of member states are adopting mandatory data retention and favour an EU-wide measure UK: Telecommunications surveillance has more than doubled under the Labour government A special analysis on the surveillance of telecommunications by states have, or are planning to, introduce mandatory data Statewatch shows that: i) the authorised surveillance in England, retention (only two member states appear to be resisting this Wales and Scotland has more than doubled since the Labour move). In due course it can be expected that a "harmonising" EU government came to power in 1997; ii) mandatory data retention measure will follow. is so far being introduced at national level in 9 out of 15 EU members states and 10 out of 15 favour a binding EU Framework Terrorism pretext for mandatory data retention Decision; iii) the introduction in the EU of the mandatory Mandatory data retention had been demanded by EU law retention of telecommunications data (ie: keeping details of all enforcement agencies and discussed in the EU working parties phone-calls, mobile phone calls and location, faxes, e-mails and and international fora for several years prior to 11 September internet usage of the whole population of Europe for at least 12 2000. On 20 September 2001 the EU Justice and Home Affairs months) is intended to combat crime in general. Council put it to the top of the agenda as one of the measures to combat terrorism. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -
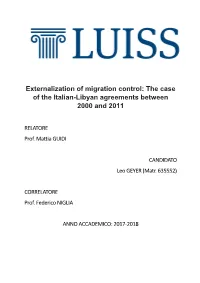
Externalization of Migration Control: the Case of the Italian-Libyan Agreements Between 2000 and 2011
Externalization of migration control: The case of the Italian-Libyan agreements between 2000 and 2011 RELATORE Prof. Mattia GUIDI CANDIDATO Leo GEYER (Matr. 635552) CORRELATORE Prof. Federico NIGLIA ANNO ACCADEMICO: 2017-2018 Acknowledgements First of all I want to thank my parents for their encouragement and invaluable support and assistance in my studies. I would also like to thank, for their help, their advice and their support, my brother Jules Geyer, my grandmother Madeleine Geyer, my cousin Maxime Di Natali, and my dear friends Louis Bachellier, Clement Parisot, Alex Azevedo, Emanuele Spina, Guillaume Willaumez, Roxane Misk, Giulio Moré, Gabriele Nictora, Francesco Costantino, Henrique Neves, Tanguy Maire du Poset, Patrick Geneit, Ambra Vaccarezza, Maria Grazia Cantarella, Marc Riewe and Virginie Matterne. Besides, I express a special gratitude to my friend Audrey Dubuc, for taking the time to print and submit this thesis for me in Brussels. I am also grateful for the help provided by my two supervisors: prof. Giacomo Orsini from ULB, his precious feedbacks, comments, and advice were very important in the redaction of this thesis, and prof. Mattia Guidi from LUISS Guido Carli who kindly accepted to supervise this thesis. Last but not least, I want to mention the importance of Kendrick Lamar’s oeuvre in my life. His music has been, during the past years, a great inspiration to me and I would not be the same person without his lyrics and melodies. I Abstract This thesis analyses the Italian externalization of migration and border management policies in Libya, to see whether and how the Europeanization and concurrent securitization of migration policies played a role to legitimize these contested policies. -
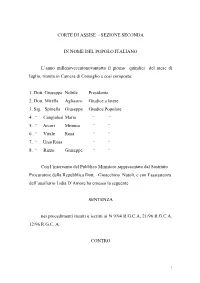
Processo Lima
CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

WP27 Saving the Lives
GRASP Working Papers - ‘Saving the lives’: analysis of a EU discourse on irregular migration in the Mediterranean Michela Ceccorulli Working Paper N° 27 December 2011 EU-GRASP Changing Multilateralism: the EU as a Global-regional Actor in Security and Peace, or EU-GRASP in short, is an EU funded FP7 Programme. EU-GRASP aims to contribute to the analysis and articulation of the current and future role of the EU as a global actor in multilateral security governance, in a context of challenged multilateralism, where the EU aims at “effective multilateralism”. This project therefore examines the notion and practice of multilateralism in order to provide the required theoretical background for assessing the linkages between the EU’s current security activities with multi-polarism, international law, regional integration processes and the United Nations system. Partners EU-GRASP is coordinated by the United Nations University – Comparative regional Integration Studies (UNU- CRIS). The other partners of EU-GRASP are based worldwide and include: University of Warwick (UK), University of Gothenburg (Sweden), Florence Forum on the Problems of Peace and War (Italy), KULeuven (Belgium), Centre for International Governance Innovation (Canada), Peking University (China), Institute for Security Studies (South Africa) and Ben-Gurion University of the Negev (Israel). Disclaimer All views and opinions are those of the authors. This paper is work in progress. Any comments are welcome and can be sent to the authors. EU-GRASP Working Papers EU-GRASP Coordination Team: Luk Van Langenhove, Francis Baert & Emmanuel Fanta Editorial Assistance: Julia Schmidt United Nations University UNU-CRIS 72 Poterierei – B-8000 – Bruges – Belgium Email: [email protected] or [email protected] Additional information available on the website: www.eugrasp.eu © 2011 by Ceccorulli. -

Mafia, Ricorre Oggi L'anniversario Degli Omicidi Dei Giudici Terranova E Saetta, E Del Maresciallo Mancuso
Mafia, ricorre oggi l'anniversario degli omicidi dei giudici Terranova e Saetta, e del maresciallo Mancuso PALERMO, 25 SETTEMBRE 2013 - Ricorre oggi l'anniversario di due agguati compiuti dalla mafia: nel 1979 fu ucciso dal giudice Cesare Terranova, insieme al maresciallo Lenin Mancuso; mentre nel 1988 persero la vita in un attentato il giudice Antonino Saetta e il figlio Stefano. Ricorre oggi il 34° anniversario della morte del giudice Cesare Terranova, ucciso a Palermo dalla mafia insieme al maresciallo Lenin Mancuso, suo collaboratore. Era il 25 settembre del 1979. Terranova e Mancuso erano attesi in via De Amicis dai killer che spararono una raffica di colpi contro di loro, mentre si trovavano in auto. Il magistrato era rientrato da poco nel capoluogo siciliano. Per due legislature era stato eletto nelle liste del Pci ed era stato membro della commissione antimafia. Si accingeva a insediarsi al posto di capo dell'ufficio istruzione di Palermo. Qualche anno prima, nel '74, aveva inchiodato Luciano Liggio, la "Primula Rossa" di Corleone. Per l'omicidio del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancuso, la corte d'assise di Reggio Calabria ha condannato all'ergastolo come mandanti i componenti della cupola di Cosa Nostra: Salvatore Riina, Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano, Francesco Madonia, Pippo Calò, Antonino Geraci, Michele Greco. Sempre il 25 settembre ma del 1988, la mafia uccideva invece lungo il viadotto Grottarossa della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta il giudice Antonino Saetta, presidente della I sezione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, e il figlio Stefano. L'agguato scattò poco prima della mezzanotte. -

Martiri Antimafia Decalogo Per I Candidati Alla Regione Vito Lo Monaco
Settimanale di politica, cultura ed economia realizzato dal Centro di Studi e iniziative culturali “Pio La Torre” - Onlus. Anno 6 - Numero 35 - Palermo 1 ottobre 2012 ISSN 2036-4865 Martiri antimafia Decalogo per i candidati alla Regione Vito Lo Monaco ue eventi, apparentemente diversi tra loro, documentano della Commissione Antimafia, in quanto magistrato che aveva l’evoluzione del percorso dell’antimafia sociale sino a con- mandato Liggio e i suoi sodali in galera per la prima volta, suc- Dcordare su principi e valutazioni storiche, impossibili ieri. cessivamente quale parlamentare nella sesta e settima legisla- Mi riferisco al documento (potete leggerlo nelle pagine successive) tura e infine, come cofirmatario della relazione conclusiva di siglato da tredici organizzazioni dell’antimafia, del lavoro, dell’im- minoranza assieme a La Torre, l’esperienza fatta nel compren- presa, dell’università indirizzato ai cittadini, alle forze politiche e ai dere il contesto sociale, economico, politico in cui si manife- candidati impegnati nel rinnovo dell’Ars e alle iniziative per il tren- stava il fenomeno mafioso e le difficoltà incontrate, giovane tatreesimo anniversario dell’uccisione del giudice Cesare Terra- magistrato, nell’opposizione della magistratura più tradizionale nova e del maresciallo Lenin Mancuso. la quale si rifiutava, per preconcetti culturali e di classe, di ca- Il documento mira a far riflettere tutti sulla drammaticità sociale ed pire la natura di associazione segreta e criminale della mafia, economica della Sicilia chiedendo che le strategie politiche di al- sino al paradosso del Pm che al processo in appello, a Bari, ar- leanza maturino solo su programmi anticrisi condivisi, non su mere rivò a definire Liggio una vittima innocente dei magistrati di Pa- scelte di potere. -

Poliziamoderna La Criminalità Organizzata Dalle
Poliziamoderna La criminalità organizzata dalle origini ai giorni nostri La medaglia d’oro alla bandiera della Polizia di Stato quest’anno premia il Servizio centrale operativo (Sco), che in ormai quasi venti anni è diventato il fulcro del coordinamento nazionale e internazionale di tutte le più impegnative indagini di criminalità organizzata e comune portate avanti dalle varie articolazioni territoriali della Polizia di Stato. Lo Sco è nata infatti nel 1989, inquadrato nella Direzione centrale della polizia criminale, come evoluzione del Nucleo centrale anticrimine, fondato nel 1984, e fin da subito ha costituito una solida protezione contro ogni tipo di delinquenza, proprio per le sue caratteristiche peculiari: una struttura agile caratterizzata da strumenti di indagine innovativi, legati, per esempio, alla gestione dei primi collaboratori di giustizia o al contrasto al crimine economico ed informatico. Nel 1998 il Servizio viene rimodulato e, nello stesso tempo, vengono istituite, presso le Squadre mobili, le Sezioni criminalità organizzata. Un modello organizzativo, sorto in origine con particolare riferimento alla lotta alle associazioni di tipo mafioso, che ha incontrato un crescente successo e che ha indotto il legislatore ad allargarne l’orizzonte investigativo in direzione della contrapposizione ad ogni forma di criminalità, fino all’inserimento nel 2005 del Servizio centrale operativo, assieme alla polizia scientifica e al Servizio controllo del territorio, nella Direzione centrale anticrimine, organismo creato nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con il fine di unificare gli uffici della Polizia di Stato a vocazione investigativa. Oggi lo Sco costituisce lo strumento di vertice nel contrasto ai grandi fenomeni criminali. -

Di Ignazio Pisani (1893-1936)
Mario Massoni Selezione dai DIARI DI IGNAZIO PISANI (1893-1936) (Prefazione di Francesco Filareto) Rossano, 2017 1 Dedico questo lavoro ai coniugi Ignazio e Antonietta Sabatini, che hanno messo a mia disposizione i fascicoli dei “Diari” dandomi il permesso per la presente pubblicazione. La loro disponibilità è stata pari alla stima e all‟affetto reciproco che ci legava e che ci legherà sempre. 2 È una fredda serata di primavera dell‟anno 1924, un uomo di 66 anni, di corporatura minuta, siede alla scrivania intento a vergare, con grafia accurata nonostante un evidente tremolio alla mano destra, le sue memorie; è dal 1893 che annota giorno per giorno ciò che accade a Rossano, in Italia e altrove, non trascurando puntuali osservazioni metereologiche e di cronaca familiare. Una luce fioca proviene dall‟abat-jour verde, sulla scrivania una montagna di quadernetti dalla copertina nera, già fittamente scritti e pronti per i posteri Ancora non sa, Ignazio, che fra tre anni diventerà il primo Podestà di Rossano, carica che reggerà a lungo e che illustrerà con opere di notevole rilievo. Soddisfazioni pubbliche e amarezze private, come quella di veder estinta la propria casata: non avrà figli e il fratello Francesco sei figlie femmine. Questo ramo dei Pisani, dopo secoli di gloria cittadina, è destinato a scomparire nel volgere di pochi anni. I suoi ”Diari” tuttavia resteranno. Qui ci sono decenni di storia e di storie annotate da un testimone attento che per quarant‟anni ha scritto tutto, giorno dopo giorno. (Massoni, Forse mi chiamavano Frate Lappo, romanzo, 2017) 3 NOTE BIOGRAFICHE IGNAZIO PISANI nasce a Rossano il 4.12.1862 da Diego e da Giuseppina dei baroni Giuranna. -

Processo Omicidio Francese
CORTE DI ASSISE DI APPELLO PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno duemiladue il giorno 13 del mese di dicembre N° 61/2002 Sent. LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO N° 30/2002 R.G. SEZIONE SECONDA N° 1314/96 N.R. composta dai Sigg.ri : D.D.A. PA 1. Dott.1 Vincenzo OLIVERI Presidente Art. ______________ 2. Dott.2 Gianfranco GAROFALO Consigliere Camp. Penale 3. Sig.3 Giovanni INCANDELA Giud. Popolare Art.______________ 4. Sig.4 Giovanni GAROFALO “ “ Campione Civile 5. Sig.5 Isabella ZUMMO “ “ 6. Sig.6 Nicola TURRISI “ “ Compilata scheda per il Casellario e per 7. Sig.7 Antonio RIGGIO “ “ l’elettorato Addì______________ 8. Sig.8 Giuseppa GIAMMARINARO “ “ Depositata in con l’intervento del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cancelleria Antonino GATTO e con l’assistenza del cancelliere B3 Sig. Addì_______________ Aurelio DI CRISTINA ha pronunziato la seguente Irrevocabile il _________________ S E N T E N Z A nei confronti di : 1) RIINA SALVATORE, fu Giovanni e Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930 ed ivi residente in via La Rua del Piano n. 13. Detenuto in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12.11.1998 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, notificata in carcere il 17.11.1998, in atto presso la Casa Circ.le di Ascoli Piceno. ASSENTE PER RINUNZIA Difensori: Avv. Cristoforo Fileccia del Foro di Palermo Avv. Domenico La Blasca “ “ 1 2) MADONIA FRANCESCO, fu Antonino e fu Trapani Rosa, nato a Palermo il 31.3.1924 ed ivi residente via Patti n. -

Senato Della Repubblica Camera Dei Deputati RESOCONTO
Senato della Repubblica Camera dei deputati Giunte e Commissioni XVI LEGISLATURA RESOCONTO STENOGRAFICO n. 78 COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere SEGUITO DELL’ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE SULLA PRIMA FASE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONDIZIONAMENTO DELLE MAFIE SULL’ECONOMIA, SULLA SOCIETA` E SULLE ISTITUZIONI DEL MEZZOGIORNO 80ª seduta: martedı` 31 maggio 2011 Presidenza del Presidente Giuseppe PISANU TIPOGRAFIA DEL SENATO (53) Senato della Repubblica–2– Camera dei deputati Commissione antimafia 78º Res. Sten. (31 maggio 2011) INDICE Sulla pubblicita` dei lavori PRESIDENTE: – PISANU (PdL), senatore .............Pag. 3 Seguito dell’esame della proposta di relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull’economia, sulla societa` e sulle istituzioni del Mezzogiorno PRESIDENTE: – PISANU (PdL), senatore .............Pag. 3, 8, 18 e passim DE SENA PD) ..................... 3 SALTAMARTINI (Pdl), senatore ........ 5 VELTRONI (PD), senatore ............. 8 PASTORE (PDL), senatore ............. 11 LUMIA (PD), senatore ................ 19 COMPAGNA (Pdl), senatore ........... 19 ORLANDO (PD), deputato .............21, 22 DELLA MONICA (PD), senatore ........ 25 GARAVINI (PD), onorevole ............ 31 LEDDI (PD), senatore ................ 34 Sui lavori della Commissione PRESIDENTE: – PISANU (PdL), senatore .............Pag. 38 MARCHETTI (PD), onorevole .......... 37 TASSONE (UDC), onorevole ........... 38 ALLEGATO ........................ 39 Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Liberta` per l’Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Liberta`: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l’Autonomia: Misto-MPA; Unione di Centro: UDC. Senato della Repubblica–3– Camera dei deputati Commissione antimafia 78º Res. -

LA MAFIA PALERMITANA Fazioni, Risorse, Violenza (1943-1993)
EDIZIONI LA MAFIA PALERMITANA Fazioni, risorse, violenza (1943-1993) di Vittorio Coco Coco, Vittorio <1980-> La mafia palermitana / Vittorio Coco – Palermo : Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre, 2010. (Collana studio e ricerca) 1. Mafia - Palermo - 1943-1993. 364.10609458231 CDD-21 SBN Pal0224465 CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace” Comitato Scientifico: Prof. Guido Corso, Prof. Alessandra Dino e Prof. Salvatore Lupo. 5 Nota editoriale di Vito Lo Monaco, Presidente Centro Pio La Torre 7 Prefazione di Salvatore Lupo, storico 9 Introduzione 11 Il contesto La Piana dei Colli e lo sviluppo urbano di Palermo dal secondo dopoguerra Parte Prima Tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Al centro della ripresa postbellica 23 Mafia ed edilizia: il costruttore Francesco Vassallo 31 L’ascesa di Angelo La Barbera 39 Da una guerra all’altra Parte Seconda Tra gli anni Settanta e Ottanta. Ai margini dopo l’antimafia 45 La perdita della centralità 51 Al fianco dei corleonesi 55 Dal maxi-processo alla riconquista dell’autonomia 61 Indice dei nomi 65 Indice dei luoghi di Vito Lo Monaco La ricerca di Vittorio Coco, a seguito di un bando pubblico del Centro Studi Pio La Torre che ha impegnato parte del contributo finanziario della Regione Sicilia, fa parte di un insieme di studi in via di pubblicazione. Per un anno tra il 2008 e il 2009 sei giovani ricercatori, guidati volontariamente da rispettivi comitati scientifici e tutor di alto profilo, hanno lavorato con tanto profitto da convincere il Centro a proseguire la ricerca nel 2010. L’idea generale della ricerca riguarda l’esplorazione della complessità del fenomeno ma- fioso tramite l’osservazione della storia e del rapporto col territorio di “famiglie” le cui relazioni interne ed esterne circoscrivono la natura specifica dell’organizzazione mafiosa e il suo rapporto organico con le classi dirigenti.