I Diari E Le Agende Di Luca Pietromarchi (1938-1940)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Download File
Italy and the Sanusiyya: Negotiating Authority in Colonial Libya, 1911-1931 Eileen Ryan Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2012 ©2012 Eileen Ryan All rights reserved ABSTRACT Italy and the Sanusiyya: Negotiating Authority in Colonial Libya, 1911-1931 By Eileen Ryan In the first decade of their occupation of the former Ottoman territories of Tripolitania and Cyrenaica in current-day Libya, the Italian colonial administration established a system of indirect rule in the Cyrenaican town of Ajedabiya under the leadership of Idris al-Sanusi, a leading member of the Sufi order of the Sanusiyya and later the first monarch of the independent Kingdom of Libya after the Second World War. Post-colonial historiography of modern Libya depicted the Sanusiyya as nationalist leaders of an anti-colonial rebellion as a source of legitimacy for the Sanusi monarchy. Since Qaddafi’s revolutionary coup in 1969, the Sanusiyya all but disappeared from Libyan historiography as a generation of scholars, eager to fill in the gaps left by the previous myopic focus on Sanusi elites, looked for alternative narratives of resistance to the Italian occupation and alternative origins for the Libyan nation in its colonial and pre-colonial past. Their work contributed to a wider variety of perspectives in our understanding of Libya’s modern history, but the persistent focus on histories of resistance to the Italian occupation has missed an opportunity to explore the ways in which the Italian colonial framework shaped the development of a religious and political authority in Cyrenaica with lasting implications for the Libyan nation. -

Scarica Il Pdf Gratuito Del Volume
CARTE SCOPERTE collana dell’Archivio Storico Capitolino 2 Direzione della collana Mariarosaria Senofonte, Laura Francescangeli, Vincenzo Frustaci, Patrizia Gori, Elisabetta Mori Consulenti scientifici Mario Bevilacqua, Marina D’Amelia, Marco De Nicolò, Anna Esposito, Francesco Giovanetti, Simona Lunadei, Paola Pavan, Maria Grazia Pastura, Carlo Maria Travaglini Segreteria di redazione Maria Teresa De Nigris e-mail: [email protected] Laura Francescangeli Politiche culturali e conservazione del patrimonio storico-artistico a Roma dopo l’Unità Il Titolo 12 “Monumenti Scavi Antichità Musei” 1871-1920 viella © 2014 Viella s.r.l. – Archivio Storico Capitolino Tutti i diritti riservati Prima edizione: giugno 2014 ISBN (carta) 978-88-6728-061-2 ISBN (e-book) 978-88-6728-251-7 Alla schedatura della serie Archivio Generale, Titolo 12 “Monumenti Scavi Antichità Musei” (1871 - 1920) hanno collaborato le dottoresse Emilia Cento, Costanza Lisi, Elena Polidori nell’ambito di un’esercitazione condotta in collaborazione con la professoressa Paola Carucci docente di Archivistica Generale presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università La Sapienza, nell’anno accademico 1993-1994. Copertina: Studio Polo 1116 viella libreria editrice via delle Alpi, 32 I-00198 ROMA tel. 06 84 17 758 fax 06 85 35 39 60 www.viella.it Indice Flavia Barca, Presentazione 7 Marco De Nicolò, Il patrimonio storico-culturale e artistico di Roma e la classe dirigente: le fonti per nuove ricerche 9 INTRODUZ I ONE 13 1. L’ Archivio Generale (1871-1922) del Comune postunitario e la serie documentaria del Titolo 12 “Monumenti Scavi Antichità Musei” 17 2. Le strutture per la tutela delle antichità e belle arti: lo Stato unitario e il Municipio di Roma Capitale 30 3. -

Trous D'archives, Trous De Mémoire?
1 Trous d’archives, trous de mémoire? Lacune degli archivi, vuoti della memoria? Actes du 9e colloque des archivistes de l’Arc alpin occidental Avignon – Rasteau – Vaison-La-Romaine (Vaucluse), 17 – 19 octobre 2019 Avignon - Chambéry - Lausanne – Torino septembre 2020 © Archivistes de l’Arc alpin occidental 2 Avertissement Seuls les résumés des interventions de Marie-Claire Pontier, Claude-France Hollard et d’Emmanuelle Combet apparaissent dans les actes, en raison de la destination de leur texte à des revues ou autres publications spécialisées. Avvertenza Gli interventi di Marie-Claire Pontier, Claude-France Hollard e di Emmanuelle Combet compaiono negli atti solo in forma di sintesi in ragione della destinazione dei loro testi a riviste o altre pubblicazioni specializzate. 9e Colloque des archivistes de l’Arc alpin occidental, Rasteau, 17-19 octobre 2019 SOMMAIRE SOMMAIRE 3 Pouvoir, mémoire, histoire : archives nécessairement lacunaires ? Marco CARASSI, Sylvie CLAIR, Gilbert COUTAZ, Jean LUQUET et Christine MARTELLA page 5 Première session – Archives publiques – Pratiques professionnelles Modérateur : Jean Luquet, directeur des Archives départementales de la Savoie Erika CRISTINA (Archives d’État de Turin) : Lacune, mancanze, tracce. Perdite, dispersioni, recuperi di documenti all’Archivio di Stato di Torino page 9 Bernard THOMAS (Archives départementales de Vaucluse) : Les archives de la légation d’Avignon. De la perte d’un fonds à sa « reconstruction » virtuelle page 21 Antonella PIERI (Surintendance archivistique du Piémont et de -

Fascist Italy's Aerial Defenses in the Second World War
Fascist Italy's Aerial Defenses in the Second World War CLAUDIA BALDOLI ABSTRACT This article focuses on Fascist Italy's active air defenses during the Second World War. It analyzes a number of crucial factors: mass production of anti- aircraft weapons and fighters; detection of enemy aircraft by deploying radar; coordination between the Air Ministry and the other ministries involved, as well as between the Air Force and the other armed services. The relationship between the government and industrialists, as well as that between the regime and its German ally, are also crucial elements of the story. The article argues that the history of Italian air defenses reflected many of the failures of the Fascist regime itself. Mussolini's strategy forced Italy to assume military responsibilities and economic commitments which it could not hope to meet. Moreover, industrial self-interest and inter-service rivalry combined to inhibit even more the efforts of the regime to protect its population, maintain adequate armaments output, and compete in technical terms with the Allies. KEYWORDS air defenses; Air Ministry; anti-aircraft weapons; bombing; Fascist Italy; Germany; radar; Second World War ____________________________ Introduction The political and ideological role of Italian air power worked as a metaphor for the regime as a whole, as recent historiography has shown. The champions of aviation, including fighter pilots who pursued and shot down enemy planes, represented the anthropological revolution at the heart of the totalitarian experiment.1 As the Fascist regime had practiced terrorist bombing on the civilian populations of Ethiopian and Spanish towns and villages before the Second World War, the Italian political and military leadership, press, and industrialists were all aware of the potential role of air 1. -

Programma ART CITY Bologna 2018
ART CITY 10 Projects ART CITY Special Project Galleria d’Arte Maggiore g.a.m. | via Massimo D’Azeglio 15 | www.maggioregam.com OTTO Gallery | via Massimo D’Azeglio 55 | www.otto-gallery.it PRIVATE TOUR | Gallerie Ascom PRIVATE TOUR | Gallerie Ascom Leoncillo Gianni Dessì. Sestante segnala mostra a cura di G.A.M. Archivio Leoncillo fino al 15 aprile 2018 | venerdì ore 10.30 - 13 / 16 - 20, sabato ore 10.30 - 24, domenica ore 10.30 - 20, ingresso gratuito ART CITY fino al 31 marzo 2018 | venerdì ore 10 - 12.30 / 16-19.30, sabato ore 10 - 12.30 / 16 - 24, domenica ore 10 - 12.30, ingresso gratuito ART CITY P420 | via Azzo Gardino 9 | www.p420.it Galleria De’ Foscherari | via Castiglione 2/b | www.defoscherari.com PRIVATE TOUR | Gallerie Ascom PRIVATE TOUR | Gallerie Ascom John Coplans & June Crespo. Foreign bodies Accademia di Belle Arti di Bologna | via delle Belle Arti 54 | www.ababo.it Vedovamazzei. Unexpected Landscapes (Paesaggi inaspettati) 3 febbraio - 31 marzo 2018 | venerdì ore 9 - 20, sabato ore 9 - 24, domenica ore 10 - 20, ingresso gratuito Program Convegno: Il ruolo del restauratore nel trasporto e allestimento di opere d’arte contemporanea fino al 10 marzo 2018 | venerdì ore 10 - 12.30 / 16 - 19 sabato ore 10 - 12.30 / 16 - 24, domenica ore 16 - 19, ingresso gratuito Palazzo Albergati | via Saragozza 28 | www.palazzoalbergati.com venerdì ore 9.30 - 13, 15 - 18, ingresso gratuito su iscrizione Galleria di Paolo Arte | Galleria Falcone Borsellino 4a/b | www.dipaoloarte.com Duchamp, Magritte, Dalí. I Rivoluzionari del ‘900 Cristian Chironi, Margherita Moscardini. -

Armiero, Marco. a Rugged Nation: Mountains and the Making of Modern Italy
The White Horse Press Full citation: Armiero, Marco. A Rugged Nation: Mountains and the Making of Modern Italy. Cambridge: The White Horse Press, 2011. http://www.environmentandsociety.org/node/3501. Rights: All rights reserved. © The White Horse Press 2011. Except for the quotation of short passages for the purpose of criticism or review, no part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical or other means, including photocopying or recording, or in any information storage or retrieval system, without permission from the publishers. For further information please see http://www.whpress.co.uk. A Rugged Nation Marco Armiero A Rugged Nation Mountains and the Making of Modern Italy: Nineteenth and Twentieth Centuries The White Horse Press Copyright © Marco Armiero First published 2011 by The White Horse Press, 10 High Street, Knapwell, Cambridge, CB23 4NR, UK Set in 11 point Adobe Garamond Pro Printed by Lightning Source All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purpose of criticism or review, no part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical or other means, including photocopying or recording, or in any information storage or retrieval system. British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library ISBN 978-1-874267-64-5 But memory is not only made by oaths, words and plaques; it is also made of gestures which we repeat every morning of the world. And the world we want needs to be saved, fed and kept alive every day. -

World War II at Sea This Page Intentionally Left Blank World War II at Sea
World War II at Sea This page intentionally left blank World War II at Sea AN ENCYCLOPEDIA Volume I: A–K Dr. Spencer C. Tucker Editor Dr. Paul G. Pierpaoli Jr. Associate Editor Dr. Eric W. Osborne Assistant Editor Vincent P. O’Hara Assistant Editor Copyright 2012 by ABC-CLIO, LLC All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, except for the inclusion of brief quotations in a review, without prior permission in writing from the publisher. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data World War II at sea : an encyclopedia / Spencer C. Tucker. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-59884-457-3 (hardcopy : alk. paper) — ISBN 978-1-59884-458-0 (ebook) 1. World War, 1939–1945—Naval operations— Encyclopedias. I. Tucker, Spencer, 1937– II. Title: World War Two at sea. D770.W66 2011 940.54'503—dc23 2011042142 ISBN: 978-1-59884-457-3 EISBN: 978-1-59884-458-0 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 This book is also available on the World Wide Web as an eBook. Visit www.abc-clio.com for details. ABC-CLIO, LLC 130 Cremona Drive, P.O. Box 1911 Santa Barbara, California 93116-1911 This book is printed on acid-free paper Manufactured in the United States of America To Malcolm “Kip” Muir Jr., scholar, gifted teacher, and friend. This page intentionally left blank Contents About the Editor ix Editorial Advisory Board xi List of Entries xiii Preface xxiii Overview xxv Entries A–Z 1 Chronology of Principal Events of World War II at Sea 823 Glossary of World War II Naval Terms 831 Bibliography 839 List of Editors and Contributors 865 Categorical Index 877 Index 889 vii This page intentionally left blank About the Editor Spencer C. -

Una Misión Fascista En América Latina: La Travesía De La R
Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. División de Historia. Una misión fascista en América Latina: la travesía de la R. Nave Italia, 1922-1924. Tesis que para obtener el grado de Maestro en Historia Internacional presenta Walter Raúl de Jesús Martínez Hernández. Asesor: Dr. Marco Zuccato. 2014. 1 Índice. Agradecimientos. 3 Introducción. 5 Capítulo I. Punto de partida. 14 Capítulo II. Una nave llamada Italia. 27 Capítulo III. La travesía Latinoamericana. 63 Capítulo IV. México: un estudio de caso. 87 Epílogo. 129 Consideraciones finales. 146 Anexo I. 154 Anexo II. 163 Fuentes. 177 2 Agradecimientos. Dedico este trabajo a mi familia, que me apoyó y reconfortó en los momentos más complicados. Agradezco infinitamente el cariño y el apoyo moral que me ha brindado la mujer con la que he compartido los últimos seis años de mi vida, Daniela Calderón Canseco. Expreso también mi agradecimiento al Ingeniero Roberto Hernández López, sin cuyo respaldo no hubiera podido concretar este y otros proyectos de vida. Mi gratitud inmensa para el profesor Stefano Tedeschi de la Università La Sapienza di Roma, quien tuvo la gentileza de aceptar y asesorar mi estancia de investigación en Italia. Doy gracias, igualmente, al Dr. Paolo Evangelisti por haberme dado orientación y asesoría personalizada durante mi labor en el Archivio Storico della Camera dei Deputati en Roma. Quiero agradecer al Dr. Marco Zuccato, mi asesor de tesis, por el compromiso que asumió con mi trabajo y todos los consejos francos y útiles que me ha dado. No olvidaré tampoco las críticas, opiniones y recomendaciones tan valiosas de la Dra. -
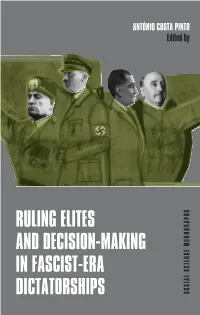
Ruling Elites.Indb
António Costa Pinto is a professor Dictators do not rule alone, and a governing elite stratum is always ANTÓNIO COSTA PINTO After the so-called ‘third wave’ of de- of politics and contemporary Euro- formed below them. This book explores an underdeveloped area in the study ANTÓNIO COSTA PINTO mocratisation at the end of the 20th pean history at the Institute of Social of fascism: the structure of power. The old and rich tradition of elite studies Edited by century had significantly increased the Sciences, University of Lisbon. He has can tell us much about the structure and operation of political power in the number of democracies in the world, been a visiting professor at Stanford dictatorships associated with fascism, whether through the characterisation of the survival of many dictatorships has University (1993) Georgetown Uni- had an important impact. Taking as the modes of political elite recruitment, or by the type of leadership, and the versity (2004), a senior associate mem- starting point the dictatorships that ber at St Antony’s College, Oxford relative power of the political institutions in the new dictatorial system. emerged since the beginning of the University (1995) and a senior visiting Analyzing four dictatorships associated with fascism (Fascist Italy, Nazi 20th century, but mainly those that fellow at Princeton University (1996) Germany, Salazar’s Portugal and Franco’s Spain), the book investigates the were institutionalised after 1945, the and at the University of California, dictator-cabinet-single party triad from -

00.Spacont38.Inizi.3A Bozza
2010, numero 38 Spagna contemporanea EDIZIONI DELL’ORSO ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI 2010, anno XIX n. 38 Spagna contemporanea EDIZIONI DELL’ORSO ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI Indice Saggi e ricerche Marcella Aglietti Simboli, archetipi e rappresentazione dell’istituto legislativo nella panflettistica politica spagnola dell’Ottocento 7 Enrico Acciai Berneri e Rosselli in Spagna. L’esperienza della “Sezione Ita- liana della Colonna Ascaso” 37 Filippo Simili Arconovaldo Bonacorsi, una breve biografia 67 Giaime Pala El frente cultural. Sobre la trayectoria de la revista “Nous Ho- ritzons” (1960-1976) 85 Elena Osorio Alonso El exilio republicano español: organizaciones de ayuda a los refugiados 109 Emanuele Treglia Alla ricerca della rivoluzione dalle fabbriche. Un’approssima- zione alla politica sindacale della ORT tra la fine del franchismo e l’inizio della Transizione 131 Fondi e fonti Alfonso Botti Rapporto dell’azione cattolica sul comunismo in Spagna e uso ecclesiastico del presunto complotto comunista del luglio 1936, alla luce della nuova documentazione vaticana 151 Rassegne e note Marco Perez Il nazionalismo basco nella riflessione storiografica: interpreta- zioni e costruzioni dell’immaginario identitario 167 Maria Elena Cavallaro La Transizione spagnola: le origini di un processo di lungo periodo 189 Laura Orlandini L’Italia e Francisco Ferrer: la risposta di piazza e la diffusione del mito 201 Luigi Paselli La guerra di Spagna di Emma Barzini 215 3 Recensioni Gabriele Pepe: una visión crítica de la guerra a comienzos del siglo XIX (Emilio La Parra López) 227 Ricardo Zabalza: retrato generacional de un líder sindical (Fernando Mendiola Gonzalo) 230 Le donne e l’Università. -

Roma XL 1871-2021
CRITICA E STORIA DELL’ARCHITETTURA Marco Spesso Roma XL 1871-2021 GENOVA RICERCA UNIVERSITY PRESS Critica e storia dell’architettura 3 Critica e storia dell’architettura 3 Collana diretta da: Guglielmo Bilancioni (Università di Genova) Marco Spesso (Università di Genova) Comitato Scientifico Benedetto Besio (Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova) Marco Biraghi (Politecnico di Milano) Alberto Giorgio Cassani (Accademia di Belle Arti di Venezia) Gian Paolo Consoli (Politecnico di Bari) Gian Luca Porcile (Università di Genova) Marco Spesso Roma XL 1871-2021 GENOVA UNIVERSITY PRESS GENOVA UNIVERSITY PRESS è il marchio editoriale dell’Università di Genova Il presente volume è stato sottoposto a double blind peer-review secondo i criteri stabiliti dal protocollo UPI © 2021 GUP Gli autori rimangono a disposizione per gli eventuali diritti sulle immagini pubblicate. I diritti d’autore verranno tutelati a norma di legge. I contenuti del presente volume sono pubblicati con la licenza Creative commons 4.0 International Attribution-NonCommercial-Share Alike. ISBN: 978-88-3618-057-8 (versione a stampa) ISBN: 978-88-3618-058-5 (versione eBook) Realizzazione Editoriale GENOVA UNIVERSITY PRESS Via Balbi, 6 - 16126 Genova Tel. 010 20951558 - Fax 010 20951552 e-mail: [email protected] http://gup.unige.it Finito di stampare gennaio 2021 Stampato presso Grafiche G7 Via G. Marconi, 18 A - 16010 Savignone (GE) e-mail: [email protected] INDICE La Communis Patria della civiltà conviviale 9 Prima, Seconda e Terza Roma: questioni di identità 33 L’opzione -

Corazzata ROMA ECCELLENZA E ABNEGAZIONE PER LA PATRIA
ROMA CAPITALE EUREKR PRESIDENZA Assemblea Capitolina COOP€RRTIVR SOCIRLE ECCELLENZA E ABNEGAZIONE PER LA PATRIA Domenico Carro CORAZZATA ECCELLENZA E ABNEGAZIONE PER LA PATRIA Ricerca storica e schede fuori testo a cura di Gennaro Barretta Cooperativa Eureka Roma, 2011 PREFAZIONE Inserito in un progetto culturale del Comune di la memoria delle grandi navi italiane e degli equipaggi che Roma questo libro vuole illustrare e commemorare uno morirono per la Patria. dei tanti esempi di eccellenza, abnegazione, eroismo legati La storia del ROMA è narrata in prima persona da un al nome della città di ROMA. personaggio immaginario, un giovane guardiamarina di La corazzata ROMA è stata una delle migliori — se prima nomina imbarcato sulla nave, che in maniera "apo- non la migliore - nave da battaglia schierata nel corso della crifa, ma veritiera" vive, giorno dopo giorno, una pagina secondi guerra mondiale. Non ha mai partecipato ad azio- drammatica della storia d'Italia. ni offensive e la storia le ha riservato un terribile destino. La scelta degli autori ha permesso di integrare le tante te- Questo libro, ben documentato ed avvincente come un stimonianze esistenti in una narrazione scorrevole, senza romanzo, si pone come obiettivo quello di mantenere viva mai derogare dalla puntigliosa esattezza storica. Il volume fa parte del progetto "Una città di eroiche memorie", realizzato con il contributo di Roma Capitale ed è distribuito gratuitamente Coordinamento editoriale Andrea Sciascia Progetto grafico e impaginazione Giovanni Morelli Testo Domenico