Scarica Il Pdf Gratuito Del Volume
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annali Del Lazio Meridionale S T O R I a E S T O R I O G R a F I a Anno VIII, N 1 – Giugno 2008
1 Annali del Lazio Meridionale S T O R I A E S T O R I O G R A F I A anno VIII, n 1 – giugno 2008 Due quaderni all’anno. Semestrale. Ambito Direttore editoriale: Antonio Di Fazio territoriale: Lazio meridionale romano, ciocia- e-mail: [email protected] ro e pontino Ambito concettuale-disciplinare: la storia e gli Comitato di redazione svolgimenti culturali del Latium vetus e adiec- A. Di Fazio, Giovanni Pesiri, tum dall’ antichità fino ad oggi. Sfondo di sto- Luigi di Pinto, Giovanni Tasciotti ria nazionale e meridionale. Ricerca storica e Massimiliano Di Fazio, discussione. Spazio didattico. Rosario Malizia, Annibale Mansillo Si collabora alla rivista solo su invito del diret- tore o di un redattore. Sono però libere le ru- Comitato scientifico briche aperte al dibattito. La responsabilità Luigi Cardi (Geografia storica, Università Orien- giuridica e scientifica rimane interamente a ca- tale di Napoli) rico dell’ autore. Dischi, foto e dattiloscritti, se Vincenzo Padiglione (Antropologia sociale, Uni- non pubblicati, possono essere ritirati solo a versità di Roma ‘La Sapienza’) cura degli stessi autori. Silvana Casmirri (Storia moderna e contempo- Gli articoli vanno consegnati in cartaceo e su ranea, Università di Cassino) floppy-disk (possibilmente in Word / Times Giovanni Pesiri (Istituto Storico del Medioevo, New Roman 11). Gli autori hanno diritto a 3 Roma) copie del fascicolo per ogni saggio e 2 copie Massimiliano Di Fazio (Archeologo - Dott. Ri- per le recensioni (3 se più di una). Per gli e- cerca - Università di Roma ‘La Sapienza’) stratti si accorderanno con l’editore. Gli interessati a recensioni e schede possono Casa Editrice ‘Edizioni di Odisseo’, via S.S. -

Processi Storici E Politichedi Pace
Provincia di Roma Università degli Studi Roma Tre Processi Storici e di Politiche Pace Rivista di Storia, Politica e Cooperazione Internazionale Processi Storici e Politiche di Pace HHistorical Processes and Peace Politics Rivista di Storia, Politica e Cooperazione Internazionale -#5A5>?->5;//@<-01881>13@1:?5?19-?5/41 -$?;=5-01881=18-E5;:55:?1=:-E5;:-8510188K5:?13=-E5;:11@=;<1- -$?@05-=1-85 -#18-E5;:55:?1=:-E5;:-851<;85?5/-5:?1=:-E5;:-81 -$?@05>@88-<-/11>@88->5/@=1EE- -1;<;85?5/- -";85?5/4105<-/105>5/@=1EE-105/;;<1=-E5;:15:?1=:-E5;:-810188K&:5;:1@=;<1- -#5A5>?-<@..85/--=?5/;855:85:3@-5?-85-:-;5:381>1/41A1:3;:;>;??;<;>?5-88- peer review. G85-=?5/;8501..;:;1>>1=15:A5-?50-88K-@?;=1A5-19-58-88-5=1E5;:1 <B@8E1=@:5;=5? %419-5:-=1->;25:?1=1>?;2?416;@=:-8-=1 -5>?;=D;2:?1=:-?5;:-8#18-?5;:>-:0;2@=;<1-::?13=-?5;: -=1-$?@051> -:?1=:-?5;:-8#18-?5;:>-:0:?1=:-?5;:-8";85?5/> -"1-/1-:0$1/@=5?D$?@051> -1;<;85?5/> -"1-/1$1/@=5?D-:0;;<1=-?5;:";85/51>;2?41@=;<1-:&:5;: %41;@=:-8<@.85>41>-=?5/81>5:?-85-:;=:385>4 [email protected]??10-=?5/81>-=1>@.61/??;<11==1A51B =?5/81>>4;@80.1>1:?.D19-58?;?4105?;=5-8!225/1<B@8E1=@:5;=5? Copyright 2016-05E5;:5 @;A-@8?@=--"8180;;=;: #;9- %18 -BBB:@;A-/@8?@=-5? '&#–#5A5>?-05->/5- =1- $/51:E1";85?5/411$;/5-85 $1??;=1;:/;=>@-81 $?;=5-01881#18-E5;:5:?1=:-E5;:-8501881$;/51?F101881>?5?@E5;:51C?=-1@=;<11 Rivista pubblicata con il contributo dei Dipartimenti: - Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” - Lingue, Letterature e Culture Straniere, Università degli Studi “Roma Tre” Processi Storici e Politiche di Pace HHistorical Processes and Peace Politics n. -

Graduatoria Regionale Continuità Assistenziale Anno
Graduatoria Unica Regionale Definitiva di Continuità Assistenziale anno 2019 Pos. Nominativo Punti Nascita Laurea Indirizzo C.A.P. Località ASL 1 PETRESCA ULDERICO 14100 27/02/1950 29/12/1976 VIA PORTUENSE 478 00149 ROMA RM3 2 MASCI VALTER 13800 21/09/1949 07/11/1978 VIA DELLA BUFALOTTA 2 00139 ROMA RM1 3 BUTTARO TOMMASO 13080 21/01/1954 07/11/1980 VIA S. GIACOMO 1 04024 GAETA LT 4 FUSCO STEFANO 12820 18/09/1954 23/12/1980 VIA MONTE DUCALE 45 04026 MINTURNO LT 5 MAZZA ROMANO 12630 30/08/1950 10/04/1979 VIA LONGARINI BGO PODGORA 3 04100 LATINA LT 6 DEL BUONO GIUSEPPE 12130 06/09/1957 12/11/1981 VIA DEGLI ESTENSI 91 00164 ROMA RM3 7 PASCUCCI BARBARA 11280 28/09/1960 12/07/1985 VIA FRECCE TRICOLORI 1 00012 GUIDONIA MONTECELIO RM5 8 RAIMONDO EUGENIO 11190 09/07/1957 30/11/1981 VIA CALCUTTA 21 00144 ROMA RM3 9 CESARINI ENNIO FRANCO 11040 31/07/1955 24/02/1983 VIA DE JOANNON 32 02025 PETRELLA SALTO RI 10 MILITELLO ROBERTO 11000 24/09/1956 28/10/1982 VIA DI VILLA MAGGIORANI 31/A 00168 ROMA RM1 11 BLASI PIERFRANCESCO 10490 30/06/1957 12/04/1984 VIA NICOLA AMORE 14 00163 ROMA RM3 12 AMICONE OTTAVIO 10330 22/04/1956 30/07/1984 PZZA DEI VESPRI SICILIANI 17 00162 ROMA RMA 13 SALERNO PAOLO 10170 27/04/1960 22/07/1985 VIA LUIGI BARTOLUCCI 11 00149 ROMA RM3 * 14 POSCOLIERI ANNA 9920 09/11/1959 23/10/1985 PIAZZA VESPRI SICILIANI 17 00162 ROMA RM1 15 CIOFFI DOMENICO 9770 03/07/1954 10/07/1979 VIA MACELLO I TRAVERSA 13/15 83012 CERVINARA AV/2 16 PIERUCCI DIANELLA 9730 02/08/1956 07/11/1983 PIAZZA MONTE BALDO 7 00141 ROMA RM1 * 17 PEZZA MARIA GRAZIA 9710 30/12/1957 26/06/1985 VIA TOR DE SCHIAVI 320 00171 ROMA RM2 18 BOSCO MARIA 9660 10/12/1958 20/03/1986 VIA FRANCO SACCHETTI 9 00137 ROMA RM1 19 D'AMATO LUIGI 9290 18/08/1954 26/07/1979 VIA VIGNA DELLA CORTE 57 84049 CASTEL SAN LORENZO SA 20 SESTITO GIUSEPPE 9150 09/01/1959 15/04/1986 VIA S ANGELA MERICI 96 00162 ROMA RM1 Medicina Generale - Stampa del 13 dicembre 2018, ore 12.42 Pagina 1 di 56 Graduatoria Unica Regionale Definitiva di Continuità Assistenziale anno 2019 Pos. -

Dott. PIERANGELO GENTILE
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM dott. PIERANGELO GENTILE . Formazione universitaria novembre 1991 - giugno 2001 Conservatorio di Musica “G. F. Ghedini” di Cuneo Diploma di Pianoforte (laurea di I livello) Data di conseguimento del titolo: 22 giugno 2001 settembre 1996 – novembre 2002 Università degli Studi di Torino Facoltà di Lettere e Filosofia Corso di laurea in Storia Laurea in Storia (110/110) Data di discussione: 6 novembre 2002. Titolo della tesi: Beneficenza e deferenza. I Savoia a Racconigi attraverso i documenti dell’archivio comunale. Relatore: Prof. Gian Carlo Jocteau novembre 2004 – ottobre 2007 Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università di Torino Dottorato di ricerca in “Storia delle società contemporanee” (XX ciclo) Data di discussione: 17 marzo 2008. Titolo della tesi: L’ombra del re. Le politiche della corte all’epoca di Vittorio Emanuele II. Tutor: Proff. Umberto Levra, Silvano Montaldo, Daniela Adorni Relatore: Prof. Paolo Colombo, Università Cattolica di Milano. 1 Giudizio finale dei tutors: Il lavoro di Gentile si basa su un’indagine approfondita di fonti sia archivistiche sia bibliografiche su un tema, quello del “partito di corte” durante il regno di Vittorio Emanuele II, ancora trascurato dalla storiografia italiana e internazionale. L’arco cronologico scelto, che ha messo in evidenza anche il periodo giovanile del “re galantuomo”, ha portato alla luce una nuova e originale interpretazione teorica del problema, distinguendo tra un “partito di corte” preunitario di matrice carloalbertina, strettamente collegato alla vecchia aristocrazia sabauda, e un “partito del re”, svincolato dai privilegi sociali garantiti dal Palazzo, ma fortemente colluso con la Corona per il contributo dato nell’assecondare le velleità di governo del sovrano. -

Fatebenefratelli"
CASA GENERALIZIA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO "FATEBENEFRATELLI" Elenco dei creditori alla data del 31.1.2017 OSPEDALE GENERALE "SM GIOVANNI Casa Ganeralizia 01181TA"-FATEBENEFRATEIII dell'Ordine OSpedaliefe di San Giovami di Via di onte Quattro Capi, Oie ISOLA 18ER,,// A.00186 39 ROMA eL 06.68371 Ospedale Generale San Giovanni Calibita "Fatebenefratelli" Debiti Tributari Euro Importo al 31 gennaio 2017 Cod. Conto Descrizione Conto 0204070102 / 102070504 DEBITI IRAP - 0204070103 IRPEF C/RITENUTE - 0204070105 / 102070505 IVA A DEBITO OSPEDALE 0 0204070110 / 102070511 IVA A DEBITO FARMACIA - 204070104 ERARIO C/IVA - Ta.Ri. (109.557) SISTRI ANNO 2014 - 004100384 Debito verso agenzia delle entrate per (132.731) imposta di registro e altre sanzioni Totale (242.288) Ospedale Generale San Giovanni Calibita "Fatebenefratelli" Debiti previdenziali Euro Cod. Conto Istituto di previdenza Importo al 31 gennaio 2017 Debiti verso Equitalia (INPS Cessioni in 204030109 (46.333.887) contenzioso) 204080102 Debiti verso Equitalia (Inps) (982.226) 204080103 Debiti verso Inail (51) 204100303 Debiti verso altri Equinps (986.513) Debiti verso altri fondi (91.676) Totale (48.394.353) Debiti verso dipendenti Euro TOTALE TFR Cod. Importo al 31 Cod. Conto Cognome e nome dipendente Codice Fiscale AGGIORNATO al gennaio 2017 Dipend. 31 gennaio 2017 0204090110 4219 ACCIAI MARIAELISA CCAMLS79D47A851Q (2.358) (4.490) 0204090110 2599 ACQUAROLO TIZIANA CQRTZN62D51A345H (10.741) (50.154) 0204090110 3778 ADINOLFI ROMINA DNLRMN70H67H501T (3.527) (15.636) -

Giuseppe Valadier Et L'arc De Titus
Coup d'oeil rétrosI)ectif DE~EK LINSTRUM FIG. 1. Giovanni Battista Wicar; portrait de Giuseppe Valadier, 1827 (Accademia di S. I~1Ica, Rome). MOnHmentHm 25(1) 43-71, 1982 44 Le premier pas que fait l'esprit de l'étranger qui aime les ruines (c'est-à-dire dont l'âme un peu mélancolique trouve du plaisir à fair abstraction de ce qui est, et à se figurer tout un édifice tel qu'on le voyait jadis, quand il était fréquenté par les hommes portant la toge); le premier pas que fait un tel esprit, dis-je, est de distinguer les restes des travaux du Moyen Age entrepris vers l'an 1300, pour servir à la défense, de ce qui fut construit plus anciennement pour donner la sensationdu beau. T{:l fit Stendhal musant sur les ruines de la Rome antique en 1828.1 Mais si son imagination pouvait se donner libre cours, en revanche il pensait-et il n'était pas le seul-qu'une réalisation en trois dimensions et avec du solide matériau neuf était pour le moins douteuse. Restaurer, écrivait-il, c'est 'deviner la forme de l'ancien bâtiment et nous en présenter les plans, cotlpeset élévations;mais qui jugera de la ressemblance?'2 Et lorsque ses pr,:>menadeslittéraires le conduisirent à l'Arc de Titus à l'extrémité est du Forum Romain, son mépris pour ce qu'il appele cette 'infamie' ne connut pas de bornes: 'Ce petit arc de triomphe si joli. ..fut le plus élégant jusqu'à l'époque fatale où il a été refait par M. -

Elenco Dei Governi Italiani
Elenco dei Governi Italiani Questo è un elenco dei Governi Italiani e dei relativi Presidenti del Consiglio dei Ministri. Le Istituzioni in Italia Le istituzioni della Repubblica Italiana Costituzione Parlamento o Camera dei deputati o Senato della Repubblica o Legislature Presidente della Repubblica Governo (categoria) o Consiglio dei Ministri o Presidente del Consiglio dei Ministri o Governi Magistratura Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Consiglio di Stato Corte dei Conti Governo locale (Suddivisioni) o Regioni o Province o Comuni Corte costituzionale Unione Europea Relazioni internazionali Partiti e politici Leggi e Regolamenti parlamentari Elezioni e Calendario Referendum modifica Categorie: Politica, Diritto e Stato Portale Italia Portale Politica Indice [nascondi] 1 Regno d'Italia 2 Repubblica Italiana 3 Sigle e abbreviazioni 4 Politici con maggior numero di Governi della Repubblica Italiana 5 Voci correlate Regno d'Italia Periodo Nome del Governo Primo Ministro 23 marzo 1861 - 12 giugno 1861 Governo Cavour Camillo Benso Conte di Cavour[1] 12 giugno 1861 - 3 marzo 1862 Governo Ricasoli I Bettino Ricasoli 3 marzo 1862 - 8 dicembre 1862 Governo Rattazzi I Urbano Rattazzi 8 dicembre 1862 - 24 marzo 1863 Governo Farini Luigi Carlo Farini 24 marzo 1863 - 28 settembre 1864 Governo Minghetti I Marco Minghetti 28 settembre 1864 - 31 dicembre Governo La Marmora Alfonso La Marmora 1865 I Governo La Marmora 31 dicembre 1865 - 20 giugno 1866 Alfonso La Marmora II 20 giugno 1866 - 10 aprile 1867 Governo Ricasoli -

Real Rome Tours
Welcome to VIVA Italian Marketplace Welcome to VIVA, Italy’s appeal is undimmed. But such our first ever success has created pressing difficulties. workshop devoted Some destinations suffer from to incoming tourism overcrowding. All need better policy co- in Italy. Ever since ordination. The regulatory environment has ETOA started in not kept pace with the changing market and 1989 Italy has been consumer behaviour. ETOA is here to a destination of discuss such matters, to facilitate better enormous importance for our members, relationships between intermediaries and who sell Europe throughout the world. In their suppliers, and to showcase new that period we have seen a huge expansion products. This is what VIVA is for. in the volume of visitors coming from such traditional markets as USA and Japan. We have welcomed the growth in arrivals from Tom Jenkins new markets such as China and India. CEO, ETOA Benvenuti a VIVA Italian Marketplace Benvenuti a VIVA, il nostro primo workshop pressanti. Alcune destinazioni soffrono di B2B dedicato al turismo in entrata in Italia. sovraffollamento. Tutte hanno bisogno di un Sin dalla nascita di ETOA nel 1989, l'Italia è migliore coordinamento politico. Il contesto stata una delle destinazioni più importanti normativo non ha tenuto il passo con il per i nostri membri, che vendono l'Europa in cambiamento del mercato e del tutto il mondo. Da allora abbiamo assistito comportamento dei consumatori. ETOA è ad un'enorme espansione del volume di qui per discutere di tali questioni, per visitatori provenienti da mercati tradizionali favorire migliori relazioni tra gli intermediari come USA e Giappone, e abbiamo accolto e i loro fornitori e per dare visibilità a nuovi con favore la crescita degli arrivi da nuovi prodotti: da questo nasce VIVA. -

Presidenti Dell'accademia Di San Luca
Presidenti dell’Accademia di San Luca 1814-16 ANDREA VICI romano, architetto 1817-19 GASPARE LANDI piacentino, pittore 1820-22 FRANCESCO MASSIMILIANO LABOUREUR romano, scultore 1823-25 GIROLAMO SCACCIA romano, architetto 1826 VINCENZO CAMUCCINI romano, pittore 1827-28 ALBERTO THORVALDSEN da Copenaghen, scultore 1829 GIULIO CAMPORESE romano, architetto 1830-31 ANDREA POZZI romano, pittore 1832 ANTONIO D ’E STE veneziano, scultore 1833-36 GASPARE SALVI romano, architetto 1837 TOMMASO MINARDI faentino, pittore 1838-40 ANTONIO SOLÀ da Barcellona, scultore 1841-43 CLEMENTE FOLCHI romano, architetto 1844-46 GIOVANNI SILVAGNI romano, pittore 1847-49 GIUSEPPE DE FABRIS da Nove di Bassano, scultore 1849-53 LUIGI POLETTI modenese, architetto 1854-55 FILIPPO AGRICOLA romano, pittore 1856-59 PIETRO TENERANI romano, scultore 1860-63 ANTONIO SARTI da Budrio, architetto 1864-66 FRANCESCO PODESTI anconitano, pittore 1867-69 PIETRO TENERANI romano, scultore 1870 VIRGINIO VESPIGNANI romano, architetto 1871-73 FRANCESCO COGHETTI bergamasco, pittore 1874-75 EMILIO WOLFF da Berlino, scultore 1876-77 VIRGINIO VESPIGNANI romano, architetto 1878 NICOLA CONSONI da Ceprano, pittore 1879 IGNAZIO JACOMETTI romano, scultore 1880-82 FRANCESCO AZZURRI romano, architetto 1883 NICOLA CONSONI da Ceprano, pittore 1884-85 FRANCESCO FABJ ALTINI da Fabriano, scultore 1884-1900 S. M. U MBERTO I Presidente onorario perpetuo 1886-87 ANDREA BUSIRI VICI romano, architetto 1888-90 CESARE MARIANI romano, pittore 1891-92 SARO ZAGARI messinese, scultore 1893-95 FRANCESCO AZZURRI romano, architetto 1896-98 ROBERTO BOMPIANI romano, pittore 1899-1900 STEFANO GALLETTI da Cento, scultore 1901 S. M. VITTORIO EMANUELE III Principe perpetuo 1901-02 ENRICO GUJ romano, architetto 1903 ROBERTO BOMPIANI romano, pittore 1904-05 GIULIO MONTEVERDE da Bistagno, scultore 1906-07 CARLO TENERANI romano, architetto 1908 CESARE MACCARI senese, pittore 1909-10 GIULIO TADOLINI romano, scultore 1911-12 GIO . -

Elenco Generale Di Ateneo Per Enti-Aziende
Anagrafica Aziende Nome Indirizzi Contatti @ MEDIASERVICE.NET SRL VIA SAN BERNARDINO, 17 10141 TORINO (TO) VIA DI GROTTE PORTELLA 6/8 00044 FRASCATI (RM) A & E TELEVISION NETWORKS ITALY VIA SALARIA 1021 SRL 00138 ROMA (RM) AASTRA ITALIA SPA VIA DI PORTA VITTORIA 9 20122 MILANO (MI) ABACO SERVIZI SRL VIA BERNARDO QUARANTA 40 20139 MILANO (MI) VIA SALARIA 290 00199 ROMA (RM) 16/07/19 9.47 Page 1 of 881 Nome Indirizzi Contatti ABARTH AND C. SPA VIA MAZZE', 121 10034 CHIVASSO (TO) ABB SACE SPA VIA VITTOR PISANI 16 20124 MILANO (MI) VIA TITO SPERI, 17 00040 POMEZIA (RM) VIA BAIONI, 35 24123 BERGAMO (BG) ABB SPA VIA VITTOR PISANI, 16 20124 MILANO (MI) VIA BAIONI, 35 24123 BERGAMO (BG) VIA DELL'INDUSTRIA, 18 20010 VITTUONE (MI) VIA ARDEATINA, 2491 00040 POMEZIA (RM) VIA FRIULI, 4 24044 DALMINE (BG) VIA E. FERMI, 14 03100 FROSINONE (FR) 16/07/19 9.47 Page 2 of 881 Nome Indirizzi Contatti VIA LUCIANO LAMA, 33 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA PESCARIA, 5 24123 BERGAMO (BG) N. DIPENDENTI AGGIORNATO AL 03.09.2012 - OO.SS. INTERNE FORNITE IN DATA 16.06.2011 - N. DIPENDENTI AGGIORNATO AL 14 11 2017 ABBOTT SRL A SOCIO UNICO S.S. PONTINA KM 52 - CAMPOVERDE DI APRILIA 04011 APRILIA (LT) VIA AMSTERDAM, 125 00144 ROMA (RM) DAL 1/08/2012 A SEGUITO DI SCISSIONE SOCIETARIA LA ABBOTT SRL HA CEDUTO I CONTRATTI E LE CONVENZIONI UNIVERSITARIE AD ABBVIE SRL, CHE SUBENTRA IN TUTTI I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAI CONTRATTI. LA ABBOTT NON AVRA' PIU' ALCUN DIRITTO OD OBBLIGO IN MERITO. -
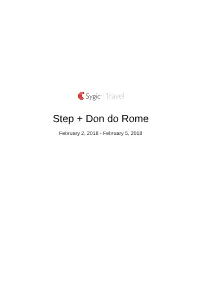
Step + Don Do Rome
Step + Don do Rome February 2, 2018 - February 5, 2018 Friday ColosseumB8 • Piazza del Colosseo, 00184 February 2, 2018 Rome Ciampino Airport F11 • Roma Ciampino Airport (Giovan Battista Pastine Airport), Via Appia Nuova B&B La Terrazza sul Colosseo 1651, 00040 Rome Ciampino, Italy B9 • Via Ruggero Bonghi 13/b, 00184 Rome Basilica of Saint Mary Major B9 • Piazza di S. Maria Maggiore, 42, 00100 Roma RM, Italy Palazzo delle Esposizioni B8 • Via Nazionale 194, Rome, Latium, 00184, Italy Church of St Andrea della Valle B8 • Corso del Rinascimento Rome, Italy 00186 Trevi Fountain B8 • Piazza di Trevi, 00187 Roma, Italy Caffè Tazza d'Oro B8 • 84 Via degli Orfani, 00186 Pantheon B8 • Piazza della Rotonda, 00186 Roma, Italy Freni e Frizioni B8 • Rome Trastevere B8 • Rome Area sacra dell'Argentina B8 • Rome Venice Square B8 • Rome Monument to Vittorio Emanuele II B8 • Piazza Venezia, 00187 Roma, Italy Trajan's Column B8 • Via dei Fori Imperiali, Roma, Italy Imperial Forums B8 • Largo della Salara Vecchia 5/6, 9 00184 Roma, Italy Forum of Augustus B8 • Via dei Fori Imperiali, Rome, Latium, 00186, Italy Forum of Trajan B8 • Via IV Novembre 94, 00187 Roma, Italy Saturday Sunday February 3, 2018 February 4, 2018 B&B La Terrazza sul Colosseo B&B La Terrazza sul Colosseo B9 • Via Ruggero Bonghi 13/b, 00184 Rome B9 • Via Ruggero Bonghi 13/b, 00184 Rome Colosseum Navona Square B8 • Piazza del Colosseo, 00184 B8 • Piazza Navona, 00186 Rome, Italy Imperial Forums Pantheon B8 • Largo della Salara Vecchia 5/6, 9 00184 Roma, Italy B8 • Piazza della Rotonda, -

Note Sul Generone Romano
Note sul generone romano } t MARCELLO GUIDI La definizione di "generone"risale alla seconda metà dell 'Ot tocento e fu coniata a Roma per distinguere una categoria di al ta borghesia danarosa dalle caratteristiche proprie, diverse da al tre classi sociali e soprattutto dall'aristocrazia, che i1 generone smaniava di frequentare ma che era allora, assai più di oggi, ri gorosamente arroccata nel suo Olimpo. I continui equivoci sul significato e sulla portata del termine "generone" nascono dal nome stesso, di assonanza indubbia mente dispregiativa, ma che riassume egregiamente le qualità e i difetti di una categoria speciale, ristretta ad un limitato numero di famiglie romane, la cui patente di appartenenza era determi nata proprio dalle origini quirite. Fanno eccezione alcune fami glie di origine straniera, quali gli Haas Spithover, i Grandjacquet o i Roesler Franz, acquisiti a una perfetta romanità da genera zioni di permanenza e di lavoro, specialmente al servizio ponti ficio. "Generone" suona male, ed il suo conio, di origine più intel lettuale che aristocratica, fu certamente malizioso in questo sen so: tanto che molti appartenenti alla categoria affermano seccati di non fame parte, pur essendone membri autorevoli. D'altro canto altri, che non hanno nessun motivo di considerarsi cittadi ni del mondo del generone, aspirano invece a farne parte, se non altro per una più precisa identificazione sociale, difficile da in .. ... ~ " ventarsi a Roma . L'etimologia del termine è controversa, perché non codifica ta: Alberto Arbasino sostiene che derivi da "genero'', e che sia 381 stata coniata da qualche aristocratico per magnificare la consi di intrecciare importanti fili nel tessuto economico romano e, più stenza finanziaria del matrimonio di una sua figlia con un ricco tardi, italiano? borghese che avrebbe rinverdito le sostanze di casa: un genero La fonte originale più frequente di ricchezza andava ricerca top, cioè, con tanti soldi.