Il Costume E` Cambiato. Una Parte Rilevante Dei Catanesi Ha Compreso
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

Processo Bagliesi
CORTE DI ASSISE DI APPELLO PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO N° 31/2008 Sent. SEZIONE PRIMA N 19/2008 R.G. L’anno duemilaotto il giorno nove del mese di dicembre composta dai Sigg.ri : Notizie di Reato N° 15489/2005 1 Dott. Innocenzo LA MANTIA Presidente Proc. Rep. PA 2 Dott. Alfredo MONTALTO Consigliere Art.___________ Camp. Penale 3 Sig. Gregoria MAURO Giudice Popol. 4 Sig. Vito PAMPALONE “ “ Art.___________ 5 Sig. Pietra MESSINEO “ “ Campione Civile 6 Sig. Giuseppa RE “ “ Compilata scheda 7 Sig. Simone LI MULI “ “ per il Casellario e 8 Sig. Emanuele FANARA “ “ per l’elettorato Addì___________ Con l’intervento del Sost. Procuratore Generale Dott.ssa DANIELA GIGLIO e con l’assistenza del Cancelliere Antonella FOTI Depositata in ha pronunziato la seguente Cancelleria Addì___________ S E N T E N Z A Irrevocabile il ______________ nei confronti di BAGLIESI Salvatore nato a Partinico (PA) il 06.02.1958 ivi res.te in Via delle Capre n.118 (dom. eletto) Arr. il 04.11.2005 scarc. il 18.12.2007 PRESENTE DIFENSORI: Avv. Mario Maggiolo Foro di Pisa Avv. Lucia Indellicati Foro di Termini Imerese con studio in Palermo Via Terrasanta, 93. PARTE CIVILE: LA CORTE Iolanda, nata a Monreale il 02.01.1970 ivi res.te in Via Verdi n.14, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui figli minori: PAGE 1 - ROSSELLO Provvidenza, nata a Palermo il 18.08.1990; - ROSSELLO Francesco, nato a Palermo il 18.02.1995; - ROSSELLO Elena, nata a Palermo il 17.07.1999; Tutti rappresentati e difesi dall’avv. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -
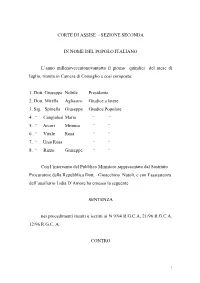
Processo Lima
CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

Il «Cacciatore» È Finito Nella Rete Catturato Santapaola
Mi'irulrili 19 indiali) 1!)!M il Fatto P i^in i 3TU La fine di Gli agenti del Servizio centrale operativo lo hanno sorpreso all'alba in una masseria nelle campagne di Caltagirone un boss Era a letto con la moglie, sotto il comodino teneva una calibro 9 Si è arreso così: «Era destino che finisse, ogni cosa finisce... » Il «cacciatore» è finito nella rete Catturato Santapaola. La «grande fuga» durava d Benedetto «Nitto» Santapaola. il capo indiscusso della mafia catanese, considerato il latitante nume ro uno di Cosa Nostra dopo la cattura di Totò Runa, è stato arrestato in una masseria nelle campagne di Granien, in provincia di Catania L'azione condotta dallo Sco e dalla squadra mobile di Catania e scatta Antonio Manganelli: ta all'alba di ieri. Il boss è stato sorpreso dagli agenti mentre dormiva assieme alla moglie «In quel momento DAL NOSTRO CORRISPONDENTE WALTER RIZZO ho pensato a Falcone» ••CAIAMA >IIcacciatore-fi deri, sul lei lo I la indosso un nalmente e diventato la preda pigiama verde si guarda attor Benedetto Santapaola, 5-1 an no «Vuole dichiarare le sue «Quando 1 operazione era conclusa, ho pensato a /ione ha subito un'accelera si iti -solo arrestali i lo'se ni considerato il capo della fa generalità per lavoic Ales zione, per presentare la cat miglia catanese di Cosa No sandro l'ansa segue la proce Giovanni Falcone Mi e già capitato, è una specie di continuano i comandare stra, il latitante ninnerò uno dura Santapaola lo guarda e automatismo, uno vorrebbe telefonargli ciao Gio tura di Nitto Santapaola co Quale ruolo -

La Commissione Regionale
LA COMMISSIONE REGIONALE Alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti analizzate diffusamente dai primi giudici, è emerso un quadro probatorio che ha consentito di tratteggiare l’evoluzione storica della Commissione regionale, istituita nel lontano 1975, dopo la crisi degli anni ’60 che aveva posto in rilievo l’esigenza di un effettivo coordinamento delle iniziative delle varie famiglie di Cosa Nostra. Su tale tema – per come già evidenziato nel libro I – in via di estrema sintesi deve convenirsi con i primi giudici che l’esigenza di un organismo di vertice, in linea con la struttura piramidale di Cosa Nostra, era stata avvertita non solo all’interno della provincia di Palermo, dove erano stati costituiti dapprima un triunvirato (nell’attesa che si completasse la ricostituzione di tutte le famiglie nei territori delle province, e poi la nuova Commissione provinciale), ma anche da parte delle altre province della Sicilia in cui esistevano analoghe strutture di Cosa Nostra che avevano anch’esse risentito dell’efficace azione repressiva dell’apparato statale nei primi anni successivi alle eclatanti attività criminali poste in essere dalla cosca di Michele Cavataio e dei suoi alleati. Le coerenti, puntuali e convergenti dichiarazioni rese da Buscetta e Calderone, la cui attendibilità in materia era stata accertata nell’ambito del primo maxiprocesso di Palermo, avevano trovato conferma anche in quelle rese da Di Carlo, il cui apporto probatorio costituisce un valido ulteriore riscontro alle predette propalazioni e la cui autonomia appare evidente, attesa la novità delle circostanze che in questo quadro unitario il dichiarante era stato in grado di inserire in modo armo- nico; novità che si giustificano con il fatto che provenivano da affiliato che, a differenza dei primi due, aveva a lungo operato a fianco del Riina e quindi nell’ambito dello schieramento corleonese, del quale il Buscetta ed il Calderone erano, invece, avversari. -

1 Dipartimento Di Scienze Politiche Cattedra Storia Dei Partiti E Dei
1 Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra Storia dei partiti e dei movimenti politici Salvatore Riina: vita criminale e organizzazione mafiosa RELATORE Prof. Andrea Ungari CANDIDATO Priscilla Roscioli Matr. 073562 ANNO ACCADEMICO 2015-2016 2 SOMMARIO Introduzione ......................................................................................................................................... 3 Cosa si intende per il termine “Mafia”? ............................................................................................... 5 ANALISI BIOGRAFICA .................................................................................................................... 8 Infanzia ................................................................................................................................................ 8 Adolescenza: i primi reati .................................................................................................................... 9 Guerra tra Corleonesi ....................................................................................................................... 10 Verso Palermo ................................................................................................................................... 11 Struttura e organizzazione di Cosa Nostra ................................................................................................. 12 Il “sacco di Palermo” ................................................................................................................................ -

In Trappola La Prìmula Rossa Di Gela «Siete Stati Veramente Bravi, Dei Veri Professionisti»
JK-~ ' "%. LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 1992 IL FATTO PAGINA ó L'UNITA L'arresto Catturato nel Vicentino il numero due di Cosa Nostra «Piddu» Madonia è stato bloccato a bordo di una Mercedes di Madonia Viveva da un mese in una villetta, circondato dai parenti L'operazione resa possibile dalle confessioni di un pentito In trappola la prìmula rossa di Gela «Siete stati veramente bravi, dei veri professionisti» «Un lavoro da professionisti. Bravi». Cosi, Piddu Ma boss quando gli 007 dell'anti perbitami di mafia. «Non donia, numero due di Cosa Nostra, ha accolto gli mafia hanno (atto scattare il avevamo avvertito i carabi agenti della Criminalpol che ieri lo hanno arrestato blitz. nieri - ha detto il vice capo Un'operazione preparata della Criminalpol Achille Ser nel Vicentino. Un'operazione iniziata sette mesi fa fin da febbraio, dopo che il ra nel corso di una conferen per catturare uno dei grandi latitanti della mafia sici pentito Leonardo Messina, za stampa a Vicenza - per liana. Ma il blitz solo per un caso non è fallito: i cara un «pezzo da novanta» della ché l'esito dell'operazione binieri, all'oscuro di tutto, stavano intervenendo in provincia di Caltanissetta, non era certa. Del resto era aveva segnalato lo sposta circa un mese che controlla sospettiti dalla presenza degli agenti in borghese. mento del boss in una città vamo la zona. Ogni momen del Nord. Per Madonia, sfug to poteva essere quello buo gito il 21 dicembre scorso ad no». Ai giornalisti che insiste un blitz a Caltanissetta, vano sull' episodio, Serra ha ENRICO FIIRRO quando la polizia scopri un risposto: «State tranquilli, •I «Complimenti: è un la morte per Giovanni Falcone covo in uria villetta vicina al non c'è nessuna conflittuali raccordo autostradale Paler tà con l'arma, il coordina voro da ven professionisti. -

I Padrini Del Ponte. Affari Di Mafia Sullo Stretto Di Messina
Tempi moderni I Padrini del Ponte Affari di mafia sullo stretto di Messina di Antonio Mazzeo Per favorire la libera circolazione della cultura, è consentita la riproduzione di questo volume, parziale o totale, a uso personale dei lettori purché non a scopo commerciale. © 2010 Edizioni Alegre - Soc. cooperativa giornalistica Circonvallazione Casilina, 72/74 - 00176 Roma e-mail: [email protected] Analisi, notizie e commenti sito: www.edizionialegre.it www.ilmegafonoquotidiano.it Indice Prefazione. Il Ponte e le mafie: uno spaccato di capitalismo reale 7 Solo pizzi e dintorni? 7 L’inchiesta Brooklyn e il contesto mondiale 8 Avvertenza e ringraziamenti 13 Capitolo uno. Brooklyn, la mafia del Ponte 17 Premiata ditta Zappia & soci... 17 «...Il Ponte lo faccio io...» 20 Il segreto d’onore 23 L’odore dei soldi 25 Il Principe Bin d’Arabia 28 Capitolo due. Il clan dei canadesi 31 A Scilla la ’ndrangheta, a Cariddi la mafia 32 Per riscuotere dall’emiro 34 Una holding made in Siculiana 36 Ci vediamo tutti al Reggio Bar 37 L’internazionale degli stupefacenti 40 L’ascesa di don Vito 42 I nuovi manager della coca 45 L’Uomo del Colosseo 48 Capitolo tre. I Signori delle Antille 53 Tra corsari e governatori 56 Le amicizie pericolose di Trinacrialand 58 Come invecchiare all’ombra del Ponte 62 Alla fine arrivò il Pippo d’America 65 Le Terrazze sullo Stretto 68 La guerra per gli appalti 69 Il ponte riemerso di Tourist e Caronte 74 Alla conquista dell’Est 77 Campione dell’undici settembre 81 Grandi mercanti sauditi 86 Kabul-Messina la rotta dei capi dei servizi segreti 89 Moschee, dissalatori, armi.. -

18 Settembre 1999
PRESIDENTE: Buongiorno. Vediamo i presenti. Graviano Giuseppe. è attivato il collegamento audiovisivo con Tolmezzo? ISPETTORE Colella: Buongiorno, signor Presidente, qui è Tolmezzo. Graviano Giuseppe è presente; e attualmente si trova in comunicazione telefonica col proprio avvocato di fiducia. PRESIDENTE: è nella saletta? Non lo vediamo. Non lo vediamo e… ISPETTORE Colella: sì, signor Presidente, perchè è in cabina telefonica. PRESIDENTE: Ah, c’è una cabina che non vediamo, va bene. Allora, intanto ci dà la sua qualità? Lei è ufficiale di Polizia Giudiziaria? ISPETTORE Colella: Sono l’ispettore Colella, Colella Antonio. PRESIDENTE: Bene. Nel caso che non ci sia già un provvedimento, lei è autorizzato a svolgere le funzioni di assistenza nell’udienza, ai sensi dell’articolo 146 disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale. Ecco, ci dà atto ora che non sono posti limitazioni, o impedimenti all’esercizio… Prego. ISPETTORE Colella: Do atto che non sono posti impedimenti, o limitazioni, all’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all’imputato. Che è attivato il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo in cui si trova l’imputato, con modalità che assicurano la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei luoghi collegati e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Do atto inoltre che è garantita la possibilità per l’imputato di consultarsi riservatamente con il proprio difensore di fiducia. PRESIDENTE: Grazie. è presente il difensore dell’imputato, l’avvocato Giangualberto Pepi, anche in sostituzione del codifensore, avvocato Salvo. Riina Salvatore. è attivato il collegamento audiovisivo con Ascoli Piceno? VICESOVRINT. Leo: Buongiorno, signor Presidente, da Ascoli. -

Dead Silent: Life Stories of Girls and Women Killed by the Italian Mafias, 1878-2018 Robin Pickering-Iazzi University of Wisconsin-Milwaukee, [email protected]
University of Wisconsin Milwaukee UWM Digital Commons French, Italian and Comparative Literature Faculty French, Italian and Comparative Literature Books Department 2019 Dead Silent: Life Stories of Girls and Women Killed by the Italian Mafias, 1878-2018 Robin Pickering-Iazzi University of Wisconsin-Milwaukee, [email protected] Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/freita_facbooks Part of the Criminology and Criminal Justice Commons, Italian Language and Literature Commons, and the Women's Studies Commons Recommended Citation Pickering-Iazzi, Robin, "Dead Silent: Life Stories of Girls and Women Killed by the Italian Mafias, 1878-2018" (2019). French, Italian and Comparative Literature Faculty Books. 2. https://dc.uwm.edu/freita_facbooks/2 This Book is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in French, Italian and Comparative Literature Faculty Books by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. DEAD SILENT: Life Stories of Girls and Women Killed by the Italian Mafias, 1878-2018 Robin Pickering-Iazzi Robin Pickering-Iazzi is Professor of Italian and Comparative Literature in the Department of French, Italian, and Comparative Literature at the University of Wisconsin-Milwaukee. She is the author of The Mafia in Italian Lives and Literature: Life Sentences and Their Geographies, published in Italian as Le geografie della mafia nella vita e nella letteratura dell’Italia contemporanea, and editor of the acclaimed volumes The Italian Antimafia, New Media, and the Culture of Legality and Mafia and Outlaw Stories in Italian Life and Literature. She is currently working on a book that examines representations of feminicide in Italian literature, film, and media. -

Giornale Storico E Letterario Della Liguria
Conto Corrente con la Posta ANNO XI - 1 55 Ó-XIII Fascicolo I - Gennaio-Marzo GIORNALE STORICO E LETTERARIO DELLA LIGURIA PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE Direttore: ARTURO CODIGNOLA Direzione e Amministrazione G E N O V A - Via Lomellini, 2 1 (Casa Mazzini) Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012 FRATELLI PAGANO TIPOGRAFI EDITORI - S. A. V IA M O N T IC E L L I, Jl - GENOVA - TELEFONO 52004 iB«iBMBi>B»f n—«B Il B«fH »**·Μ ·Μ ·~·*.·Μ ·«*»*··*«·»ί e·*·!!·*···*·:!»·«·'··«··"»* *·»··"·*Ι ·Μ·*Ι··· ·«♦·*» »«IBII ·ΙΙ ·ΙΙ·Ι1· II· UBI!· 11*1 Ι·ΙΙ ·ΙΙ·Ι Nostre Edizioni POESIE IN DIALETTO GENOVESE di Martin Piaggio • ò* edizione, curata da Giulio Gatti - Prefazione di L. A. Cervetto . · L. 1 ö .—- LA CUCINIERA GENOVESE di Gio Batta e Giovanni padre e figlio Ratto - 1 S a edizione - Prefazione di Carlo Panseri ...··· L. ö . ANNUARIO GENOVESE FRATELLI PAGANO £ Guida di Genova e Provincia (Lunario del Signor Regina) 1 1 9 ediozione · 3 0 ,« — ; i 1 — SOMMARIO = Arturo Codignola, Il credo di Mazzini - Ferruccio Sassi, E v o lu z io n e delle forme politiche Lunigianesi dal secolo X ll e! X V I - Mario Bat- tietini, Rapporti di Mazzini con democratici del Belgio. - Paola Catel, Ancora sul congresso repubblicano del 30 a p rile 1646. - Renato Giar- delli, Saggio di una bibliografia generale della Corsica. - R A S S E G N A BIBLIOGRAFICA: Arrigo Solini, L'idea dell' unità italiane nell'età napoleonica (Vito Vitale) - Ilario Rinieri, / vesto»'/ della Corsica (Adolfo Bassi) - SPIGOLATURE E NOTIZIE. Giuseppe Bisogni Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012 A n n o XI 1935*XIII F a s c ic o l o 1.° - G e n n a i o -M a r z o GIORNALE STORICO E LETTERARIO DELLA LIGURIA Direttore: A R T U R O CO D IG NO LA Comitato di Redazione : Carlo Bornate - Pietro Nurra - Vito A.