La Commissione Regionale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1 8Lf1mfl\Ffjg2 025?2
025?2 l TRIBUNALE DI PALERMO ! SEZIONE I DELLA CORTE DI ASSISE • TRASCRIZIONE DELLA BOBINA N. 04 DEL 12/05/1992 CORTE DI ASSISE DI 1 8lf1Mfl\ffJg2 Depositato in Cancelleria oggi '.....• _______________ IL COLLABORATORE 01 CANCELLERIA Il Perito Quattrocchi Marilena r ~~-~"-A9 e:eL- 025?3 ,~, P.M. Poi lei, sempre ~n questo interrogatorio, dice: "Anche la vicenda di Galati mi e stata riferita da Angelo Izzo il quale mi disse che un poliziotto si era recato ~n Inghilterra • per indurre la vedova Mattarella a riconoscere, quali autori dell'omicidio del marito, tale Prestifilippo e il Galati. Di quest'ultimo io sapevo solo quello che è pubblicato sui giornali e cioè che si trattava di un uomo che aveva fatto arrestare Michele Greco", qual'è la verità? Lo sapeva lei o gliel'aveva detto Angelo • Izzo? GIUSEPPE PELLEGRITI Ma guardi, Izzo non poteva mai dirmi una cosa del genere. lo ho detto" questo perchè, appunto, avevo sentito il fatto che Izzo aveva avuto dei contatti con questo Lopuzzo e di conseguenza 1 02544 • mi sono afferrato a quelle cianfelle ed ho scaricato tutto su Izzo. P.M. Cioè ha incolpato Izzo perchè aveva sentito da una conversazione fatta dai Giudici che lo interrogavano che Izzo aveva imbeccato • Lopuzzo. Quindi lei ha ritenuto a questo punto di potere scaricare su Izzo tutte le cose che aveva detto lei, sia quelle vere, sia quelle false. GIUSEPPE PELLEGRITI • Perfettamente. P.M. Poi lei dice anche, sempre in questo interrogatorio, spontaneamente J;'erchè evidentemente non le fu chiesto dai Giudici presenti: ••Angelo Izzo mi ha detto che dopo il mio interrogatorio da parte del dottor 2 02545 Mancuso, egli era stato chiamato da quest'ultimo (cioè dal P.M. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

23 Gennaio 1998
PRESIDENTE: Buongiorno, vediamo i presenti. Bagarella? IMPUTATO Bagarella: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Ceolan, avvocato Cianferoni; è presente l’avvocato Ceolan. Barranca Giuseppe. AVV. Cianferoni: (voce fuori microfono) Sì, Presidente, è presente anche l’avvocato Cianferoni. PRESIDENTE: Ah, c’è anche lei, grazie. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Barone e avvocato Cianferoni, che è presente. Benigno Salvatore. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Rinunciante. Avvocato Farina e avvocato Maffei, è sostituito dall’avvocato Ceolan. Brusca Giovanni: ora entrerà. Avvocato Li Gotti e avvocato Falciani. E’ presente l’avvocato Li Gotti. Calabrò Gioacchino. IMPUTATO Calabrò: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Gandolfi, Fiorentini e Cianferoni, che è presente. Cannella Cristoforo. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) E’ rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Di Peri e avvocato Rocchi, sostituito dall’avvocato Cianferoni. Carra Pietro: libero, assente. Avvocato Cosmai e avvocato Batacchi… E’ presente l’avvocato… AVVOCATO Falciani: Falciani, Presidente.. PRESIDENTE: …Falciani in sostituzione. Di Natale Emanuele: contumace. Avvocato Gentile, Di Russo, Falciani, che è presente. Ferro Giuseppe: rinunciante. Avvocato Miniati Paoli, sostituito dall’avvocato Falciani. Ferro Vincenzo: libero, assente. Avvocato Traversi e avvocato Gennai… AVVOCATO Traversi: E’ presente PRESIDENTE: E’ presente l’avvocato Traversi. Frabetti Aldo. IMPUTATO Frabetti: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Monaco, Usai, Roggero, sostituiti dall’avvocato Pepi. Giacalone Luigi. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Priola, avvocato Florio, sostituito dall’avvocato Pepi. Giuliano Francesco. IMPUTATO Giuliano: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Farina e avvocato Pepi, che è presente. Graviano Filippo: rinunciante. Avvocato Oddo, avvocato Gramigni, sostituito dall’avvocato Cianferoni. -

Mafia Carini Capaci Isola Delle Femmine E Dintorni
Mafia Carini Capaci Isola delle Femmine e dintorni Comuni sciolti per mafia 25 09 09 Uploaded by isolapulita . - News videos from around the world. Figura 1 Cipriano Santo Inzerillo Gianni SIINO dichiara: DI MAGGIO Salvatore Emanuele Io l’ho conosciuto all’interno della fattoria di Bellolampo intorno alla fine degli anni ’70. I DI MAGGIO hanno avuto varie vicissitudini in negativo all’interno dell’organizzazione mafiosa, perché messi da parte. L’ho rivisto insieme ad un DI MAGGIO detto “u’ figghiu da za’ lena” che mi venne indicato come capo della famiglia di Torretta. I due vennero a raccomandare un imprenditore di Torretta al quale ho fatto aggiudicare, perché loro me lo avevano chiesto, la scuola media di Isola delle Femmine. (Ordinanza di Custodia cautelare Operazione Oldbridge N. 11059/06 R. mod. 21 D.D.A.) Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. 1 Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. …… Ed è un dato ormai processualmente acquisito che, fino a quando il suo capo indiscusso, Gaetano BADALAMENTI, non fu espulso da Cosa Nostra, la famiglia di Cinisi costituiva uno dei più importanti mandamenti della provincia di Palermo, ricomprendendo, oltre al circondario di Cinisi e Terrasini , anche i territori di Balestrate, Carini, Capaci e Isola delle Femmine (cfr. BUSCETTA, MARINO MANNOIA e MUTOLO, nonché DI MATTEO Mario Santo). Successivamente, il mandamento venne sciolto e la famiglia aggregata al mandamento di Partinico, mentre i territori che ne avevano fatto parte furono divisi tra lo stesso mandamento di Partinico e (dopo il 1982) il neo- mandamento di San Lorenzo , dopo la ristrutturazione seguita alla conclusione della sanguinosa guerra di mafia dei primi anni ’80. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -
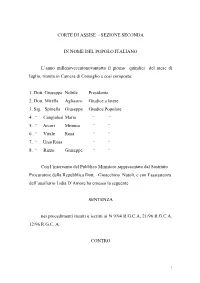
Processo Lima
CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

Privatizzazioni, Si Comincia Con Le Poste
Non dobbiamo consentire che gli ucraini facciano guerra agli ucraini. È una terribile assurdità. Ma la situazione sembra aver preso una piega tale che senza un aiuto potrebbe esserci una catastrofe. Gorbaciov lettera a Putin e Obama 1,30 Anno 91 n. 22 Venerdì 24 Gennaio 2014 Giovanni Moro Se l’ufficio diventa Calatrava e il ritorno conquista dell’attivismo un luogo di poesia il Vaticano U: Almagisti Zanon pag. 18 Francini pag. 17 Barilli pag. 20 Letta: ora conflitto d’interessi ● Il premier: vado avanti e nel patto di governo ci sarà la norma ● «Legge elettorale, i cittadini devono poter scegliere» ● Renzi: sì a modifiche con il consenso di tutti. «Se la riforma salta finisce la legislatura» «Sono deciso ad andare avanti». Enri- co Letta anticipa i contenuti del piano L’INTERVISTA del governo, che comprenderà il con- flitto d’interessi. Sull’Italicum esprime dubbi sulle liste bloccate. Renzi apre a Epifani: subito modifiche, ma solo se condivise, «se no salta tutto». Anche la legislatura. ANDRIOLO FRULLETTI A PAG. 2-3 un vero rilancio Se si batte del governo il tempo insieme MASSIMO ADINOLFI MA IL GOVERNO: CHE FINE FA? L’ac- ● cordo raggiunto da Renzi con Ber- lusconi sulla legge elettorale non risol- ve il problema, ma anzi lo pone. E non si tratta di alimentare nuovamente so- spetti sulle reali intenzioni di Renzi. Il segretario ha tagliato corto: mi accusa- vate di voler far cadere il governo per andare subito alle elezioni, e magari «Serve un’azione di governo forte a avrei pure avuto il mio tornaconto, e partire del lavoro», dice Epifani. -

Society, Culture and Mafia
Society, Culture and Mafia. An analysis of why Sicily falls behind when it comes to development Photo: http://sicily.rome-in-italy.com/ Master thesis in International Business Communication – Italian Cand.ling.merc. Copenhagen Business School, July 2008 Advisor: Susanne Gram Larsen By Ditte Roslyng Tastesen © Ditte Roslyng Tastesen 2008 Acknowledgements When first starting this project in Sicily, I experienced many obstacles, and doubted that I would succeed in completing this project. However, later in the process I was met with the kindness, which Sicilians are known for. Therefore, I would like to thank all of my interview people – they will be named later in the thesis – for taking their time and sharing so honestly their experiences and knowledge with me. Without them, this thesis would not have been possible. Particularly, I would like to thank Salvatore Costantino from University of Palermo for his guidance during my stay in Palermo. I would like to extend my thank you to other people that have crossed my way in Sicily, their openness and willingness to share have been of great use for a complete picture of the situation in Sicily. I would also like to thank Thomas Harder for his guidance in the beginning of the research process, and especially in connection with the mafia. Finally, I would like to thank Susanne Gram Larsen for guiding and encouraging me throughout the process. Her professionalism, knowledge and personal support have been invaluable and have helped me produce a project that I am proud of. Society, Culture, and Mafia Copyright © Ditte Roslyng Tastesen i Terminology British English/American English This thesis is written in British English, which in some cases have presented a problem, because I use a lot of American theorists. -

Processo Omicidio Francese
CORTE DI ASSISE DI APPELLO PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno duemiladue il giorno 13 del mese di dicembre N° 61/2002 Sent. LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO N° 30/2002 R.G. SEZIONE SECONDA N° 1314/96 N.R. composta dai Sigg.ri : D.D.A. PA 1. Dott.1 Vincenzo OLIVERI Presidente Art. ______________ 2. Dott.2 Gianfranco GAROFALO Consigliere Camp. Penale 3. Sig.3 Giovanni INCANDELA Giud. Popolare Art.______________ 4. Sig.4 Giovanni GAROFALO “ “ Campione Civile 5. Sig.5 Isabella ZUMMO “ “ 6. Sig.6 Nicola TURRISI “ “ Compilata scheda per il Casellario e per 7. Sig.7 Antonio RIGGIO “ “ l’elettorato Addì______________ 8. Sig.8 Giuseppa GIAMMARINARO “ “ Depositata in con l’intervento del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cancelleria Antonino GATTO e con l’assistenza del cancelliere B3 Sig. Addì_______________ Aurelio DI CRISTINA ha pronunziato la seguente Irrevocabile il _________________ S E N T E N Z A nei confronti di : 1) RIINA SALVATORE, fu Giovanni e Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930 ed ivi residente in via La Rua del Piano n. 13. Detenuto in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12.11.1998 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, notificata in carcere il 17.11.1998, in atto presso la Casa Circ.le di Ascoli Piceno. ASSENTE PER RINUNZIA Difensori: Avv. Cristoforo Fileccia del Foro di Palermo Avv. Domenico La Blasca “ “ 1 2) MADONIA FRANCESCO, fu Antonino e fu Trapani Rosa, nato a Palermo il 31.3.1924 ed ivi residente via Patti n. -
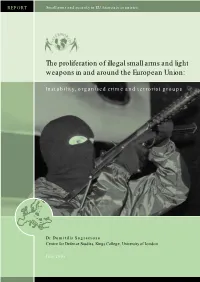
The Proliferation of Illegal Small Arms and Light Weapons in and Around the European Union
REPORT Small arms and security in EU Associate countries The proliferation of illegal small arms and light weapons in and around the European Union: Instability, organised crime and terrorist groups Dr Domitilla Sagramoso Centre for Defence Studies, Kings College, University of London July 2001 The proliferation of illegal small arms and light weapons in and around the European Union: Instability, organised crime and terrorist groups Dr Domitilla Sagramoso Centre for Defence Studies, Kings College, University of London SAFERWORLD · CENTRE FOR DEFENCE STUDIES JUNE 2001 Contents Acknowledgements 4 1. Introduction 5 2. Main findings 6 3. Recommendations 8 4. Methodology and sources 9 5. SALW in the European Union: country studies 12 United Kingdom The Netherlands Germany Italy Italian organised crime 6. SALW in EU Candidate Countries: country studies 27 Czech Republic Bulgaria 7. SALW among terrorist groups in Europe 32 Separatist movements Northern Ireland The Basque Country Corsica Right- and left-wing terrorism 8. Assessment of external sources of illegal 45 SALW in the European Union 9. Conclusions 48 Acknowledgements This report is being published as part of Saferworld’s small arms project in Central and Eastern Europe. Saferworld is grateful to the Department for International Development (DFID), UK for funding this project. Author’s acknowledgements The research was undertaken and written up by Dr Domitilla Sagramoso as part of the Centre for Defence Studies’ small arms and light weapons project funded by the Ploughshares Fund and Dulverton Trust, and conducted under the direction of Dr Chris Smith, Senior Research Fellow at the Centre for Defence Studies. The author would like to thank all those officials and journalists who helped during her various interviews in the UK, Germany, Italy, Holland, Spain, Bulgaria and the Czech Republic. -

Il «Cacciatore» È Finito Nella Rete Catturato Santapaola
Mi'irulrili 19 indiali) 1!)!M il Fatto P i^in i 3TU La fine di Gli agenti del Servizio centrale operativo lo hanno sorpreso all'alba in una masseria nelle campagne di Caltagirone un boss Era a letto con la moglie, sotto il comodino teneva una calibro 9 Si è arreso così: «Era destino che finisse, ogni cosa finisce... » Il «cacciatore» è finito nella rete Catturato Santapaola. La «grande fuga» durava d Benedetto «Nitto» Santapaola. il capo indiscusso della mafia catanese, considerato il latitante nume ro uno di Cosa Nostra dopo la cattura di Totò Runa, è stato arrestato in una masseria nelle campagne di Granien, in provincia di Catania L'azione condotta dallo Sco e dalla squadra mobile di Catania e scatta Antonio Manganelli: ta all'alba di ieri. Il boss è stato sorpreso dagli agenti mentre dormiva assieme alla moglie «In quel momento DAL NOSTRO CORRISPONDENTE WALTER RIZZO ho pensato a Falcone» ••CAIAMA >IIcacciatore-fi deri, sul lei lo I la indosso un nalmente e diventato la preda pigiama verde si guarda attor Benedetto Santapaola, 5-1 an no «Vuole dichiarare le sue «Quando 1 operazione era conclusa, ho pensato a /ione ha subito un'accelera si iti -solo arrestali i lo'se ni considerato il capo della fa generalità per lavoic Ales zione, per presentare la cat miglia catanese di Cosa No sandro l'ansa segue la proce Giovanni Falcone Mi e già capitato, è una specie di continuano i comandare stra, il latitante ninnerò uno dura Santapaola lo guarda e automatismo, uno vorrebbe telefonargli ciao Gio tura di Nitto Santapaola co Quale ruolo -

RPG Phd Thesis
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/85513 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Peña González R. Title: Order and Crime: Criminal Groups ́ Political Legitimacy in Michoacán and Sicily Issue Date: 2020-02-20 Chapter 5. Cosa Nostra: Tracking Sicilian Mafia’s Political Legitimacy At 2012, El Komander, popular Mexican "narco-singer", released his new single entitled "La mafia se sienta en la mesa" (Mafia Takes a Sit on the Table). El Komander, the artistic name of Alfredo Ríos, as well as other performers of the so-called narcocorridos (or, as it was later named, movimiento alterado) were forbidden to perform public concerts in Mexico. That was also the case in Michoacán, where a local public officer argued that Komander's ban was due to the lyric´s songs, which touch "very sensitive topics" (Velázquez, 2018). Certainly, most of his songs are dedicated to assert Mexican "narcos" as stylish and brave popular heroes. However, the lyrics of "La mafia se sienta a la mesa" were slightly different. Instead of glorifying exclusively Mexican “narcos”, this song did “[…] a twentieth-century history seen from the mafia’s point of view” (Ravveduto, 2014), in which “someone” in Sicily did start “everything”: “En un pueblito en Sicilia, un hombre empezó las cosas. Fue el padrino en la familia y fundó la Cosa Nostra. Desde Italia a Nueva York, traficó vino y tabaco. La mafia lo bautizó, fue el primer capo de capos” (In a small town in Sicily, a man started everything. He was the godfather in the family, and founded the Cosa Nostra.