Lina Novara Architettura E Arte a Trapani Ed Erice
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

TRAPANI, SICILY 2014 25Th to 29Th June 2014 Città Di Trapani
TRAPANI, SICILY 2014 th th 25 to 29 June 2014 Città di Trapani Regatta Programme Contact Kathryn Thomson +44 7891 579612 Sarah Goodacre +44 7816 888209 www.frerscup.com [email protected] Content Content Frers Cup 2014, Trapani, Sicily Regatta Programme Introduction 5 Social Programme 6 Mooring 8 Marina 9 Sailing Area 11 Getting to Trapani 12 Accommodation 14 Local Information 17 Isole Egadi & Favignana 19 Sponsors & Partners 20 3 4 Introduction The Frers Cup was born out of the desire to enjoy the high performance characteristics associated with Frers designs in an enjoyable environment that brings out the substance of sail racing, teamwork, skills, intensity and camaraderie. Building Block has been the main driving force behind the organization of the event and Trapani with it unique characteristics both at sea and on land is the chosen place for the first edition. Frers has designed 1,350 successful yachts since 1928, from classics to the cutting edge yachts of the future, designs which vary in age, size and concept and which are sailing the oceans around the globe. For this first edition a selection of special designs were invited and the owners were very enthusiastic about the idea. Some owners will race in this first edition; many are planning to be part of future ones, as are some whose yachts are currently being built. This regatta is a celebration of Frers’ history and future. With the support of all involved in the organization, the town, the owners and their crews this event is shaping up to become something special. Looking forward to see you all in Trapani, German Mani Frers . -

Progetto1 I PICCIOTTI I Picciotti Di Buseto
Antonino Poma I «PICCIOTTI» DI BUSETO La presente pubblicazione è stata curata dalla A.L.A.S.D. JO’ di Buseto Palizzolo Con il contributo del Comune di Buseto Palizzolo In copertina: Giuseppe Sansica - Buseto Palizzolo, La discesa dei Mille, olio su tela 40x60 - Pinacoteca comunale di Buseto Palizzolo Ringraziamenti Mi è gradito ringraziare gli amici che mi hanno aiutato nel lavoro di ricerca d’archivio e di documentazione: Matteo Vasco, Matteo Maiorana, Rosario Salone, Vito Blunda, Baldo Sabella. Mi sento veramente in dovere di rivolgere al prof. Carlo Cataldo un ringraziamento sincero. Tanto più sincero in quanto posso, in coscienza, dichiarare che solo grazie alle sue preziose notizie ho potuto compilare le presenti memorie. A mio padre, uomo di grande rettitudine, idealista e patriota, carabiniere Medaglia d’Onore alla memoria quale internato in lager di sterminio nazista. Possa il suo cuore generoso continuare a battere, nel mondo che ci attende, per l’eternità. «Non ho niente da dire ma lo voglio dire». Marcello Marchesi I «picciotti» di Buseto PRESENTAZIONE L’umile e laboriosa gente della nostra antica borgata, staccatasi dalla millenaria storia ericina, ha pian piano e faticosamente co- struito una propria identità cui siamo oggi orgogliosi di apparte- nere. Il passato, oggi saggiamente studiato e rivisitato, deve poter ali- mentare nelle giovani generazioni propositi di civile progresso in un’Italia saldamente unita, suscitare comuni intenti, intrapren- denza e unità d’impegno. In questo contesto va inserita e rammentata la memoria di que- sti nostri fratelli busetani che, forse inconsciamente, fecero l’Italia nella memorabile battaglia di Calatafimi. Nel clima dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità, l’Asso- ciazione Culturale JÒ intende dare il suo contributo con la pub- blicazione di questo saggio del dr. -

L'odissea a TRAPANI
L’ODISSEA a TRAPANI.1 -1.1Α 1U ^ u . JMk *Λ M A LO. Pocuck ilf e m e dì tìènèbhil Λ lilfe SICILIAN OlUtilN $ m * oi* nifeD bvssfev JviAl&b J w M > * I» h ilM il N!*> i M»> .M Ali/Bl y W 0 y & A4*. bui Aim AMlfcfciiAMirdt.Mft? i é i ^ y e: *AhAM:Ul.tliAAI. ttlMUbfjiUlK)^ '& € κ**Α& Α Ι * * FRANCESCO FRAZZITTA Via Littore Ragusa, 22 90144 PALERMO tei. 61.09.11 -Pref. 091 FRANCESCO PRA22ITTA recapito estivo Ui" Via Torre di Mezzo, 59 91020 MAR AUSA (TP) *· Tel. 84.17.67 - Pref. 0923 ^ ο φ ο PRIMO CONVEGNO INTERNAZIONALE " THE SICILIAN ORIGIN OF THE ODYSSEY » Trapani- 18/19/20/21/22/ LUGLIO 1990. International Festival In Sicily World Odyssey Conference " A Trip Across The Water " U fficio Stampa - Propaganda e Pubbliche Relazioni per la Coop. Antigruppo Siciliano. FRANCESCO FRAZZITTA Via Littore Ragusa, 22 90144 PALERMO Tel. 51.09.11 - Pref. 091 NAT SCAMMACCA, a p p a ssio n a to s tu d io s o d e l le "cose" siciliane (1) quale novello Heinrich Schliemann, in questo afoso LUGLIO 1990, sta vivendo momenti di grande trepidazione. (1) Per Nat Scammacca, trovasi qui inserita amplissima biografia e bibliografia trat= ta dai SΙΚΑΝΟ L'AMERICANO e da BYE BYE AMERICA. /V / Coordinando i lavori del Primo Convegno I n te r n a z io n a le su ORIGINI SICILIANE d e l l · ODISSEA, ( organizzato dal Movimento A rtistico-Ietterario " Antigruppo Siciliano " del quale la moglie Nina Di Giorgio in Scammacca é la Presidente ) cercherà di consolidare tutte le ipotesi fino ad ora avanzate su possibili origini trapanesi dell' Odissea',, Come lo Schliemann andò alla ricerca di TROIA, così Nat Scammacca ( e gli studiosi che egli sostiene attraverso le pagine del settimanale TRAPANI NUOVA di crii é redattore per la Terza Pagina letteraria ) va alla ricerca di ITACA0 I l convegno é indetto da: Coop® Editrice Antigruppo Siciliano Via Argenteria Km04, 91100 TRAPANl/ltaly in collaborazione con: Cross-Cultural Communications, Stanley H0 Barkan, Publisher, 239 Wynsum Avenue,Merrick,' Hew York 11566 U.S.AV con l ’appoggio di: A. -
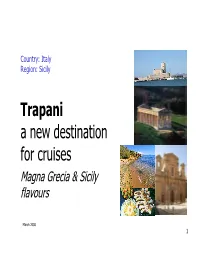
Microsoft Powerpoint
Country: Italy Region: Sicily Trapani a new destination for cruises Magna Grecia & Sicily flavours March 2008 1 Index • The port of Trapani p. 3 – Location p. 3 – Territorial context p. 4 – Infrastructures and port services p. 5 • Trapani as embarkation port p. 7 • Trapani as tourist port: a new destination for cruises p. 7 – 1. Trapani , a town between 2 seas p. 9 – 2. Erice, Punic and Medieval with beautiful view p. 10 – 3. Segesta, the mystery of Elimians p. 11 – 4. Selinunte, once a poweful State p. 12 – 5. Mozia, Phoenician corner in the Stagnone lagoon p. 13 – 6. Marsala, history and wine p. 14 – 7. Mazara del Vallo, the town of “The Satiro” p. 15 – 8. Gibellina and Salemi, art and culture after the earthquake p. 16 – 9. The Nature reserve of “Lo Zingaro” p. 17 – 10. The Nature reserve of “Salt-Pans of Trapani and Paceco” p. 18 – 11. Beaches p. 19 – 12. The Aegades Islands p. 20 – 13. Tuna “factories” p. 22 – 14. The Agrigento Temples Valley p. 23 – 15. Food and wines p. 24 • Province Map p. 26 • References p. 27 2 The port of Trapani: location It is located in the middle of the Mediterranean routes latitude 38° 01' 36" N - longitude 12° 30' 49" E Trapani is a town on the west coast of Sicily, capital of the province of Trapani. His position is baricentric in the Mediterranean sea, thanks to its equidistance from the Suez channel and the Straits of Gibraltar: 665 marine miles from Heraklion 526 marine miles from Barcelona 490 marine miles from Palma de Mallorca 472 marine miles from Marseille 248 marine miles from Civitavecchia 191 -
La Dea Di Erice E La Sua Diffusione Nel Mediterraneo. Un Culto Tra Fenici, Greci E Romani Beatrice Lietz
La dea di Erice e la sua diffusione nel Mediterraneo. Un culto tra Fenici, Greci e Romani Beatrice Lietz To cite this version: Beatrice Lietz. La dea di Erice e la sua diffusione nel Mediterraneo. Un culto tra Fenici, Grecie Romani. Edizioni della Normale, 2012, 978-88-7642-436-6. hal-02137069 HAL Id: hal-02137069 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02137069 Submitted on 22 May 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 8 TESI CLASSE DI LETTERE Beatrice Lietz La dea di Erice e la sua diffusione nel Mediterraneo Un culto tra Fenici, Greci e Romani © 2012 Scuola Normale Superiore Pisa isbn 978-88-7642-436-6 Indice Introduzione xi I. La dea di Erice nella storiografia 1 1. La dea di Erice nella Sicilia antica: tra antiquaria e storiografia 1 1a. Dalla regina Licasta all’Astarte dei Fenici 4 1b. Le origini del culto ericino: un problema di identità 27 2. Astarte Ericina e Cartagine 46 3. L’Afrodite Ericina dei Greci 49 4. La dea ericina a Roma e la leggenda troiana 52 II. Il culto della dea in Sicilia 61 1. -

CUSTONACI La Madonna E La Comunità
SALVATORE CORSO CUSTONACI La Madonna e la Comunità PARTE PRIMA “Riviera di Bonagia” e Custunaci Con la denominazione “Riviera di Bonagia” dal 1682 nelle carte geografiche della Sicilia è indicata quella vasta distesa di terre, fra le più ridenti e intensivamente coltivate, che una serie di documenti almeno dal 1167 aveva accomunato. Custunaci/Custonaci, invece, è all’estrema punta, sotto Monte Cofano, ed è toponimo indicato per la prima volta nel Privilegium datato 1241 ed attribuito falsamente a Federico II imperatore, riguardante concessioni di 14 casali arabi alla città di Monte San Giuliano, documento certamente ratificato nel 1392. Né appaia fuor di luogo insistere sulla flessione dialettale Custunaci, perché l’altra, italianizzata, risulta attestata congiuntamente solo dal 1457, mentre la prima, verosimilmente, appare più adatta a rivelarne la derivazione, flessione documentata in questo e negli altri scritti posteriori. 1 1 Solo Bonagia è toponimo indicato per la prima volta in una carta del 1578: si tratta della pianificazione delle torri litoranee ad opera di Tiburzio Spannocchi: L.DUFOUR-A.LA GUMINA, Imago Siciliae. Cartografia storica della Sicilia 1420-1860, Catania, 1998, p.84; e, con il titolo Monte San Giuliano:Veduta in un acquarello colorato,L.DUFOUR, Atlante storico della Sicilia. Le città costiere nella cartografia manoscritta 1500-1823, Palermo-Siracusa-Venezia, 1992, p.478. Inoltre Bonagia è toponimo che si afferma solo successivamente con la delimitazione di Cofano: cartografie di Giovanni Olives del 1616 e del 1638 in L.DUFOUR-A.LA GUMINA, Imago Siciliae…,cit., pp.104.105; tanto è vero che viene specificata come Bonagia Statione nella sintesi cartografica di Giovanni Antonio Magini nel 1607 e nel 1620 e come Riviera di Bonagia nella carta elaborata, sulle orme del celebre Tommaso Fazello nella sua opera De rebus siculis decades duae, Panormi 1560 con le precisazioni storiche relative, da Giacomo Cantelli de Vignola nel 1682: L.DUFOUR-A.LA GUMINA, Imago Siciliae…,cit., pp.108.109.145. -

Trapani Capitale Della Cultura 2022 Dossier
Città di Trapani Medaglia d’Oro al Valor Civile Trapani, crocevie di popoli e culture, di approdi e policromie. Arte e Cultura, Vento di Rigenerazione Inquadra il QR Code con lo smartphone per visualizzare il video. Città di Trapani Augurandomi che Trapani diventi Capitale Italiana della Cultura 2022, mando un pensiero affettuoso alle mogli dei marinai. Un caro saluto da Dacia Maraini, scrittrice siciliana Ho amato e conosciuto Trapani nel corso degli anni, ma non l’avevo mai vista dal mare. Sull’aliscafo per le Egadi ho finalmente capito cos’è Trapani. L’invictissima Trapani, sull’estrema punta della Sicilia, è sempre accogliente, prende e dà, è una città di scambi e non di conflitti. Se il cibo è cultura, come noi siciliani crediamo, il cous cous trapanese ne è l’estrema espressione. Testimonia l’ancestrale unione tra l’Africa e la Sicilia, due terre vicine e lontane che a Trapani hanno sempre mantenuto il dialogo, il confronto, la convivenza e la condivisione. Dal porto di Trapani, un passo su Levanzo, un altro su Favignana, un salto su Pantelleria, un balzo ancora e siamo in Africa. Mai come adesso è importante che ci sia un dialogo e una vicinanza tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo per l’unione e la rinascita delle loro culture. Trapani è l’unico posto in cui tutto ciò avviene ancora nel segno di una candidatura a Capitale Italiana della Cultura che è bellezza, natura e condivisione. Simonetta Agnello Hornby, scrittrice siciliana 2 3 Trapani Città Candidata a Capitale Italiana della Cultura 2022 Scuole Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri Condividono il Piano Strategico Culturale del Territorio Trapanese 2021 i seguenti enti Ist. -

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO Libero Consorzio Comunale Di Trapani
COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO Libero Consorzio Comunale di Trapani Piano triennale di attività per la valorizzazione di beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di festività di interesse locale per gli anni 2017/2019 (art. 21, commi 5,6 e7 L.R. n. 6 del 7/3/1997) Allegato alla deliberazione consiliare n. 25 del 06.06.2017 Pag. 1 a 14 Il presente piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agro-turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali di festività di interesse locale viene redatto ai sensi dell’art. 21, commi 5, 6 e 7 della L.R. n. 6 del 07/03/1997. La predisposizione e approvazione di tale piano triennale è necessaria al fine di potere utilizzare le eventuali somme che la Regione assegna per le predette finalità. Riteniamo che l’obbligo di cui sopra debba essere dettato non solo dalla necessità di usufruire di eventuali fondi regionali, ma dalla necessità di avviare, da parte delle Amministrazioni, un’attenta e seria programmazione nel settore al fine di consentire uno sviluppo turistico – culturale ed ambientale del proprio paese. Il piano dovrebbe consentire anche la creazione di nuove occasioni di lavoro senza tralasciare il bisogno di arricchimento culturale che è alla base dello sviluppo economico di una collettività. Un piano triennale – così come previsto dalla legge – “scollegato” dai piani dei Comuni limitrofi o di altri Enti del settore, è però destinato a restare solo un piano di spesa e non d’investimento per il futuro. -

Pieghevole Valderice ITA-ING
e è... gio enti tipiche Valderic Paesag Monum Produzioni C entro collinare tra paesaggio. Nella cittadina la Cronoscalata del Monte I l nucleo abitativo prin- cina e il Monte Cofano presenta una costa roccio- I l territorio è caratterizza- panesi. Il suggestivo Santua- ciò che rimane di un’antica N ella zona di Valderice si menti specializzati nella pro- tempo ci si avvaleva di stru- Trapani e Erice, Valderice si svolgono diverse mani- Erice, molto seguita dalla cipale sorge intorno a una sullo sfondo. Il Parco Urba- sa e un pittoresco portic- to dalla presenza di nume- rio di Maria Santissima della cappella a pianta quadrata. incontrano diversi oleifici. duzione di olio. Gli oleifici menti (trappitu e strincituri), offre piacevoli passeggiate festazioni di rilievo: una popolazione. D’obbligo nei piazza-belvedere, da cui è no di Misericordia offre la ciolo; mentre su tutto il rosi bagli, costruzioni rurali Misericordia, edificato tra il Infine presso la Tonnara di Tra ottobre e dicembre, le di oggi sono ormai dotati di attivati con lavoro umano e da compiere tra il verde rassegna cinematografica dintorni una breve visita possibile ammirare uno possibilità di percorrere litorale domina la sagoma con diversi corpi affacciati XVII e il XVIII secolo, fu Bonagia e il complesso Torre olive, una delle principali moderni macchinari auto- animale. L’antico e prestigio- delle pinete e i bagli anti- e musicale estiva nel sug- al Museo dell’antica Ton- splendido panorama sulla sentieri panoramici im- del Monte Cofano, proiet- su un cortile interno, e da completato dall’architetto Xiare, oggi frequentati alber- coltivazioni della zona, sono matizzati per la spremitura so mulino Excelsior diverrà chi che ne punteggiano il gestivo teatro all’aperto, nara di Bonagia. -

Piano Comunale Di Protezione Civile
Comune di Trapani PIANO COMUNALE di PROTEZIONE CIVILE Edizione marzo 2005 COMUNE DI TRAPANI Piano Comunale di Protezione Civile SOMMARIO A) PARTE GENERALE A1 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E LINEE GUIDA A2 - IL TERRITORIO COMUNALE A2.a) CONFINI TERRITORIALI A2.b) ESTENSIONE TERRITORIALE A2.c) COORDINATE GEOGRAFICHE (Municipio – Palazzo D ’Al ì) A2.d) ALTITUDINE A2.e) POPOLAZIONE RESIDENTE AL 2001 (G.U. n. 81 del 07/04/2003) A2.f) PATRIMONIO EDILIZIO A2.g) EDIFICI STRATEGICI A2.h) EDIFICI TATTICI A2.i) EDIFICI SENSIBILI A2.l) SERVIZI A RETE A2.m) INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO A2.n) ELISUPERFICI DI EMERGENZA A2.o) AUTOLINEE DI COLLEGAMENTO ESTERNO A2.p) AEROPORTI A2.q) PORTO A2.r) AUTOSTRADE A2.s) FF.S. TRENITALIA S.p.A. A2.t) AREE DI AMMASSAMENTO DEI SOCCORRITORI A2.u) AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE A2.v) AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE A2.w) RISORSE DELL ’AMMINISTRAZIONE A2.z) CARTOGRAFIA A3 - SCENARI DEGLI EVENTI ATTESI A3.1 - RISCHIO SISMICO A3.2 - RISCHIO TSUNAMI A3.3 - RISCHIO IDROGEOLOGICO A3.4 - RISCHIO INDUSTRIALE A3.5 - RISCHIO TRASPORTO MERCI PERICOLOSE A3.6 - RISCHIO INCENDI B ) LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE B1 - SINDACO B2 - COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE B3 - UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE B4 - NUCLEI OPERATIVI DI PROTEZIONE CIVILE B5 - CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C ) B6 - SALA OPERATIVA: Funzioni di Supporto B7 - SEGRETERIA E GESTIONE DATI B8 - UFFICIO STAMPA C ) MODELLO DI INTERVENTO C1 – GENERALITA ’ C2 - FASE DI ATTENZIONE C3 - FASE DI PRE -ALLARME C4 - FASE DI ALLARME C5 - FASE DI EMERGENZA D) PIANI DI EMERGENZA PER RISCHI SPECIFICI D1) RISCHIO SISMICO D1.1 – GENERALITA ’ D1.1.a – Scenario di evento D1.1.b – Scenario di rischio D1.2 - LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE D1.2.a. -

M-601 Sentiero Di Sant'anna
M-601 Sentiero Italia Sentiero di Sant’Anna ERICE Lunghezza 5,5 Km Dislivello salita 661 m Difficoltà E - Itinerario escursionistico Durata complessiva 2 h 20 min Città di Erice Comune Città di Pace e di Buseto Partenza Stazione Ovovia (43 m) per la Scienza Palizzolo Quota massima 704 m (Porta Trapani) Itinerario Stazione Ovovia - Area attrezzata di Martogna - Santuario di Sant’Anna - Casa Demanio Foreste - Porta Trapani Il sentiero è percorribile anche in MTB Comune di Comune Note Cast.mare di Custonaci del Golfo Breve itinerario in linea che parte dalla stazione dell’ovovia (43 m) e raggiunge Porta Trapani ad Erice centro storico. Il sentiero sale lungo il versante occidentale di Monte Erice (già San Giuliano) e prevede un primo tratto lungo la via Capua, via Manzoni e via Pola Sant’Anna per raggiungere l’ingresso all’area Comune di attrezzata di Martogna (250 m), che si lascerà per proseguire in un secondo tratto verso Pizzo Argenteria San Vito Comune Lo Capo di Valderice e raggiungere il secentesco Santuario di Sant’Anna (332 m), da dove è possibile godere di una vista panoramica sulla città di Trapani e sulle Isole Egadi, tra il Mar Tirreno e il Mar Mediterraneo. Dal Santuario di Sant’Anna si prosegue lungo il sentiero fino a raggiungere la Casa Demanio Foreste (475 m). Segue Azienda Foreste l’ultimo tratto, attraverso un boschetto, in direzione di Porta Trapani (704 m), dove sarà possibile continuare Demaniali la visita dell’antico borgo medievale. Regione Siciliana Club Alpino Italiano GR Sicilia / Sottosezione Castellammare del -

Provincia Di Trapani
XIII Campionato Italiano di Ciclismo FORZE DI POLIZIA Trapani 20 Giugno 2004 PROVINCIA DI TRAPANI Dove il cielo si tinge di forti colori che, specie al tramonto, stordiscono col vigore del rosso, del turchino e dell’oro; dove il vento, che porta caldi efflussi d’Africa e fini sabbie dei deserti, sagoma a suo piacimento morbide dune, umili alture d’azzurre argille e dorate arenarie; dove, a sfidare scirocco e arsura, dominano incontrastati grandi cespi d’euphorbie, argentei oleastri, umili palmette, ginestre spinose e lentischi; dove, solitarie e possenti, s’innalzano aspre masse calcaree ora strapiombanti sul mare, ora su pianori sassosi, ora su terre ondulate; dove, il mare, che ancora riecheggia dei clamori di epiche battaglie, lambisce distese di sabbie infuocate o infuria su basse scogliere: lì è l’occidente siciliano, il lembo più “africano” dell’Isola e nel contempo il più “siciliano” degli ambienti di Sicilia. In questi reami di luci e di venti ogni pietra, ogni pianta, ogni fiore nasce e muore per questi e di questi; ogni cosa “è” in quanto da quelle luci, da quei venti, da quelle acque progettata, lambita, lusingata, glorificata, divinizzata. Che ne sarebbe delle bionde spiagge del Belice, delle selvatiche pietre dello Zingaro, della magica laguna dello Stagnone, dei riverberanti specchi delle saline, delle rupi sanguigne di Scurati, dei dolomitici baratri di Marittimo, delle nebbie di Erice, delle sublimi architetture di Segesta e Selinunte, senza quei venti sferzanti, senza quei tramonti africani, senza luce accecanti, i cieli inquieti e il mare impazzito di spume che ogni cosa, lì ad occidente, avvampano di vita: povere, povere cose sarebbero, se mai potessero esistere.