Genesi Di Un Paese: Valderice
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Stazionamenti Feriale Feriale Feriale Feriale Estiva Feriale Feriale Feriale Feriale Scolastica Scolastica Estiva Estiva Scolastica Scolastica Estiva
Allegato "C" Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrsatrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 1 "Autotrasporto Persone" Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi Extraurbani di T.P.L. in autobus già in concessione regionale Impresa: Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T. S.p.A. Codice 64 Orario Autolinea Extraurbana CASTELLAMMARE DEL GOLFO - VALDERICE - TRAPANI - con deviazione A 29-Trapani e Buseto - s.p. 52 - Trapani (cod. 732) C O R S E C O R S E 1A 2A 3A 4A 5A 6A 1R 2R 3R 4R 5R 6R KM KM KM FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE STAZIONAMENTI FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE ESTIVA FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE SCOLASTICA SCOLASTICA ESTIVA ESTIVA SCOLASTICA SCOLASTICA ESTIVA Capolinea 6.30 6.40 6.50 6.50 12.30 16.30 0,0 0,0 CASTELLAMARE DEL GOLFO - via della Repubblica 52,1 14.55 15.40 15.45 15.20 15.45 19.25 Fermata intermedia 6.50 7.00 | 7.05 12.50 16.50 10,0 10,0 BALATA DI BAIDA - via Laudani | 14.25 15.15 15.20 | 15.20 18.55 Fermata intermedia 6.55 7.05 | 7.10 13.00 16.55 16,0 16,0 BATTAGLIA - via Battaglia | 14.20 | 15.15 | 15.15 18.50 Fermata intermedia 7.00 7.10 | | | | BUSETO PALIZZOLO – via P. Randazzo | 14.15 15.00 | | | 18.45 Fermata intermedia | 7.40 | 7.30 | 17.05 24,0 | CROCEVIE - via Rinascita A 29 | | 14.55 A 29 14.55 | Fermata intermedia | 7.45 via 7.35 | 17.15 28,0 | VALDERICE - via Vespri via | | 14.45 via 14.45 | Fermata intermedia 7.10 | A 29 | 13.10 | | 21,0 BUSETO - via Roma | | | | | | | Fermata intermedia 7.25 | | | 13.25 | | 27,0 CHIESANUOVA - via Oberdan | 14.05 14.50 | | | 18.30 Fermata intermedia 7.30 | | | 13.30 | | 30,0 CROCCI - via Crocci | 14.00 14.40 | | | 18.25 Capolinea 7.50 8.20 8.00 8.10 13.50 17.50 40,1 40,1 TRAPANI – Terminal piazzale Ilio 0,0 13.30 14.15 14.15 14.15 14.15 18.00 Prescrizioni d'Esercizio nessuna Allegato "C" Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 1 "Autotrasporto Persone" Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi Extraurbani di T.P.L. -

IL CULTO DI MARIA SS. DI CUSTONACI a VALDERICE Di Maria Anna Milana
IL CULTO DI MARIA SS. DI CUSTONACI A VALDERICE di Maria Anna Milana Il culto di Maria SS. ma di Custonaci, ampiamente illustrato da Vincenzo Vassallo nel libro che avrete dopo tra le mani, si è esteso a macchia d’olio non solo nel territorio dell’antico Agro ericino, ma oltre, come testimonia il Castronovo nel suo libro Le glorie di Maria SS.ma Immacolata sotto il titolo di Custonaci, dove l’autore fa un lungo e dettagliato elenco delle località in cui la Madonna di Custonaci è stata venerata. Vengono citate i centri di Trapani, Marsala, S. Vito Lo Capo, Mazara, Castelvetrano, Agrigento, Palermo e – aggiunge Vincenzo Vassallo –, anche in Francia, in Spagna, in Tunisia e nelle Americhe se n’era diffuso il culto “ovunque si trovasse un ericino”. A tal proposito è interessante ricordare che anche a Roma, nella chiesa di S. Giuseppe al Trionfale, l’ericino Francesco Cascio aveva promosso iniziative per venerare la Madonna di Custonaci sotto il titolo di Madonna della Provvidenza. Ne parla Salvatore Giurlanda nel suo libro Maria SS. ma di Custonaci: il culto ieri e oggi e Vincenzo Vassallo riporta un’ampia documentazione su questa iniziativa e sugli sviluppi che essa poi ebbe nel tempo. Da nostre ricerche effettuate a Roma nella chiesa di S. Giuseppe al Trionfale non esiste attualmente traccia del culto alla Madonna della Provvidenza. Tra gli abitanti dell’antico Agro ericino il culto della Vergine di Custonaci si presume sia stato presente sin dal XV secolo, ancor prima che iniziassero i trasporti. Nelle chiese dei paesi che adesso formano l’Unione dei Comuni Elimo Ericini si trovavano – e in qualche caso si trovano ancora – i quadri che riproducono l’antica sacra immagine. -

TRAPANI, SICILY 2014 25Th to 29Th June 2014 Città Di Trapani
TRAPANI, SICILY 2014 th th 25 to 29 June 2014 Città di Trapani Regatta Programme Contact Kathryn Thomson +44 7891 579612 Sarah Goodacre +44 7816 888209 www.frerscup.com [email protected] Content Content Frers Cup 2014, Trapani, Sicily Regatta Programme Introduction 5 Social Programme 6 Mooring 8 Marina 9 Sailing Area 11 Getting to Trapani 12 Accommodation 14 Local Information 17 Isole Egadi & Favignana 19 Sponsors & Partners 20 3 4 Introduction The Frers Cup was born out of the desire to enjoy the high performance characteristics associated with Frers designs in an enjoyable environment that brings out the substance of sail racing, teamwork, skills, intensity and camaraderie. Building Block has been the main driving force behind the organization of the event and Trapani with it unique characteristics both at sea and on land is the chosen place for the first edition. Frers has designed 1,350 successful yachts since 1928, from classics to the cutting edge yachts of the future, designs which vary in age, size and concept and which are sailing the oceans around the globe. For this first edition a selection of special designs were invited and the owners were very enthusiastic about the idea. Some owners will race in this first edition; many are planning to be part of future ones, as are some whose yachts are currently being built. This regatta is a celebration of Frers’ history and future. With the support of all involved in the organization, the town, the owners and their crews this event is shaping up to become something special. Looking forward to see you all in Trapani, German Mani Frers . -

Norme Di Attuazione
PIANO PAESAGGISTICO AMBITO 1 “AREA DEI RILIEVI DEL TRAPANESE” NORME DI ATTUAZIONE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità e campo di applicazione del Piano Il Piano Territoriale Paesaggistico dell’Ambito 1 - Area dei rilievi del trapanese – interessa il territorio dei comuni di Castellammare del Golfo, Custonaci, Buseto Palizzolo, Valderice, San Vito Lo Capo e parte del territorio del comune di Erice. Il Piano Territoriale Paesaggistico dell’Ambito 1 è redatto in adempimento alle disposizioni delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, e con riferimento alla Convenzione europea del Paesaggio e al quadro legislativo nazionale e regionale, in particolare a quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 1 agosto 1977, n. 80, dall’ art. 143 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, così come integrato e modificato dai DD.lgs n. 157 del 24 marzo 2006 e n. 63 del 26 marzo 2008 e in seguito denominato Codice, e dall’Atto di Indirizzo dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n° 5820 del 08/05/2002. Il Piano Territoriale Paesaggistico dell’Ambito 1 persegue le seguenti finalità generali: la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, la difesa del suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità; la valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio dell’Ambito, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni; il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni. -
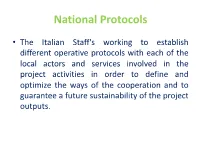
Saarbruchen Presentation
National Protocols • The Italian Staff's working to establish different operative protocols with each of the local actors and services involved in the project activities in order to define and optimize the ways of the cooperation and to guarantee a future sustainability of the project outputs. Protocols Objectives 1. To make new cooperative conditions for defining and planning the multicultural support system for migrant women, victims of S/GBV and future activities and services to support them. 2. To create new networking among institutions and social actors operating in the field of the gender based violence 3. To involve local actors in the establishment of the operative protocol to help migrants women had violence experiences 4. To rule the EcA’s placements in the local services Why were protocols necessary? • To work with Public Services it’s needed an official agreement that specify terms and conditions of the collaboration ( timework, action and types of activities, voluntary or waged work, finance charge, etc ). • To discern the responsibilities of each members of the partnership . • To assure and make official work of each operators, EcA’s and workers involved in the activities project. Protocols already undersigned • Municipality of Valderice • No profit associations and cooperatives: – Esercito della salvezza (The Salvation Army)–Castelvetrano working in the field of ANTI-TRAFFICKING – La Mimosa – Safe House for Women - Mazara del Vallo – Coesi – Reception center for migrants (women and families ) Valderice • Women’s Aid centers: – Casa di venere (Non-Violence against women Centre ) - Marsala – Demetra (anti-violence against women desk - VAW desk) - Mazara Del Vallo Protocols to be signed • Municipality of Castelvetrano – • Municipality of Mazara del Vallo – • Municipality of Marsala – • SFERA Association working in the fields of guidance, counseling and mediation for migrants. -

TRAPANI ORARIO Ln VIGORE Dal 70 - I - 2021 Partenae DALL'aeroporto BIRGI Per
ffie AZIEN DA SICI LIANA TRASPORTI SEDE DI TRAPANI ORARIO lN VIGORE dal 70 - I - 2021 PARTENaE DALL'AEROPORTO BIRGI pER: ORARI FERIALI . WEEKDAY I 5.50 6.30 7.15 8.40 9.00 LUNEDI LU-VE-SA 11.30 12.00 1234 13.00 13.30 TRAPANI VENERDI LU-SA VENERDI SABATO LUNEDI 16.00 17.30 ( PACECO ) 13.50 14.50 18.40 LU-VE VENERDI 20,45 21 .15 22,0A MA-SA LUNEDI LU-VE MARSALA 7.25 12.40 13.30 14.55 MAZARA DEL VALLO 7.25 13.30 14.55 CASTELVETRANO - CAMPOBELLO 7.25 13.30 SALAPARUTA _ POGGIOREALE 13.30 I PARTANNA - SANTA NINFA 13.30 I ORARI FESTIVI . HOLIDAY.HOURS TRAPANI 8.45 12,30 17.40 18.40 22.00 Paceco AEROPORTO BIRGI - TRAPANI EURo 4.90 TICKET: AEROPORTO BIRGI - TVIARSALA EURo 2 70 AEROPORTO BIRGI - MAZARA DEL VALLO EURo 4.1 N.B.: IL 25 DICEMBRE NON VIENE EFFETTUATO NESSUN SERVIZIO / NO SERVICE IS PROVIDED ON DECEMBER 25 TH A.S.T. - Trapani - Direzione tel.0923.21021 informazioni A.S.T. - Trapani - Direzione - Via Virgilio 20 - fax 0923.872939 www.astsicilia.it N.B.: L'Azienda si riserva con altre pubblicazioni di modificare il presente orario. N.B.: Munirsi di biglietto o di monete prima disalire a bordo. PIease Note: Please to be provided with tickets or small coin before boarding. N. B.: LE FERMATE SONO A RICHIESTA. -..% *,effi* SEDE DI TRAPANI ORARIO FERIALE INVERNALE lN VIGORE dal 11 -1 -2021 PARTENZE DA TRAPANI PER 5.00 5.45 10.00 11.30 14.45 15.30 6.35 7.15 12.00 12.50 14.15 17.00 LUNEDI LU-VE-SA LU-VE-SI LU-VE-SÀ II-VF VENERDI AEROPORTO BIRGI 19.15 21.0U LU-VE ACQUESORBE 6.35 c 13.45 v ALATA DI BAIDA 13.30 c 14.15 c 18.00 c ALLATA 12.30 c 14.15 -

Progetto1 I PICCIOTTI I Picciotti Di Buseto
Antonino Poma I «PICCIOTTI» DI BUSETO La presente pubblicazione è stata curata dalla A.L.A.S.D. JO’ di Buseto Palizzolo Con il contributo del Comune di Buseto Palizzolo In copertina: Giuseppe Sansica - Buseto Palizzolo, La discesa dei Mille, olio su tela 40x60 - Pinacoteca comunale di Buseto Palizzolo Ringraziamenti Mi è gradito ringraziare gli amici che mi hanno aiutato nel lavoro di ricerca d’archivio e di documentazione: Matteo Vasco, Matteo Maiorana, Rosario Salone, Vito Blunda, Baldo Sabella. Mi sento veramente in dovere di rivolgere al prof. Carlo Cataldo un ringraziamento sincero. Tanto più sincero in quanto posso, in coscienza, dichiarare che solo grazie alle sue preziose notizie ho potuto compilare le presenti memorie. A mio padre, uomo di grande rettitudine, idealista e patriota, carabiniere Medaglia d’Onore alla memoria quale internato in lager di sterminio nazista. Possa il suo cuore generoso continuare a battere, nel mondo che ci attende, per l’eternità. «Non ho niente da dire ma lo voglio dire». Marcello Marchesi I «picciotti» di Buseto PRESENTAZIONE L’umile e laboriosa gente della nostra antica borgata, staccatasi dalla millenaria storia ericina, ha pian piano e faticosamente co- struito una propria identità cui siamo oggi orgogliosi di apparte- nere. Il passato, oggi saggiamente studiato e rivisitato, deve poter ali- mentare nelle giovani generazioni propositi di civile progresso in un’Italia saldamente unita, suscitare comuni intenti, intrapren- denza e unità d’impegno. In questo contesto va inserita e rammentata la memoria di que- sti nostri fratelli busetani che, forse inconsciamente, fecero l’Italia nella memorabile battaglia di Calatafimi. Nel clima dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità, l’Asso- ciazione Culturale JÒ intende dare il suo contributo con la pub- blicazione di questo saggio del dr. -

Elencommgdistrettotrapani 78
ELENCO MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL DISTRETTO Orari Apertura Ambulatorio Codice Reg. Ambito Territoriale Nome Medico Indirizzo Ambulatorio Cellulare LUN MAR MER GIO VEN SAB E-mail 911257 Trapani-Erice ACCARDO TIZIANA Via Enrico Petrella n. 10 Trapani 3495368754 16:00-18:00 9:00-11:00 16:00-18:00 9:00-11:00 9:00-11:00 [email protected] 911234 Trapani-Erice ADRAGNA ANGELA Via Manzoni n. 162/B Erice 3386178048 09:00-12:00 16:00-19:00 09:00-12:00 16:00-19:00 09:00-12:00 8:30-10:00 [email protected] Via G. Marconi, 17 - C.S. Erice - 08:00-09:30 (Trapani), Corso Vittorio Emanuele, 164 (Trapani) 10:30- 15:30-18:00 11:30-13:00 (Trapani) su 910689 Trapani-Erice ALBERTINI ALBERTO Trapani 3288772431 13:00 (Erice) 15:30-18:30 (Erice) (Trapani) 15:30-18:30 (Erice) 08:00-10:30 (Erice) appuntamen [email protected] Via Rocco Solina n. 16 Trapani; 15,30-18,30 8,30-12,00 15,30-18,30 Via Marsala - Rilievo n.332 (Trapani); 9,00-10,30 (Trapani); 15,30- 15,30-18,30 (Trapani); 9,00- 912534 Trapani-Erice ALEO NICOLA Trapani 3297220690 (Rilievo) 17,00(Rilievo) (Trapani); 10,30 (Rilievo) 8,30-12,00 (Trapani) [email protected] 9,00-13,00 (Trapani) 8,00-9,00 (Guarrato) 8,00-9,00 10,00-13,00 (Trapani) AMATO SALVATORE Via A. Esposito n.23 Trapani - Trapani-Erice 3387577311 15,00-16,00 15,30-18,30 9,00-13,00 (Trapani) (Guarrato) 15,30- Via Marsala n.140 Guarrato 908699 NATALE (Guarrato) (Trapani) 18,30 (Trapani) [email protected] 907970 Trapani-Erice AMICO PAOLA ASSUNTA Via Marconi, 17 , C.S. -

Lina Novara Architettura E Arte a Trapani Ed Erice
Lina Novara Architettura e Arte a Trapani ed Erice Cenni Storici sul territorio LA PREISTORIA Nella Sicilia Occidentale le prime testimonianze della presenza dell’uomo risalgono alla fine del Paleolitico Superiore (circa 10.000 a.C.) e documentano l’esistenza di insediamenti in prossimità di numerose caverne e cavità rocciose, rifugio di piccole comunità di cac - ciatori. Le tracce più significative di queste presenze si trovano nella grotta dell’Addaura, vicino Palermo e nella grotta del Genovese, nell’isola di Levanzo. Levanzo - Grotta del genovese. Le pareti della cavità più interna della grotta sono incise da graffiti del paleoliti- co, rappresentanti cervi, buoi, piccoli equidi e tre figure antropomorfe (circa 10.000 a.C.). Nella stessa grotta è presente anche un ciclo di pitture in nero risalente alla fine del Neolitico (4000-3000 a.C.), periodo in cui l’uomo ha già sviluppato tecniche agricole e di allevamento abbastanza avanzate. Le figure antropomorfe stilizzate sono testimoni, probabilmente, di un rito religioso arcaico legato al culto della Dea Madre Generatrice che si riscontra anche in altri siti coevi del Mediterraneo. Molti sono gli animali dipinti, fra cui, è da notare la prima rappresenta- zione rupestre europea di pesci (delfini e tonni). GLI ELIMI Fra l’età del bronzo e l’età del ferro la Sicilia, oltre che da Sicani e Siculi, fu abitata dagli Elimi nella parte nord-occidentale, e vide fiorire Erice (il centro religioso), Segesta (il centro politico), Entella, Salemi. Diverse sono le teorie sull’origine di questo popolo: l’ipo - tesi più accreditata è quella di Tucidide che sostiene la discendenza troiana degli Elimi. -

Collezione Celani
Ministero per i Beni e le AttivitàCulturali e per il Turismo Archivio di Stato di Trapani COLLEZIONE CELANI Arianna Di Miceli, Valentina Rallo Fotografia: G. Macaluso Intervento conservativo a cura di Fulvia Bartolone (2019) Trapani – 2017 http://archiviodistatotrapani.beniculturali.it/index.php?it/223/collezione-celani SOMMARIO Nota introduttiva pag. 1 Nota tecnico-conservativa pag. 5 Schede pag. 11 Indice delle carte pag. 98 Indice dei nomi di persone e famiglie pag. 107 Indice dei nomi di enti pag. 118 Indice dei toponimi pag. 120 Bibliografia pag. 143 Catalogo delle immagini su: http://www.archiviodistatotrapani.beniculturali.it/index.php?it/223/collezione-celani http://archiviodistatotrapani.beniculturali.it/index.php?it/223/collezione-celani NOTA INTRODUTTIVA La collezione è costituita complessivamente da 86 unità cartografiche prodotte tra il 1811 e il 1898 e riguardanti diversi comuni della provincia di Trapani. Le carte sono pervenute in possesso dell’Archivio di Stato in due distinti momenti a seguito di alienazione effettuata dalla precedente proprietaria, sig.ra Celani, da cui la raccolta prende il nome. Il primo nucleo, costituito da 67 carte, è stato acquistato dalla Soprintendenza Archivistica di Palermo e consegnato all’Archivio di Stato di Trapani nel 2005, il secondo, con le rimanenti 19 unità, nel 2009. Nonostante, nel suo complesso, la collezione si presenti caratterizzata da una grande varietà nella tipologia, nelle dimensioni, nell’oggetto delle rappresentazioni, nelle datazioni, è stato possibile individuare un elemento comune a tutte le carte nella loro specifica natura di “strumenti funzionali a specifiche pratiche” 1. Per tutte si è tentato di risalire al contesto di provenienza attraverso l’esame di elementi significativi sul recto o sul verso (sottoscrizioni, riferimenti a pubbliche autorità committenti, timbri, visti, etc.) e, in alcuni casi, per mezzo di analogie con altre cartografie conservate in Istituto. -

L'odissea a TRAPANI
L’ODISSEA a TRAPANI.1 -1.1Α 1U ^ u . JMk *Λ M A LO. Pocuck ilf e m e dì tìènèbhil Λ lilfe SICILIAN OlUtilN $ m * oi* nifeD bvssfev JviAl&b J w M > * I» h ilM il N!*> i M»> .M Ali/Bl y W 0 y & A4*. bui Aim AMlfcfciiAMirdt.Mft? i é i ^ y e: *AhAM:Ul.tliAAI. ttlMUbfjiUlK)^ '& € κ**Α& Α Ι * * FRANCESCO FRAZZITTA Via Littore Ragusa, 22 90144 PALERMO tei. 61.09.11 -Pref. 091 FRANCESCO PRA22ITTA recapito estivo Ui" Via Torre di Mezzo, 59 91020 MAR AUSA (TP) *· Tel. 84.17.67 - Pref. 0923 ^ ο φ ο PRIMO CONVEGNO INTERNAZIONALE " THE SICILIAN ORIGIN OF THE ODYSSEY » Trapani- 18/19/20/21/22/ LUGLIO 1990. International Festival In Sicily World Odyssey Conference " A Trip Across The Water " U fficio Stampa - Propaganda e Pubbliche Relazioni per la Coop. Antigruppo Siciliano. FRANCESCO FRAZZITTA Via Littore Ragusa, 22 90144 PALERMO Tel. 51.09.11 - Pref. 091 NAT SCAMMACCA, a p p a ssio n a to s tu d io s o d e l le "cose" siciliane (1) quale novello Heinrich Schliemann, in questo afoso LUGLIO 1990, sta vivendo momenti di grande trepidazione. (1) Per Nat Scammacca, trovasi qui inserita amplissima biografia e bibliografia trat= ta dai SΙΚΑΝΟ L'AMERICANO e da BYE BYE AMERICA. /V / Coordinando i lavori del Primo Convegno I n te r n a z io n a le su ORIGINI SICILIANE d e l l · ODISSEA, ( organizzato dal Movimento A rtistico-Ietterario " Antigruppo Siciliano " del quale la moglie Nina Di Giorgio in Scammacca é la Presidente ) cercherà di consolidare tutte le ipotesi fino ad ora avanzate su possibili origini trapanesi dell' Odissea',, Come lo Schliemann andò alla ricerca di TROIA, così Nat Scammacca ( e gli studiosi che egli sostiene attraverso le pagine del settimanale TRAPANI NUOVA di crii é redattore per la Terza Pagina letteraria ) va alla ricerca di ITACA0 I l convegno é indetto da: Coop® Editrice Antigruppo Siciliano Via Argenteria Km04, 91100 TRAPANl/ltaly in collaborazione con: Cross-Cultural Communications, Stanley H0 Barkan, Publisher, 239 Wynsum Avenue,Merrick,' Hew York 11566 U.S.AV con l ’appoggio di: A. -
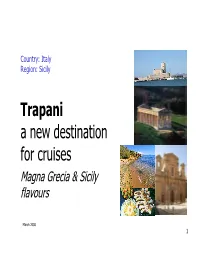
Microsoft Powerpoint
Country: Italy Region: Sicily Trapani a new destination for cruises Magna Grecia & Sicily flavours March 2008 1 Index • The port of Trapani p. 3 – Location p. 3 – Territorial context p. 4 – Infrastructures and port services p. 5 • Trapani as embarkation port p. 7 • Trapani as tourist port: a new destination for cruises p. 7 – 1. Trapani , a town between 2 seas p. 9 – 2. Erice, Punic and Medieval with beautiful view p. 10 – 3. Segesta, the mystery of Elimians p. 11 – 4. Selinunte, once a poweful State p. 12 – 5. Mozia, Phoenician corner in the Stagnone lagoon p. 13 – 6. Marsala, history and wine p. 14 – 7. Mazara del Vallo, the town of “The Satiro” p. 15 – 8. Gibellina and Salemi, art and culture after the earthquake p. 16 – 9. The Nature reserve of “Lo Zingaro” p. 17 – 10. The Nature reserve of “Salt-Pans of Trapani and Paceco” p. 18 – 11. Beaches p. 19 – 12. The Aegades Islands p. 20 – 13. Tuna “factories” p. 22 – 14. The Agrigento Temples Valley p. 23 – 15. Food and wines p. 24 • Province Map p. 26 • References p. 27 2 The port of Trapani: location It is located in the middle of the Mediterranean routes latitude 38° 01' 36" N - longitude 12° 30' 49" E Trapani is a town on the west coast of Sicily, capital of the province of Trapani. His position is baricentric in the Mediterranean sea, thanks to its equidistance from the Suez channel and the Straits of Gibraltar: 665 marine miles from Heraklion 526 marine miles from Barcelona 490 marine miles from Palma de Mallorca 472 marine miles from Marseille 248 marine miles from Civitavecchia 191