Norme Di Attuazione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dall'1 Luglio Al 13 Settembre 2020 Modifiche Circolazione
DALL’1 LUGLIO AL 13 SETTEMBRE 2020 LINEA: PIRAINETO - TRAPANI MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI Da mercoledì 1 luglio a domenica 13 settembre 2020 per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Alcamo Diramazione e Salemi, i seguenti treni subiscono le variazioni indicate nelle tabelle. Da Trapani per Castelvetrano Treno Partenza Ora Arrivo Ora Provvedimenti CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA202 nei giorni lavorativi. Il bus anticipa di 40’ l’orario di partenza da Trapani. R 26622 TRAPANI 05:46 CASTELVETRANO 07:18 Orario del bus: Trapani (p. 05:06), Paceco (p. 05.16), Marausa (p. 05:29) Mozia-Birgi (p. 05.36), Spagnuola (p.05:45), Marsala (p.05:59), Terrenove (p.06.11), Petrosino-Strasatti (p.06:19), Mazara del Vallo (p.06:40), Campobello di Mazara (p.07:01), Castelvetrano (a.07:18). CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA218 nei giorni lavorativi. R 26640 TRAPANI 16:04 CASTELVETRANO 17:24 Orario del bus: Trapani (p. 16:04), Mozia-Birgi (p. 16:34), Marsala (p. 16:57), Petrosino-Strasatti (p. 17:17), Mazara del Vallo (p. 17:38), Campobello di Mazara (p. 17:59), Castelvetrano (a. 18:16). CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA220 nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì. Non circola venerdì 14 agosto 2020. R 26642 TRAPANI 17:30 CASTELVETRANO 18:53 Orario del bus: Trapani (p. 17:30), Marausa (p. 17:53), Mozia-Birgi (p. 18:00), Spagnuola (p. 18:09), Marsala (p. 18:23), Petrosino-Strasatti (p. 18:43), Mazara del Vallo (p. 19:04), Campobello di Mazara (p. 19:25), Castelvetrano (a. 19:42). -

Stazionamenti Feriale Feriale Feriale Feriale Estiva Feriale Feriale Feriale Feriale Scolastica Scolastica Estiva Estiva Scolastica Scolastica Estiva
Allegato "C" Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrsatrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 1 "Autotrasporto Persone" Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi Extraurbani di T.P.L. in autobus già in concessione regionale Impresa: Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T. S.p.A. Codice 64 Orario Autolinea Extraurbana CASTELLAMMARE DEL GOLFO - VALDERICE - TRAPANI - con deviazione A 29-Trapani e Buseto - s.p. 52 - Trapani (cod. 732) C O R S E C O R S E 1A 2A 3A 4A 5A 6A 1R 2R 3R 4R 5R 6R KM KM KM FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE STAZIONAMENTI FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE ESTIVA FERIALE FERIALE FERIALE FERIALE SCOLASTICA SCOLASTICA ESTIVA ESTIVA SCOLASTICA SCOLASTICA ESTIVA Capolinea 6.30 6.40 6.50 6.50 12.30 16.30 0,0 0,0 CASTELLAMARE DEL GOLFO - via della Repubblica 52,1 14.55 15.40 15.45 15.20 15.45 19.25 Fermata intermedia 6.50 7.00 | 7.05 12.50 16.50 10,0 10,0 BALATA DI BAIDA - via Laudani | 14.25 15.15 15.20 | 15.20 18.55 Fermata intermedia 6.55 7.05 | 7.10 13.00 16.55 16,0 16,0 BATTAGLIA - via Battaglia | 14.20 | 15.15 | 15.15 18.50 Fermata intermedia 7.00 7.10 | | | | BUSETO PALIZZOLO – via P. Randazzo | 14.15 15.00 | | | 18.45 Fermata intermedia | 7.40 | 7.30 | 17.05 24,0 | CROCEVIE - via Rinascita A 29 | | 14.55 A 29 14.55 | Fermata intermedia | 7.45 via 7.35 | 17.15 28,0 | VALDERICE - via Vespri via | | 14.45 via 14.45 | Fermata intermedia 7.10 | A 29 | 13.10 | | 21,0 BUSETO - via Roma | | | | | | | Fermata intermedia 7.25 | | | 13.25 | | 27,0 CHIESANUOVA - via Oberdan | 14.05 14.50 | | | 18.30 Fermata intermedia 7.30 | | | 13.30 | | 30,0 CROCCI - via Crocci | 14.00 14.40 | | | 18.25 Capolinea 7.50 8.20 8.00 8.10 13.50 17.50 40,1 40,1 TRAPANI – Terminal piazzale Ilio 0,0 13.30 14.15 14.15 14.15 14.15 18.00 Prescrizioni d'Esercizio nessuna Allegato "C" Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 1 "Autotrasporto Persone" Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi Extraurbani di T.P.L. -

Presentazione Standard Di Powerpoint
DALL’1 LUGLIO AL 13 SETTEMBRE 2020 LINEA: PIRAINETO - TRAPANI MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI Da mercoledì 1 luglio a domenica 13 settembre 2020 per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Alcamo Diramazione e Salemi, i seguenti treni subiscono le variazioni indicate nelle tabelle. Da Trapani per Castelvetrano Treno Partenza Ora Arrivo Ora Provvedimenti CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA202 nei giorni lavorativi. Il bus anticipa di 40’ l’orario di partenza da Trapani. R 26622 TRAPANI 05:46 CASTELVETRANO 07:18 Orario del bus: Trapani (p. 05:06), Paceco (p. 05.16), Marausa (p. 05:29) Mozia-Birgi (p. 05.36), Spagnuola (p.05:45), Marsala (p.05:59), Terrenove (p.06.11), Petrosino-Strasatti (p.06:19), Mazara del Vallo (p.06:40), Campobello di Mazara (p.07:01), Castelvetrano (a.07:18). CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA218 nei giorni lavorativi. R 26640 TRAPANI 16:04 CASTELVETRANO 17:24 Orario del bus: Trapani (p. 16:04), Mozia-Birgi (p. 16:34), Marsala (p. 16:57), Petrosino-Strasatti (p. 17:17), Mazara del Vallo (p. 17:38), Campobello di Mazara (p. 17:59), Castelvetrano (a. 18:16). CANCELLATO E SOSTITUITO CON BUS PA220 nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì. Non circola venerdì 14 agosto 2020. R 26642 TRAPANI 17:30 CASTELVETRANO 18:53 Orario del bus: Trapani (p. 17:30), Marausa (p. 17:53), Mozia-Birgi (p. 18:00), Spagnuola (p. 18:09), Marsala (p. 18:23), Petrosino-Strasatti (p. 18:43), Mazara del Vallo (p. 19:04), Campobello di Mazara (p. 19:25), Castelvetrano (a. 19:42). -

IL CULTO DI MARIA SS. DI CUSTONACI a VALDERICE Di Maria Anna Milana
IL CULTO DI MARIA SS. DI CUSTONACI A VALDERICE di Maria Anna Milana Il culto di Maria SS. ma di Custonaci, ampiamente illustrato da Vincenzo Vassallo nel libro che avrete dopo tra le mani, si è esteso a macchia d’olio non solo nel territorio dell’antico Agro ericino, ma oltre, come testimonia il Castronovo nel suo libro Le glorie di Maria SS.ma Immacolata sotto il titolo di Custonaci, dove l’autore fa un lungo e dettagliato elenco delle località in cui la Madonna di Custonaci è stata venerata. Vengono citate i centri di Trapani, Marsala, S. Vito Lo Capo, Mazara, Castelvetrano, Agrigento, Palermo e – aggiunge Vincenzo Vassallo –, anche in Francia, in Spagna, in Tunisia e nelle Americhe se n’era diffuso il culto “ovunque si trovasse un ericino”. A tal proposito è interessante ricordare che anche a Roma, nella chiesa di S. Giuseppe al Trionfale, l’ericino Francesco Cascio aveva promosso iniziative per venerare la Madonna di Custonaci sotto il titolo di Madonna della Provvidenza. Ne parla Salvatore Giurlanda nel suo libro Maria SS. ma di Custonaci: il culto ieri e oggi e Vincenzo Vassallo riporta un’ampia documentazione su questa iniziativa e sugli sviluppi che essa poi ebbe nel tempo. Da nostre ricerche effettuate a Roma nella chiesa di S. Giuseppe al Trionfale non esiste attualmente traccia del culto alla Madonna della Provvidenza. Tra gli abitanti dell’antico Agro ericino il culto della Vergine di Custonaci si presume sia stato presente sin dal XV secolo, ancor prima che iniziassero i trasporti. Nelle chiese dei paesi che adesso formano l’Unione dei Comuni Elimo Ericini si trovavano – e in qualche caso si trovano ancora – i quadri che riproducono l’antica sacra immagine. -

Italy, the Deep South and Sicily
Italy, the Deep South and Sicily Tour Information Italy, the Deep South and Sicily TOUR INFORMATION You are travelling to Europe – a wonderful assembly of diverse countries that have, over hundreds of years, evolved and formulated their individual and often unique customs, styles and quirkiness. We want to (and sometimes have to) fit into the region’s natural patterns and irregularities. Much will appear so very different from ‘home’ – and surely it is exactly those very differences that inspired you to go there in the first place! To help you, the following pages contains additional information specific to your tour including brief introductory information regarding the major sites and regions you will be visiting. We would like to wish you a wonderful trip through Europe and a safe return home. Best wishes from the Albatross Team Italy, the Deep South and Sicily Italian traffic rules and regulations You will see in our promotional brochure that the Albatross style of touring emphasises a more leisurely pace with a number of 2, 3, 4 and even 5 night stops. This is always our objective and on virtually all of our programme tours throughout Europe it is relatively easily achievable. In Italy, however, despite having longer stays in each place than any other tour we still have to have a number of earlier starts. This is beyond our control. You see, throughout Italy local councils, cities and regions impose some quite significant restrictions on coach usage, stopping, parking and pick up points. These local by-laws change from year to year and can even change during the summer tourist season. -

Castellammare Del Golfo
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale SERVIZIO GEOLOGICO D’ ITALIA Organo Cartografico dello Stato (legge n° 68 del2.2.1960) NOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA alla scala 1:50.000 foglio 593 CASTELLAMMARE DEL GOLFO A cura di: R. Catalano°*, M. Agate°*, L. Basilone*, C. Di Maggio*, M. Mancuso°, A. Sulli° Con contributi di: E. Di Stefano*, M. Gasparo Morticelli*, G. Avellone*, B. Abate*, M. Arnone*, G. Lo Cicero°*, M. Scannavino° & C. Gugliotta* AreePROGETTO marine° e terrestri* Dipartimento di Geologia e Geodesia, Università di Palermo Ente realizzatore: Regione SicilianaCARG - Assessorato Territorio ed Ambiente Direttore del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA: C. Campobasso. Responsabile del Progetto CARG per il Servizio Geologico d’Italia - ISPRA: F. Galluzzo Responsabile del Progetto CARG per la Regione Siciliana: A. Guadagnino PER IL SERVIZIO GEOLO G ICO D’ITALIA - ISPRA: Revisione scientifica: R. Bonomo, M. C. Giovagnoli, E. La Posta, M. Marino, S. D’Angelo, A. Fiorentino (aree marine) Coordinamento cartografico: D. Tacchia (coord.), F. Pilato Revisione informatizzazione dei dati geologici: L. Battaglini, C. Cipolloni, D. Delogo, M. C. Giovagnoli (ASC) Coordinamento editoriale e allestimento per la stampa: D. Tacchia, F. Pilato PER LA RE G IONE SICILIANA Coordinamento informatizzazione: Nadir s.a.s. Informatizzazione dei dati geologici: Nadir s.a.s. PROGETTOAllestimento editoriale: L. Basilone, S.Pierini GE S TIONE TECNICO -AMMINISTRATIVA DEL PRO G ETTO CARG M.T. Lettieri - Servizio Geologico d’Italia - ISPRA A. Guadagnino - Regione Siciliana Si ringraziano i componenti dei Comitati CARG Geologici per il loro contributo scientifico. Stampa: SY S TEM CART srl - 2011 INDICE I - INTRODUZIONE .................................. -

Notice of Application for an Oil and Gas Exploration Licence Designated Vita
C 173/22 EN Official Journal of the European Union 25.7.2009 NOTICE OF APPLICATION FOR AN OIL AND GAS EXPLORATION LICENCE DESIGNATED ‘VITA’ REPUBLIC OF ITALY — REGION OF SICILY REGIONAL MINISTRY OF INDUSTRY — REGIONAL DEPARTMENT OF MINING REGIONAL OFFICE FOR HYDROCARBONS AND GEOTHERMAL ENERGY (U.R.I.G.) (2009/C 173/11) Edison S.p.A., a company with a registered office at Foro E. Point situated at trigonometric point 151 metres above sea Buonaparte 31, Milan, and fiscal code 06722600019, by appli level, in the Contrada of Trinità at the SE edge of the Chiesa cation of 10 May 2006 and additional application of 2 August della Trinità; 2007, applied to the Regional Minister for Industry, the competent authority for granting mining rights in the Region of Sicily, with its registered office at via Ugo La Malfa 87/89, F. Point consisting of a concrete post fixed onto the well at 90146 Palermo, in accordance with Regional Law of Sicily elevation 200 metres situated 275 metres east of the road No 14 of 3 July 2000 transposing and implementing from the south to Borgo Aquila in the contrada of the same Directive 94/22/EC, for an oil and gas exploration licence (con name. It coincides with point ‘f’ of the area of the ‘Lippone- ventionally known as ‘Vita’) extending over 68 210 ha in Mazara del Vallo’ licence; Western Sicily in the provinces of Palermo and Trapani. The area referred to has free boundaries to the north, east and south. To the west, along the section between points F and G, it is G. -
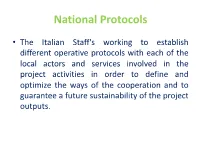
Saarbruchen Presentation
National Protocols • The Italian Staff's working to establish different operative protocols with each of the local actors and services involved in the project activities in order to define and optimize the ways of the cooperation and to guarantee a future sustainability of the project outputs. Protocols Objectives 1. To make new cooperative conditions for defining and planning the multicultural support system for migrant women, victims of S/GBV and future activities and services to support them. 2. To create new networking among institutions and social actors operating in the field of the gender based violence 3. To involve local actors in the establishment of the operative protocol to help migrants women had violence experiences 4. To rule the EcA’s placements in the local services Why were protocols necessary? • To work with Public Services it’s needed an official agreement that specify terms and conditions of the collaboration ( timework, action and types of activities, voluntary or waged work, finance charge, etc ). • To discern the responsibilities of each members of the partnership . • To assure and make official work of each operators, EcA’s and workers involved in the activities project. Protocols already undersigned • Municipality of Valderice • No profit associations and cooperatives: – Esercito della salvezza (The Salvation Army)–Castelvetrano working in the field of ANTI-TRAFFICKING – La Mimosa – Safe House for Women - Mazara del Vallo – Coesi – Reception center for migrants (women and families ) Valderice • Women’s Aid centers: – Casa di venere (Non-Violence against women Centre ) - Marsala – Demetra (anti-violence against women desk - VAW desk) - Mazara Del Vallo Protocols to be signed • Municipality of Castelvetrano – • Municipality of Mazara del Vallo – • Municipality of Marsala – • SFERA Association working in the fields of guidance, counseling and mediation for migrants. -

TRAPANI ORARIO Ln VIGORE Dal 70 - I - 2021 Partenae DALL'aeroporto BIRGI Per
ffie AZIEN DA SICI LIANA TRASPORTI SEDE DI TRAPANI ORARIO lN VIGORE dal 70 - I - 2021 PARTENaE DALL'AEROPORTO BIRGI pER: ORARI FERIALI . WEEKDAY I 5.50 6.30 7.15 8.40 9.00 LUNEDI LU-VE-SA 11.30 12.00 1234 13.00 13.30 TRAPANI VENERDI LU-SA VENERDI SABATO LUNEDI 16.00 17.30 ( PACECO ) 13.50 14.50 18.40 LU-VE VENERDI 20,45 21 .15 22,0A MA-SA LUNEDI LU-VE MARSALA 7.25 12.40 13.30 14.55 MAZARA DEL VALLO 7.25 13.30 14.55 CASTELVETRANO - CAMPOBELLO 7.25 13.30 SALAPARUTA _ POGGIOREALE 13.30 I PARTANNA - SANTA NINFA 13.30 I ORARI FESTIVI . HOLIDAY.HOURS TRAPANI 8.45 12,30 17.40 18.40 22.00 Paceco AEROPORTO BIRGI - TRAPANI EURo 4.90 TICKET: AEROPORTO BIRGI - TVIARSALA EURo 2 70 AEROPORTO BIRGI - MAZARA DEL VALLO EURo 4.1 N.B.: IL 25 DICEMBRE NON VIENE EFFETTUATO NESSUN SERVIZIO / NO SERVICE IS PROVIDED ON DECEMBER 25 TH A.S.T. - Trapani - Direzione tel.0923.21021 informazioni A.S.T. - Trapani - Direzione - Via Virgilio 20 - fax 0923.872939 www.astsicilia.it N.B.: L'Azienda si riserva con altre pubblicazioni di modificare il presente orario. N.B.: Munirsi di biglietto o di monete prima disalire a bordo. PIease Note: Please to be provided with tickets or small coin before boarding. N. B.: LE FERMATE SONO A RICHIESTA. -..% *,effi* SEDE DI TRAPANI ORARIO FERIALE INVERNALE lN VIGORE dal 11 -1 -2021 PARTENZE DA TRAPANI PER 5.00 5.45 10.00 11.30 14.45 15.30 6.35 7.15 12.00 12.50 14.15 17.00 LUNEDI LU-VE-SA LU-VE-SI LU-VE-SÀ II-VF VENERDI AEROPORTO BIRGI 19.15 21.0U LU-VE ACQUESORBE 6.35 c 13.45 v ALATA DI BAIDA 13.30 c 14.15 c 18.00 c ALLATA 12.30 c 14.15 -

Piano Comunale Di Protezione Civile
COMUNE DI SANTA NINFA Libero Consorzio Comunale di Trapani Piazza Libertà, 1 – 91029 SANTA NINFA (TP) Tel. 0924-992001 Fax 0924-62100 www.comune.santaninfa.tp.it protocollo@pec. comune.santaninfa.tp.it PIANO COMUNALE DI EMERGENZA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE Redatto da: Arch. Vincenzo Morreale ________________________________ Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio Responsabile comunale di protezione civile Collaboratore: Geom. Gino Li Causi dipendente dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio Elaborazioni cartografiche: Ing. Alessandro Putaggio Responsabile del servizio nodo S.I.T.R. del Libero Consorzio Comunale di Trapani Il Sindaco: Dott. Giuseppe Lombardino ________________________ Data: Novembre 2015 Aggiornamenti: Dicembre 2017 Adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 132 del 02/12/2015 Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° ______ del _______________ Comune di Santa Ninfa (TP) Piano Comunale di Emergenza in materia di Protezione Civile - 2 - INDICE PREMESSA 7 1. PARTE GENERALE 9 1.1. DISTRIBUZIONE E REVISIONE 9 1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI 10 1.3. IL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 11 2. INQUADRAMENTO AMBIENTALE-TERRITORIALE 2.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO 12 2.2. INQUADRAMENTO DELL’AMBIENTE NATURALE 14 2.2.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO 14 2.2.1.1. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 15 2.2.1.2. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 15 2.2.1.3. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 15 2.2.2. CARATTERISTICHE CLIMATICHE 15 2.3. INQUADRAMENTO DELL’AMBIENTE URBANIZZATO 17 2.4. RETE VIARIA E FERROVIARIA 17 2.5. RETI TECN0LOGICHE 18 3. DATI DI BASE RELATIVI AL COMUNE 19 3.1. ELEMENTI ESPOSTI A RISCHIO 19 3.1.1. -

Dal 2 Marzo All'11 Aprile 2021
DAL 2 MARZO ALL’11 APRILE 2021 LINEA PIRAINETO - CASTELVETRANO - TRAPANI MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRENI Da martedì 2 marzo a domenica 11 aprile 2021, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Marsala, i seguenti treni regionali subiscono variazioni. I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati. Da PIRAINETO/ CINISI-TERRASINI / ALCAMO DIR.NE / CASTELVETRANO per CASTELVETRANO / TRAPANI Treno Partenza Ora Arrivo Ora Provvedimenti CIRCOLA CON NUOVO NUMERO R 34875 MODIFICA L’ORARIO A: Spagnuola (p. 07:03), Mozia-Birgi (p. 07:15), R 21853 CASTELVETRANO 06:00 TRAPANI 07:38 Marausa (p. 07:21), Paceco (p. 07:31). Restano invariate le rimanenti fermate e gli orari. CIRCOLA CON NUOVO NUMERO R 34861 E MODIFICA L’ORARIO A: Marsala (p. 07:16), Spagnuola (p. 07:22), R 21857 CASTELVETRANO 06:20 TRAPANI 07:58 Mozia-Birgi (p. 07:28), Trapani (a. 07:54). Restano invariate le rimanenti fermate e gli orari. CIRCOLA CON NUOVO NUMERO R 34851 E MODIFICA L’ORARIO A: Castelvetrano (p. 08:28), Campobello di R 21859 CINISI-TERRASINI 06:55 TRAPANI 09:41 Mazara (p. 08:37), Mazara del Vallo (p. 8:50). Restano invariate le rimanenti fermate e gli orari. CIRCOLA CON NUOVO NUMERO R 34853, POSTICIPA LA PARTENZA A Castelvetrano (p. 7:30) E MODIFICA L’ORARIO A: R 21861 CASTELVETRANO 07:28 TRAPANI 08:55 Campobello di Mazara (p. 07:39), Mazara del Vallo (p. 08:03), Petrosino-Strasatti (p. 08:13), Terrenove (p. 08:17), Marsala (p. 08:24), Spagnuola(p. 08:30), Mozia-Birgi(p. 08:36), Marausa (p. 08:42), Trapani (a. -

Deputazione Provinciale Di Trapani Ramo Proietti
ARCHIVIO DI STATO DI TRAPANI DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI RAMO PROIETTI CONTABILITA’ 1877 - 1906 Regg., fascc. 421 in bb. 36 Revisione: A. Di Miceli (2020) http://www.archiviodistatotrapani.beniculturali.it/index.php?it/266/deputazione-provinciale-di-trapani-ramo-proietti NOTA INTRODUTTIVA Nel Regno delle Due Sicilie l’ambito della pubblica beneficenza era di competenza dell’Intendente, coadiuvato dal Consiglio degli Ospizi della Valle1, cui era assegnata la sorveglianza e il controllo sugli stabilimenti di beneficenza, compresi i brefotrofi; ai Sindaci spettava l’amministrazione dei fondi per il mantenimento dei proietti; specifiche commissioni comunali2 erano deputate, invece, alla vigilanza sui proietti e sulle balie e alla distribuzione delle paghe mensili alle nutrici, funzioni precedentemente esercitate dalle “Deputazioni pè projetti”3. Dopo l’Unità d’Italia, con legge 20 marzo 18654, si dispose che le spese per il mantenimento degli esposti dovessero essere a carico dei Comuni e delle Province. Le “Commissioni comunali di sorveglianza per i proietti”5, laddove esistenti, o le Congregazioni di carità del Comune, continuarono ad occuparsi della sorveglianza sulle balie, della distribuzione delle loro paghe e, inoltre, della compilazione delle tabelle mensili dei trovatelli che, successivamente, inviavano al Prefetto, Presidente della Deputazione provinciale, per il relativo visto. Il complesso archivistico conservato nell’Archivio di Stato di Trapani è stato versato dalla Deputazione provinciale di Trapani in due distinti momenti. Nel 1890 furono consegnati all’allora Archivio provinciale: “registri di contabilità dei proietti della provincia di Trapani” dei comuni di: Alcamo, Calatafimi, Campobello di Mazara, Camporeale, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Monte San Giuliano, Salaparuta, Salemi, S.