Il Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 Il
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Formulation of Territorial Action Plans for Coastal Protection and Management
this project is co-funded by the European Regional Development Fund Eu project COASTANCE FINAL REPORT phase C Component 4 Territorial Action Plans for coastal protection and management Formulation of territorial Action Plans for coastal protection and management 96 95 94 93 PARTNERSHIP Region of Eastern Macedonia & Thrace (GR) - Lead Partner Regione Lazio (IT) Region of Crete (GR) Département de l’Hérault (FR) Regione Emlia-Romagna (IT) Junta de Andalucia (ES) The Ministry of Communications & Works of Cyprus (CY) Dubrovnik Neretva County Regional Development Agency (HR) a publication edit by Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica responsibles Roberto Montanari, Christian Marasmi - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica editor and graphic Christian Marasmi authors Roberto Montanari, Christian Marasmi - Regione Emilia-Romagna, Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica Mentino Preti, Margherita Aguzzi, Nunzio De Nigris, Maurizio Morelli - ARPA Emilia-Romagna, Unità Specialistica Mare e Costa Maurizio Farina - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa Michael Aftias, Eleni Chouli - Ydronomi, Consulting Engineers Philippe Carbonnel, Alexandre Richard - Département de l’Hérault INDEX Background and strategic framework 2 The COASTANCE project 6 Component 4 strategy framework 8 Component 4 results: coastal and sediment management plans 10 Relevance of project’s outputs and results in the EU policy framework and perspectives 10 Limits and difficulties -

Viaggio a Gerusalemme Di Pietro Casola
VIAGGIO A GERUSALEMME DI PIETRO CASOLA a cura di Anna Paoletti Edizioni dell'Orso Opera pubblicata, con il contributo del Dipartimento di Scienze letterarie e filologiche dell'Università degli Studi di Torino. © 2001 Copyright by Edizioni dell'Orso S.r.l. 15100 Alessandria, via Rattazzi 47 Tel. 0131. 25.23.49 – Fax 0131.25.75.67 E-mail: [email protected] http: //www.ediorso.it Impaginazione a cura di CDR, Torino È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell’art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.1941 ISBN 88-7694-530-X Prefazione di Jeannine Guérin Dalle Mese 1494: Pietro Casola, milanese, intraprende dopo tanti altri il viaggio a Gerusalemme. Mentre si va esplorando vie oceaniche ignote e scoprendo un nuovo mondo, molti continuano a solcare il Mediterraneo, ripetendo viaggi compiuti da secoli, ma sempre avventurosi, verso una meta sacra, la Terra Santa. Scoprono se stessi e le vere componenti della natura umana confrontata ai vari pericoli che si presentano loro, in una prova di eccezionale importanza, quella della fede. Così appare il viaggio ai Luoghi santi del Casola sul finire del Quattrocento. Non si tratta più, nella sua relazione, di ribadire quello che è stato scritto tantissime volte a proposito del pellegrinaggio a Gerusalemme e delle sue tappe obbligate, anche se si serve - come ovvio - di guide anteriori per riportare talvolta alcune informazioni. Le lunghe liste d’indulgenze, le preghiere da recitare, le reliquie sante da visitare non fanno parte del suo proposito: molti altri le hanno menzionate come, ad esempio, solo quattordici anni prima, il suo concittadino Santo Brasca. -

Economic Impact of the Cultural Routes of the Council of Europe in the EU Macro-Regions Routes4u | 15
Economic impact of the Cultural Routes of the Council of Europe in the EU macro-regions Routes4U | 15 Routes4U Council of Europe Routes4U | 15 Directorate General Democracy of Europe of the Council Routes impactEconomic of the Cultural F-67075 Strasbourg Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes – Council of Europe European Institute of Cultural Routes 28 rue Münster in the EU macro-regions L-2160 Luxembourg Tel. +352 24 12 50 Routes4U www.coe.int/routes4u Cultural Routes of the Adriatic-Ionian, Alpine, Baltic Sea Council of Europe in the and Danube macro-regions PREMS 026120 ENG The Council of Europe is the continent’s leading The Member States of the European Union human rights organisation. It comprises 47 member have decided to link together their know- states, including all members of the European Union. how, resources and destinies. Together, they All Council of Europe member states have signed up have built a zone of stability, democracy and to the European Convention on Human Rights, sustainable development whilst maintaining a treaty designed to protect human rights, cultural diversity, tolerance and individual democracy and the rule of law. The European Court freedoms. The European Union is committed of Human Rights oversees the implementation to sharing its achievements and its values with of the Convention in the member states. countries and peoples beyond its borders. www.coe.int www.europa.eu Routes4U Project Routes4U Project Economic impact of the Cultural Routes of the Council of Europe in the European Union macro-regions Routes4U | 15 Council of Europe The opinions expressed in this work are the responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy of the European Commission or the Council of Europe All requests concerning the reproduction or translation of all or part of this document should be addressed to the Directorate of Communication (F-67075 Strasbourg Cedex or [email protected]). -

Pilgrims and Pilgrimage in the Medieval West
Pilgrims and Pilgrimage in the Medieval West The International Library of Historical Studies Series ISBN 1 86064 079 6 Editorial Board: Professor David N.␣ Cannadine, Director, Institute of Historical Research, University of London; Wm. Roger Louis, Dis- tinguished Teaching Professor and Kerr Chair in English History and Culture, University of Texas, Austin; Gene R. Garthwaite, Jane and Raphael Bernstein Professor of Asian Studies, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire; Andrew N. Porter, Rhodes Professor of Imperial History, King’s College London; Professor James Piscatori, Oxford Centre for Islamic Studies and Fellow of Wadham College, Oxford; Professor Dr Erik J. Zürcher, Chair, Turkish Studies, University of Leiden Series Editors: Andrew Ayton, University of Hull (medieval history); Christopher J. Wrigley, Professor of Modern British History, University of Nottingham The International Library of Historical Studies (ILHS) brings together the work of leading historians from universities in the English-speaking world and beyond. It constitutes a forum for original scholarship from the United Kingdom, continental Europe, the USA, the Common- wealth and the Developing World. The books are the fruit of original research and thinking and they contribute to the most advanced historiographical debate and are exhaustively assessed by the authors’ academic peers. The Library consists of a numbered series, covers a wide subject range and is truly international in its geographical scope. It provides a unique and authoritative resource for libraries -
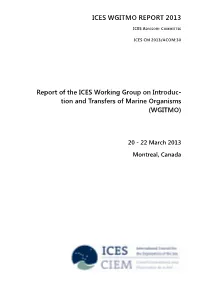
Ices Wgitmo Report 2013
ICES WGITMO REPORT 2013 ICES ADVISORY COMMITTEE ICES CM 2013/ACOM:30 Report of the ICES Working Group on Introduc- tion and Transfers of Marine Organisms (WGITMO) 20 - 22 March 2013 Montreal, Canada International Council for the Exploration of the Sea Conseil International pour l’Exploration de la Mer H. C. Andersens Boulevard 44–46 DK-1553 Copenhagen V Denmark Telephone (+45) 33 38 67 00 Telefax (+45) 33 93 42 15 www.ices.dk [email protected] Recommended format for purposes of citation: ICES. 2013. Report of the ICES Working Group on Introduction and Transfers of Ma- rine Organisms (WGITMO), 20 - 22 March 2013, Montreal, Canada. ICES CM 2013/ACOM:30. 149 pp. For permission to reproduce material from this publication, please apply to the Gen- eral Secretary. The document is a report of an Expert Group under the auspices of the International Council for the Exploration of the Sea and does not necessarily represent the views of the Council. © 2013 International Council for the Exploration of the Sea ICES WGITMO REPORT 2013 i Contents Executive summary ................................................................................................................ 1 1 Opening of the meeting ................................................................................................ 2 2 Adoption of the agenda ................................................................................................ 2 3 WGITMO Terms of Reference .................................................................................... 2 4 Progress in relation -

Guide of Lighthouses and Semaphores
Guide of lighthouses and semaphores TM References Guide of lighthouses and semaphores. Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (France), Agence pour la protection et l’Aménagement du Littoral en Tunisie (Tunisia), Société pour la Protection de la Nature au Liban (Lebanon), Municipality of Tyre (Lebanon). Legal note These guidelines have been written under the MED-PHARES project "Integrated Management Strategies to develop the heritage of lighthouses, semaphore stations and maritime signaling systems of the Mediterranean", funded by the EU within the framework of the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin. The contents of this document are the sole responsibility of the beneficiary of the project and partners and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of the management structures of the Programme. Guide of lighthouses and semaphores Italy France Tunisia Lebanon Preface The MED-PHARES project is a cross-border cooperation project, funded by the European Union through the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) for the Mediterranean Maritime Basin (ENPI- CBC MED). The project brings together countries of North, South and East of the Mediterranean area with the Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna (beneficiary of the project - Italy) and four other partners: Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (France), Agence pour la protection et l'Aménagement du Littoral en Tunisie (Tunisia), Société pour la Protection de la Nature au Liban and the Municipality of Tyre (Lebanon). The project aims to develop a model that is applicable in every country of the Mediterranean area, with the purpose of emphasizing the unique material and immaterial features of this heritage including the coastal areas with the presence of lighthouses and semaphore. -
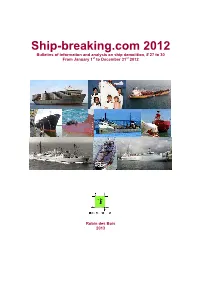
Ship-Breaking.Com 2012 Bulletins of Information and Analysis on Ship Demolition, # 27 to 30 from January 1St to December 31St 2012
Ship-breaking.com 2012 Bulletins of information and analysis on ship demolition, # 27 to 30 From January 1st to December 31st 2012 Robin des Bois 2013 Ship-breaking.com Bulletins of information and analysis on ship demolition 2012 Content # 27 from January 1st to April 15th …..……………………….………………….…. 3 (Demolition on the field (continued); The European Union surrenders; The Senegal project ; Letters to the Editor ; A Tsunami of Scrapping in Asia; The END – Pacific Princess, the Love Boat is not entertaining anymore) # 28 from April 16th to July 15th ……..…………………..……………….……..… 77 (Ocean Producer, a fast ship leaves for the scrap yard ; The Tellier leaves with honor; Matterhorn, from Brest to Bordeaux ; Letters to the Editor ; The scrapping of a Portuguese navy ship ; The India – Bangladesh pendulum The END – Ocean Shearer, end of the cruise for the sheep) # 29 from July 16th to October 14th ....……………………..……………….……… 133 (After theExxon Valdez, the Hebei Spirit ; The damaged ship conundrum; Farewell to container ships ; Lepse ; Letters to the Editor ; No summer break ; The END – the explosion of Prem Divya) # 30 from October 15th to December 31st ….………………..…………….……… 197 (Already broken up, but heading for demolition ; Demolition in America; Falsterborev, a light goes out ; Ships without place of refuge; Demolition on the field (continued) ; Hong Kong Convention; The final 2012 sprint; 2012, a record year; The END – Charlesville, from Belgian Congo to Lithuania) Global Statement 2012 ……………………… …………………..…………….……… 266 Bulletin of information and analysis May 7, 2012 on ship demolition # 27 from January 1 to April 15, 2012 Ship-breaking.com An 83 year old veteran leaves for ship-breaking. The Great Lakes bulker Maumee left for demolition at the Canadian ship-breaking yard at Port Colborne (see p 61). -
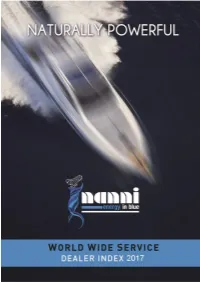
Nanni-Wws.Pdf
1 Worldwide Presence with guaranteed Service Nanni products are supported at every major port thanks to a worldwide network of independent distributor facilities and dealer locations, delivering the expertise and parts needed to keep customer's products running smoothly. By choosing a Nanni product, you gain an extensive Worldwide Sales and Service network to help you achieve maximum engine life and sustained reliability. Update 29/06/2017 2 Index NANNI NETWORK ........................ 3 La Réunion ................................. 47 Lituania ....................................... 48 Algeria ............................................ 5 Madagascar ................................ 48 Argentina ....................................... 5 Malaysia ..................................... 48 Australia ........................................ 5 Maldives ..................................... 48 Bahamas ........................................ 7 Malta ........................................... 48 Bangladesh .................................... 7 Marocco ...................................... 48 Belgium .......................................... 7 Martinique ................................... 49 Brazil .............................................. 7 Mexico ........................................ 49 Brunei ............................................ 8 Netherlands ................................ 49 Canada .......................................... 8 New Caledonia .................... 500 Chili ............................................... -

Mamluk Studies Review Vol. V (2001)
MAMLU±K STUDIES REVIEW V 2001 MIDDLE EAST DOCUMENTATION CENTER (MEDOC) THE UNIVERSITY OF CHICAGO PLEASE NOTE: As of 2015, to ensure open access to scholarship, we have updated and clarified our copyright policies. This page has been added to all back issues to explain the changes. See http://mamluk.uchicago.edu/open-acess.html for more information. MAMLŪK STUDIES REVIEW published by the middle east documentation center (medoc) the university of chicago E-ISSN 1947-2404 (ISSN for printed volumes: 1086-170X) Mamlūk Studies Review is an annual, Open Access, refereed journal devoted to the study of the Mamluk Sultanate of Egypt and Syria (648–922/1250–1517). The goals ofMamlūk Studies Review are to take stock of scholarship devoted to the Mamluk era, nurture communication within the field, and promote further research by encouraging the critical discussion of all aspects of this important medieval Islamic polity. The journal includes both articles and reviews of recent books. Submissions of original work on any aspect of the field are welcome, although the editorial board will periodically issue volumes devoted to specific topics and themes.Mamlūk Studies Review also solicits edited texts and translations of shorter Arabic source materials (waqf deeds, letters,fatawa and the like), and encourages discussions of Mamluk era artifacts (pottery, coins, etc.) that place these resources in wider contexts. An article or book review in Mamlūk Studies Review makes its author a contributor to the scholarly literature and should add to a constructive dialogue. Questions regarding style should be resolved through reference to the MSR Editorial and Style Guide (http://mamluk.uchicago.edu/msr.html) and The Chicago Manual of Style. -
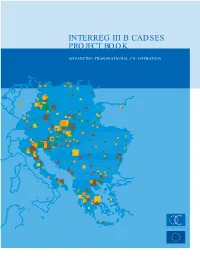
Interreg Iii B Cadses Project Book
INTERREG III B CADSES PROJECT BOOK ADVANCING TRANSNATIONAL CO-OPERATION Preface “Spatial development co-operation”, and more recently “territorial co-operation”, have become buzzwords for concepts which foster European spatial integration and cohesion. From 2000 to 2006 the INTERREG III B CADSES Programme has provided a platform to apply these principles which have also been proposed by the European Spatial Development Perspective (ESDP) for a balanced and sustainable development of Central and South-Eas- tern Europe. The Programme enables and fi nances project collaborations on topics ranging from the improvement of transport systems and access to the information society to the revitalisation of derelict urban areas and fl ood protection. The third edition of the CADSES Project Book compiles for the fi rst time all 134 projects approved within the EU Community Initiative INTERREG III B for transnational co-operation in Central and South-Eastern Europe. The projects were selected by the CADSES Steering Committee in four calls for project proposals, which took place between 2002 and 2006. The last call was completed in 2006 and was carried out within the framework of the neighbourhood approach. This approach stands for better integration of EU Member States, candidate countries and neighbouring countries by supporting transnational co-operation along the external borders of the enlarged European Union. The aim of this book is to illustrate how the approved projects contribute to the achievements of the objectives of CADSES. In many cases the projects have already achieved their fi nal results. By illustrating them the CADSES Project Book should also serve as reference material for those who wish to develop new partnerships and project ideas in the fi eld of territorial co-operation for the upcoming 2007-2013 programming period. -

Ground-Services-2020-1.Pdf
Welcome to Italy Let us guide you along a unique holiday experience. We know the country and her culture, the hidden treasures of large cities and small villages, the scents and the flavour of our food and wine. Alviani Viaggi - Sorrento - Tel. 081/807.3046 - Fax 081/807.1791 [email protected] - www.alvianiviaggi.com Alviani Viaggi S.r.l. v Milano & Bergamo Piazza Andrea Veniero, 15/16 80067 – Sorrento (NA) v Torino Italy v Verona Tel.: +39/081/8073046 Fax: +39/081/8071791 v Venezia & Treviso [email protected] www.alvianiviaggi.com v Genova & Italian Riviera Out of office hours - Emergency only v French Riviera Mobile no.: +39/333/9001669 v Bologna Office hours: v Firenze ➢ Winter time : November 01 / March 31 v Tuscany Private Tours Mon/Fri: 09:00 / 19:00 v Livorno Harbour Saturday: 09:00 / 13:00 Sunday: closed v Pisa & Siena ➢ Summer time : v Civitavecchia Harbour April 01 / October 31 v Roma Mon/Fri: 09:00 / 20:00 Saturday: 09:00 / 18.00 v The Bay of Naples & Amalfi Coast Sunday: closed v Bari & Brindisi (Apulia ) We are closed : v Lamezia Terme ( Calabria ) January 1 April 12 v Sicilia November 1 December 8, 25 & 26 v Sardegna We have reduced service : v Throughout Italy April 13 • Classic Rent a Car April 25 May 1 • Shopping Tours June 2 August 15 • Helicopters Transfer & Tours December 24 & 31 • Luxury Rent a Car *** Issue n° 1 – October 19 Travel Industry Designator Service 1 Visit Our Web for Hotel Rates 2020 From family run properties to Italy’s best-known luxury hotels, we offer the perfect place for your clients. -

Diversification of Portulaca Oleracea L. Complex in the Italian Peninsula and Adjacent Islands†
BOTANY LETTERS, 2016 http://dx.doi.org/10.1080/23818107.2016.1200482 Diversification of Portulaca oleracea L. complex in the Italian peninsula and adjacent islands† Avinoam Danina, Fabrizio Buldrinib,g, Marta Bandini Mazzantib, Giovanna Bosib, Maria Carmela Cariac, David Dandriad, Edwin Lanfrancoe, Stephen Mifsudf and Simonetta Bagellac aDepartment of Ecology, Evolution, and Behavior, The Alexander Silberman Institute, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel; bOrto Botanico – Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italy; cDipartimento di Scienze della Natura e del Territorio, Università degli Studi di Sassari, Sassari, Italy; dDepartment of Biology, University of Malta, Msida, Malta; eDepartment of Biology & Institute of Earth Systems, University of Malta, Msida, Malta; fEcoGozo, Ministry for Gozo, Victoria, Gozo (Malta); gDipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italy ABSTRACT ARTICLE HISTORY There is an increasing interest in the taxonomy and distribution of the forms of the Portulaca Received 11 December 2015 oleracea complex. The information accruing from specimens collected in the Italian peninsula and Accepted 2 June 2016 surrounding islands (Sicily, Sardinia, Corsica and Malta) is here described. Eleven morphotypes KEYWORDS were recorded: ‘P. cypria’, ‘ P. granulatostellulata’, ‘ P. nitida’, ‘ P. oleracea’, ‘ P. papillatostellulata’, Corsica; Maltese Islands; ‘P. rausii’, ‘ P. sardoa’, ‘ P. sativa’, ‘ P. sicula’, ‘ P. trituberculata’, ‘ P. zaffranii’ and a still unclear form purslane; Sardinia; seed Portulaca oleracea f. Three occur in almost all the Italian peninsula and adjacent islands; three tegument; Sicily; Portulaca are scattered in the Italian peninsula and in the adjacent islands; the remnant have a distribution restricted to the islands such as Sicily and Sardinia.