Almanacco 71 72.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Il Movimento Operaio a Pola Nel 1907
BRUNO FLEGO- OTT AVIO PAOLETié IL MOVIMENTO OPERAIO A POLA NEL 1907 • Relazione letta al Memoriale di Pisino 1984. Questo saggio va concepito come un modesto capitolo di quella che do vrebbe essere una vasta opera sul movimento operaio, sul partito socialista, sulla lotta di classe e nazionale in Istria, dagli albori di questo secolo al 1918. Su questo specifico periodo storico che vede a Pola e in Istria affermarsi le pri me organizzazioni operaie su base classista e internazionalista, non possiamo negare che si sono fatte delle costruzioni e conclusioni che non hanno nulla da fare con una storiografia intesa come scienza del reale e dello sviluppo del rea le. Non per niente lo storico croato V. Bratulié ebbe a dire: "Guardare unilate ralmente lo sviluppo storico di un territorio si arriva a conclusioni sbagliate che non possono andare a vantaggio della scienza" . Esistono infatti, su questo periodo, questioni controverse che dovrebbero essere appianate attraverso un confronto democratico e dialettico libero da ogni parzialità. Con questi intendimenti ci proponiamo di dare una maggiore chiarezza dialettica a fatti e avvenimenti politici che hanno visto per protagonisti nel 1907 a Pola la classe operaia e il Partito socialista. Tralasciando tutta la parte introduttiva del nostro saggio per ragioni di tempo, entreremo subito nel meri to di una questione controversa e cioè quella delle elezioni politiche e ammi nistrative del 1907. AL DI SOPRA DEI NAZIONALISMI 11 24 febbraio 1907 ebbe luogo a Isola il III Convegno dei socialisti istr:ia ni. Erano presenti trenta delegati delle varie località della penisola. Argomen to centrale in dibattito erano le prossime elezioni politiche a suffragio univer sale, uguale, diretto e sçgreto e quelle amministrative. -

Un Triestino All'origine Del Partito Socialista Trentino
MIRKO SALTORI UN TRIESTINO ALL’ORIGINE DEL PARTITO SOCIALISTA TRENTINO Per una biografia di Antonio Gerin (1856-1926) Il socialismo è un “luogo” importante di verifica dei rapporti fra Trento e Trieste, fra Tirolo italiano e, più in generale, il cosiddetto Lito- rale (che comprendeva anche il Goriziano e l’Istria) nel periodo austria- co. Dobbiamo infatti tener conto di alcuni punti essenziali. Per prima cosa il partito socialista sorge e si organizza in Austria in un momento storico (alla fine degli anni ’80 dell’800) nel quale gli Ita- liani d’Austria si trovano ormai solamente in Trentino e nel Litorale (oltre ad una minoranza nella Dalmazia): non vi è più il grande bacino di italiani lombardi e veneti che sino a 20-30 anni prima costituiva, dal punto di vista demografico, un’importante parte dell’Impero. Il sociali- smo italiano d’Austria pone quindi fin da subito in evidenza il rapporto fra Trento e Trieste. In secondo luogo questi sono gli anni in cui la questione naziona- le torna a porsi prepotentemente entro l’Impero, soprattutto riguardo ai Cechi: ed anche per diversi settori di Italiani, che hanno ora uno Stato unitario a cui guardare, l’irredentismo diviene pratica politica comune. In terzo luogo, naturalmente, il socialismo italiano di Trento e di Trieste si trova a fare i conti con la compresenza di altre nazionalità, e quindi a mettere in pratica quei dettami internazionalisti che in altri paesi rimanevano postulato teorico: questo significava rapportarsi con l’elemento tedesco in Trentino (anche se le due nazionalità erano solo contigue, tranne che nei centri industriali di Innsbruck, Bolzano, Mera- no), e con quelli tedesco, sloveno e croato nel Litorale, ove invece il grado di frammistione è assai più elevato. -

Augusto Avancini. Inventario Sommario (1944-1939)
Augusto Avancini. Inventario sommario (1944-1939) a cura di Caterina Tomasi Fondazione Museo storico del Trentino 2006 Premessa Le carte afferenti ad Augusto Avancini, originariamente compresi all'interno del complesso della famiglia Battisti, sono state da questo scorporate e sommariamente ricondizionate nel 2005. In tale occasione vennero redatte le schede fondo e soggetto produttore, a cura di Renata Tomasoni e Caterina Tomasi. L'importazione di tali schede in AST-Sistema informativo degli archivi storici del Trentino e la conseguente revisione dei dati sono state curate da Mirella Duci nel corso del 2015, secondo le norme di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006". Albero delle strutture Augusto Avancini, 1844 - 1939 Documenti personali e familiari, 1844 - 1939 Attività politica e professionale, 1896 - 1924 Documenti in copia e degli eredi, 1939 - 1979 Albero dei soggetti produttori Avancini, Augusto, Strigno, 1868 febbraio 28 - Cles, 1939 giugno 6 Persona Avancini, Augusto 1868 febbraio 28 - 1939 giugno 6 Luoghi Trento, Bolzano, Vienna, Bregenz, Innsbruck Archivi prodotti Fondo Augusto Avancini, 01/01/1844 - 31/12/1939 Storia Nato a Strigno (Tn) il 28 febbraio 1868 da Lodovico e da Emilia degli Avancini, resta orfano di entrambi i genitori all'età di quattro anni. Dopo le scuole inferiori a Trento, inizia a lavorare come garzone di bottega prima a Trento e successivamente a Bolzano (1887-1893), dove impara il tedesco. Tornato a Trento, nel 1894 aderisce al movimento socialista; è attivo in varie iniziative e attività di partito, collabora attivamente con Cesare Battisti. Nel 1897 è candidato alle elezioni al parlamento, ma l'esito non gli sarà favorevole. -
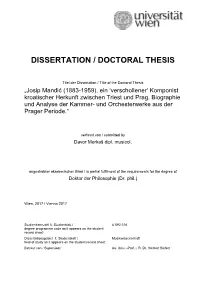
Dissertation / Doctoral Thesis
DISSERTATION / DOCTORAL THESIS Titel der Dissertation / Title of the Doctoral Thesis „Josip Mandić (1883-1959), ein ‘verschollener‘ Komponist kroatischer Herkunft zwischen Triest und Prag. Biographie und Analyse der Kammer- und Orchesterwerke aus der Prager Periode.“ verfasst von / submitted by Davor Merkaš dipl. musicol. angestrebter akademischer Grad / in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Wien, 2017 / Vienna 2017 Studienkennzahl lt. Studienblatt / A 092 316 degree programme code as it appears on the student record sheet: Dissertationsgebiet lt. Studienblatt / Musikwissenschaft field of study as it appears on the student record sheet: Betreut von / Supervisor: Ao. Univ. -Prof. i. R. Dr. Herbert Seifert 2 Inhaltsverzeichnis 1. VORWORT 7 2. BIOGRAPHIE 13 2.1. Allgemeine Probleme des Zugangs zur Biographie Josip Mandićs 13 2.2.1. Herkunft 15 2.2.2. Kindheit, Ausbildung (Schulzeit) und Studium – Triest, Rijeka, Zagreb, Wien, Graz (1884-1907) 19 2.3. Exkurs: Politische Tätigkeit Josip Mandićs - Triest (1905 – 1914) 39 2.3.1. Allgemeine gesellschafltlich-politische Situation in Triest im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts 39 2.3.2. Nationale Arbeiterorganisation (Narodna delavska organizacija) 46 2.3.3. Versuche als Dramatiker und politisches Engagement zu Beginn des Ersten Weltkrieges 58 2.4. Die Schweiz (1915-1920) 67 2.5. Prag (1920-1939): Leben und Wirken. Rückkehr zur Komposition 73 2.5.1. Fortsetzung des Musikstudiums in Prag mit den Prager Professoren. Werkrezeption in der zeitgenössichen Periodik 80 2.6. 1940 – 1959; Der Krieg und die Nachkriegszeit 120 3. BESPRECHUNG DER KAMMER- UND ORCHESTERWERKE AUS DER PRAGER SCHAFFENSPERIODE 143 3. 1. AUSFÜHRLICHE ANALYSEN 143 3.1.1. -

Diplomarbeit Soellwagner Maria
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Auswirkungen der italienischen Einigungsbewegung auf Triest und sein slawischsprachiges Umland Verfasserin Maria Söllwagner angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 190 313 350 Studienrichtung lt. Studienblatt: UF Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung, UF Italienisch Betreuerin: a.o. Univ.– Prof. Mag. Dr. Marija Wakounig MAS 2 Danksagung Ich möchte mich sehr herzlich bei meiner ganzen Familie, besonders bei meinen Eltern Waltraud und Josef sowie meinem Bruder Josef und bei meinem Freund Carmine für deren große Unterstützung während der gesamten Studienzeit bedanken. Sie alle haben mir viel Freude, Kraft und Motivation gegeben, mein Studium erfolgreich zu meistern. Dank gilt vor allem auch a.o. Univ.–Prof. Mag. Dr. Marija Wakounig MAS, die durch ihre sehr gute Betreuung und ihre Anregungen zum Gelingen dieser Diplomarbeit beigetragen hat. 3 4 Inhaltsverzeichnis 1. Einführung 7 1.1 Forschungsstand 11 2. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Triests in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 14 2.1 Konsolidierung des italienischen Nationalbewusstseins 14 2.2 Das Triester Bürgertum 17 2.3 Domenico Rossetti und die „Società di Minerva” 20 2.4 Die Rolle der Favilla für die italienische Nationalbewegung 23 2.5 Das Nationalbewusstsein der Italiener und Slowenen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 25 2.6 Triests Wirtschaft als Quelle des Wohlstands in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 27 3. Die Revolution von 1848 und ihre Auswirkungen auf Triest 31 3.1 Die Wahrnehmung der Revolution 31 3.2 Die „Società dei Triestini“ 35 3.3 Eine Audienz beim Kaiser 38 3.4 Die Triestiner Presse im Jahr 1848 39 3.5 Die Ergebnisse des Jahres 1848 43 4. -

Corporate Policing, Yellow Unionism, And
5 State authorities, municipal forces and military intervention in the policing of strikes in Austria- Hungary, 1890–1914 * Claire Morelon In an interpellation in the Austrian Parliament in 1908, a Social Democratic dep- uty denounced the actions of the police and gendarmerie in Troppau/Opava dur- ing a masons’ strike: The attitude of district officer Klinger and the municipality of Troppau and its police towards the strikers is absolutely improper and unlawful. Instead of acting impartially, they place themselves at the service of the master builders. This of course damages the trust of the workers and, in general, their percep- tion of justice, and undermines the authority of the officials.1 In early twentieth-century Austria-Hungary, in an age of growing democratisa- tion, the expectation that authorities would be impartial in labour disputes had far-reaching consequences. The need to maintain public order, a cornerstone of state duties, increasingly faced competing challenges. From the 1890s to 1914, the number of strikes (and of strikers involved) significantly rose in Austria-Hungary in a context of growing industrialisation.2 Consequently, employers were putting more pressure on state authorities to intervene in the management of the strikes. At the same time, the push for democratisation (culminating in 1907 with the intro- duction of universal and equal suffrage in parliamentary elections) and increased calls for constitutional rights to be respected meant that workers’ representatives demanded greater accountability from the Austrian government. This chapter examines how the Austrian state managed these competing demands in the two decades before the First World War. It analyses the regulation of public order in the Habsburg monarchy by examining the interaction between the different authorities at the local level and the centres of power. -

Corporate Policing, Yellow Unionism, and Strikebreaking, 1890–1930
Corporate Policing, Yellow Unionism, and Strikebreaking, 1890–1930 This book provides a comparative and transnational examination of the complex and multifaceted experiences of anti-labour mobilisation, from the bitter social conflicts of the pre-war period, through the epochal tremors of war and revolution, and the violent spasms of the 1920s and 1930s. It retraces the formation of an extensive market for corporate policing, privately contracted security and yellow unionism, as well as processes of professionalisation in strikebreaking activities, labour espionage and surveillance. It reconstructs the diverse spectrum of right-wing patriotic leagues and vigilante corps which, in support or in competition with law enforcement agencies, sought to counter the dual dangers of industrial militancy and revolutionary situations. Although considerable research has been done on the rise of socialist parties and trade unions the repressive policies of their opponents have been generally left unexamined. This book fills this gap by reconstructing the methods and strategies used by state authorities and employers to counter outbreaks of labour militancy on a global scale. It adopts a long-term chronology that sheds light on the shocks and strains that marked industrial societies during their turbulent transition into mass politics from the bitter social conflicts of the pre-war period, through the epochal tremors of war and revolution, and the violent spasms of the 1920s and 1930s. Offering a new angle of vision to examine the violent transition to mass politics in industrial societies, this is of great interest to scholars of policing, unionism and striking in the modern era. Matteo Millan is associate professor of modern and contemporary history at the University of Padova, Italy. -

QUALESTORIA Rivista Di Storia Contemporanea 1
ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA NEL FRIULI VENEZIA GIULIA QUALESTORIA Rivista di storia contemporanea 1 Dopo la Grande guerra Violenza, Stati e società tra Adriatico orientale e Balcani a cura di Alberto Basciani qs Anno XLVIII, N.ro 1, Giugno 2020 EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE «QUALESTORIA» 1 2020 Rivista di storia contemporanea Periodico semestrale Realizzata con il contributo della Direttore scientifico Luca G. Manenti Vicedirettore scientifico Raoul Pupo Direttore responsabile Pierluigi Sabatti Redazione Francesca Bearzatto Comitato scientifico Pamela Ballinger, Giuseppe Battelli, Marco Bellabarba, Gabriele D’Ottavio, Paolo Ferrari, Filippo Focardi, Aleksej Kalc, Georg Meyr, Giorgio Mezzalira, Marco Mondini, Egon Pelikan, Paolo Pezzino, Giovanna Procacci, Silvia Sal- vatici, Marta Verginella, Rolf Wörsdörfer Comitato di redazione Patrizia Audenino, Francesca Bearzatto, Fulvia Benolich, Štefan Čok, Lorenzo Ielen, Patrick Karlsen, Carla Konta, Luca G. Manenti, Gloria Nemec, Raoul Pupo, Federico Tenca Montini, Fabio Todero, Fabio Verardo, Diana Verch, Gianluca Volpi Direzione, redazione e amministrazione Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia Salita di Gretta 38, 34136 Trieste telefono: 040.44004 fax: 0404528784 mail: [email protected] sito: http://www.irsrecfvg.eu/editoria/rivista «Qualestoria» è la rivista dell’Irsrec FVG, fondata nel 1973 come «Bollettino dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia». Ospita contributi di autori italiani e stranieri, promuovendo la pubblicazione di numeri monografici e miscellanei. La rivista propone tradizionalmente tematiche legate alla storia contemporanea dell’area alto-adriatica e delle zone di frontiera, rivolgendo particolare attenzione allo studio e alla storiografia dei paesi dell’Europa centro-orientale e balcanica. -

Zži^Mf1' Kateremu Trst Hrepeni Bolj Kot Kdajkoli'odkar Se S - Edm
INSTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA PRISPEVKI ZAZGODOVINO DE^VSKEGA A LETNIK XVII ' ŠTmLKA1-2 U OBIJANA, TRST 1979 CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF THE WORKER'S MOVEMENT COOBmEHHil HO HCTOPHH PABO^EFO ABH^CEHHa CONTRIBUTIONS A L'HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DER ARBEITERBEWEGUNG CONTRIBUTI PER LA STORIA DEL MOVIMENTO OPERAIO Izdaja — A cura dello Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana Uredniški odbor — Comitato di redazione Dr. Marijan Britovšek, dr. Jasna Fischer, Stane Granda (urednik — redattore), dr. Milica Kacin-Wohinz, dr. France Kresal (glavni in odgovorni urednik — direttore e redattore responsabile), Ivan Križnar, mag. Boris Mlakar, dr. Janko Pleterski, dr. Franc Rozman, dr. Miroslav Stiplovšek, dr. France Skerl, Jera Vodušek-Starič Prevajalka za angleščino — Traduttrice per l'inglese Marija Peklenik . • Zamenjava,— Scambio (OSMCH, Exchanges, Austausch): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja 61000 Ljubljana, Trg osvoboditve 1, SFR Jugoslavija Založili — Editori Partizanska knjiga Ljubljana Založništvo tržaškega tiska — Editoriale štampa triestina Trst — Trieste s sofinanciranjem — con i contributti delle Raziskovalna skupnost Slovenije Kulturna skupnost Slovenije Tiskala — Stampato da Tiskarna »Jože Moškrič«, Ljubljana 1979 V okviru Filozofske fakultete Univerze v Trstu je njen Inštitut za srednje veško in moderno zgodovino s sodelovanjem Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter krožkov Most, P. Tomažič in H. Turna orga niziral 20. in 21. maja 1977 v sejni -
La Grecia, La Guerra Nella Finanza E La Crisi Mondiale
DISTINGUE ILIL NOSTRO PARTITO: lala linealinea dada MarxMarx aa Lenin,Lenin, Anno XXXVII - N. 340 Marzo-Aprile 2010 alla fondazione della III Internazionale, a Livorno 1921, nascita Edizioni ‘Il Partito Comunista’ - Cas.Post. 1157 - 50121 Firenze del Partito Comunista d’Italia, alla lotta della Sinistra Comunista organo del partito C/C P n. 30944508 www.international-communist-party.org Una copia E. 1,00 [email protected] ItalianaItaliana controcontro lala degenerazionedegenerazione didi Mosca,Mosca, alal rifiutorifiuto deidei frontifronti Abbonamento. annuale E. 9,00, sostenitore E. 25,00, estero E. 11,00 popolari e dei blocchi partigiani; la dura opera del restauro della Abb. cumulativo col semestrale "Comunismo" E. 17,00, estero E. 20,00 dottrina e dell’organo rivoluzionario, a contatto con la classe comunista internazionale Sped.abbonamento postale art.2 c.20/c L.662/96 FI - Reg. Tribunale di Firenze n. 2346, 28-5-1974. Direttore responsabile Ezio Baudone, Vice direttore Fabio Bertelli. Proprietà Associazione La Sini- operaia, fuori dal politicantismo personale ed elettoralesco. stra Comunista. Stampato a Scandicci (Fi), Tipografia Emme-A, Via di Casellina 73m, il 3-5-2010. Primo Maggio 2010 tire da zero! La classe operaia ha un suo bagaglio di teoria, una sua completa visione del Dietro crisi e disoccupazione Il capitalismo è ovunque mondo, ed un secolo e mezzo di lezioni da numerose sconfitte e da poche ma si prospetta il superamento grandiose vittorie. Tutto quello che le è solo un nauseante cadavere stato insegnato, dai nemici e dai falsi Per il marxismo la storia è una suc- con la teoria del socialismo in un solo amici, negli ultimi ottanta anni si è di- rivoluzionario del capitalismo cessione di modi di produzione e dei paese, venivano a mascherare sotto le mostrato falsità e menzogna; il marxi- La crisi del capitale è dovuta alla so- danno per i lavoratori disoccupati, rapporti fra gli uomini che essi deter- insegne del comunismo, ideologie, smo autentico invece non ha mai tra- vrapproduzione di merci. -

La Stampa Della Concentrazione D'azione Antifascista (1927-1934): Struttura, Diffusione E Tematiche
« Italia contemporanea », 1981, fase. 144 La stampa della Concentrazione d’azione antifascista (1927-1934): struttura, diffusione e tematiche Il problema della stampa nella esperienza concentrazionista L’esigenza di disporre d’una stampa informata ed efficiente dal punto di vista tecnico, valido e diffuso strumento di propaganda e di orientamento, fu subito avvertita come prioritaria dai dirigenti di quei partiti e di quelle organizzazioni antifasciste che, ricostituitesi in Francia dopo la bufera delle leggi eccezionali, die dero vita nella primavera del 1927 alla Concentrazione d’azione antifascista, alla formula politico-organizzativa, cioè, entro la quale, sia pure con oscillazioni e crisi, si sarebbe in sostanza sviluppata, nel corso dei sette anni successivi, l’attività delle forze più rappresentative dell’opposizione di segno non comunista al regime mus- soliniano *. Infatti, della necessità di una efficace presenza pubblicistica, in dire zione dell’opinione pubblica europea, di quella emigrata e di quella italiana, soffocata dal fascismo, aveva immediatamente parlato lo stesso Luigi Campolonghi — il segretario della Lega italiana dei diritti dell’uomo, fuoruscito a Nérac — quando si era sforzato di rimettere in moto il faticoso meccanismo della trattativa fra i partiti antifascisti 1 2. Una tale esigenza, seppur assai diffusa e concordemente sentita, non impedì, tut tavia, l’immediato manifestarsi di una vivace dialettica all’interno degli ambienti 1 Come è noto la Concentrazione era composta dalla Confederazione generale del lavoro (riformista), dalla Lega italiana per i diritti dell’uomo, dal Partito repubblicano italiano, dal Par tito socialista italiano, dal Partito socialista dei lavoratori italiani. Per una storia generale della Concentrazione si veda il sempre valido aldo garosci, Storia dei fuorusciti, Bari, Laterza, 1953, in specie pp. -

La Parabola Del Socialismo Adriatico
«Qualestoria» n.1, giugno 2020, pp. 169-176 DOI: 10.13137/0393-6082/30741 ISSN 0393-6082 https://www.openstarts.units.it/handle/10077/21200 169 La parabola del socialismo adriatico di Ivan Jeličić La problematica primaria nell’affrontare le vicende del socialismo nell’area alto- adriatica riguarda la definizione terminologica, cronologica e geografica dell’argo- mento. Il termine di riferimento entrato in uso nella storiografia per definire il socia- lismo secondointernazionalista della regione è socialismo adriatico, termine che in realtà delimita tematicamente le articolate realtà del movimento socialdemocratico. Infatti, il socialismo adriatico identifica principalmente, se non esclusivamente, il socialismo di lingua italiana sviluppatosi nell’area costiera della Cisleitania dalla fine dell’Ottocento alla dissoluzione dell’impero austro-ungarico avente come cen- tro metropolitano Trieste. Partendo da questa definizione quale punto di riferimento, cercherò di tratteggiare un quadro, per quanto possibile sintetico, della storiografia relativa al socialismo adriatico, lo stato degli studi e le potenziali piste di ricerca, cercando però di aprire gli orizzonti oltre al socialismo di lingua italiana. L’intento è perciò anche di relazionare il socialismo di lingua italiana con gli altri movimenti so- cialdemocratici formatisi lungo o affacciatisi sulle sponde dell’Adriatico asburgico. Affrontare la tematica del movimento socialista negli anni Novanta del secolo scorso, rispetto ai decenni precedenti, in particolar modo nei paesi dell’ex sociali- smo reale, sembrava essere diventata un’operazione infelice e obsoleta. La fine dei regimi comunisti nell’Europa orientale e la scomparsa o trasformazione dei prin- cipali partiti comunisti europei, invece di aprire nuovi filoni di studio, ha piuttosto segnato un momentaneo e parziale stallo nello studio dell’argomento.