Fenomeni Di Subsidenza Carsica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bibliography of Works of Professor Keiichi Takeuchi
Bibliography of Works of Professor Keiichi Takeuchi This bibliography does not claim to be complete, or exhaustive. Writings appearing in various encyclopedias, weekly magazines and newspapers, and most of the non academic writings have been omitted. In this list, writings which appear, sometimes with some modifications, in the author’s later publications are omitted. The writings are divided into books, articles, and book reviews. For each division, writings are arranged chronologically. The original spelling mistakes are corrected, but the mistakes of phonetic representations of persons’ names, are not corrected. Russian titles are latinized and for writings in Japanese, the Western language titles are in parentheses. Some Japanese periodical titles have official translations into Western languages as follows: Chiikigaku Kenkyu(地域学研究):Regional Views, Institute for Applied Geography at Komazawa University Chirigaku Hyoron( 地理学評論):Geographical Review of Japan. Since Volume 59 (1986), this journal has been divided into Series A (Japanese edition) and Series B (English edition) Chishiken Nenpo(地誌研年報):Annual Report of Research Center for Regional Geography at Hiroshima Univercity Hannan Ronshu Shakai Kagaku hen(阪南論集社会科学編): Journal of Hannan University, Social Science Hitotsubashi Daigaku Kenkyu Nenpo, Jinbunkagaku-kenkyu(一橋大学研究年報・人文科 学研究):Hitotsubashi University Research Series, Humanities Hitotsubashi Daigaku Kenkyu Nenpo, Shakaigaku-kenkyu(一橋大学研究年報・社会学研究): Hitotsubashi University Research Series, Social Studies Hitotsubashi Ronso(一橋論叢):Hitotsubashi -

Paesaggi Di Pietra
Geologia dell’Ambiente Supplemento al n. 3/2020 Periodico trimestrale della SIGEA ISSN 1591-5352 Società Italiana di Geologia Ambientale ATTI DEI CONVEGNI SUI PAESAGGI DI PIETRA PERETO (AQ) 9 AGOSTO 2019 A CURA DI GIUSEPPE GISOTTI OSTUNI (BR) 18 OTTOBRE 2019 A CURA DI EMANUELE GIACCARI EVENTI IN SICILIA Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 - DCB Roma n° 46) art. 1 comma in L. 27/02/2004 (conv. 353/2003 - D.L. Postale - Spedizione in Abbonamento Italiane S.p.a. Poste 2019 A CURA DI MICHELE ORIFICI Società Italiana di Geologia Ambientale Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale riconosciuta dal Ministero dell’ambiente, Sommario della tutela del territorio e del mare con D.M. 24/5/2007 e con successivo D.M. 11/10/2017 PRESIDENTE Antonello Fiore CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE Lorenzo Cadrobbi, Franco D’Anastasio (Segretario), Daria Duranti (Tesoriere), Ilaria Falconi, Antonello Fiore (Presidente), Sara Frumento, Presentazione Fabio Garbin, Enrico Gennari, Giuseppe Gisotti Giuseppe Gisotti, Emanuele Giaccari, Michele Orifici 3 (Presidente onorario), Gioacchino Lena, Luciano Masciocco, Michele Orifici (Vicepresidente), Vincent Ottaviani (Vicepresidente), Paola Pino d’Astore, Livia Soliani PERETO Geologia dell’Ambiente A cura di Giuseppe Gisotti Periodico trimestrale della SIGEA La calce a Pereto (L’Aquila) Supplemento al N. 3/2020 Anno XXVIII • luglio-settembre 2020 Massimo Basilici 9 Iscritto al Registro Nazionale della Stampa n. 06352 Autorizzazione -
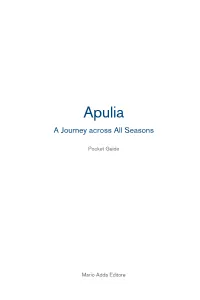
Apulia a Journey Across All Seasons
Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

GEOLOGICAL and GEOMORPHOLOGICAL CONTROLS on FLOOD PHENOMENA in the PUTIGNANO TOWN, SOUTHERN ITALY Paolo Giannandrea 1, Salvatore
Available online http://amq.aiqua.it ISSN (print): 2279-7327, ISSN (online): 2279-7335 Alpine and Mediterranean Quaternary, 31 (2), 2018, 221 - 234 https://doi.org/10.26382/AMQ.2018.17 GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL CONTROLS ON FLOOD PHENOMENA IN THE PUTIGNANO TOWN, SOUTHERN ITALY Paolo Giannandrea 1, Salvatore Laurita 1, Francesca Pugliese 2 1 Dipartimento di Scienze, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, Italy 2 Via Roma, 13, 70017 Putignano (BA), Italy Corresponding author: P. Giannandrea <[email protected]> ABSTRACT: The geological/geomorphological map of Putignano town (Bari, Southern Italy) contains useful evidence of landforms and sedimentary successions in both urbanized and industrial areas, contributing also to a better understanding of floodings dur- ing high-magnitude pluviometric events in the area. The analyzed flooded areas correspond to surfaces karst landforms with differ- ent shapes and sizes. Our detailed geological/geomorphological study shows that most of the industrial area of Putignano was built on Cretaceous calcareous units in a depressed area, which corresponds to an extensive endorheic basin (locally called "il Basso"). Part of the local urban expansion, built from 1950 to present day, occupies the most depressed areas of numerous karst valleys that, despite this urbanization, still preserve their hydraulic function. Usually these geological and geomorphological fea- tures are not yet completely identified and, unfortunately, not taken into consideration in the planning stages of the urban expan- sion and industrial settlement. Keywords: Putignano town, southern Italy, Apulian Foreland, Quaternary, flood, karst 1. INTRODUCTION thropogenic deposits. Putignano is a small town in the south-eastern 2. GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL Murge, an area frequently exposed to alluvial events SETTING OF THE MURGE RELIEF that occur despite the numerous mitigation actions tak- en to reduce or eliminate long-term risk to people and The carbonate rocks of the Murge hills, with the infrastructure. -

La Puglia E Le Culture Neolitiche Il Contesto Ambientale Il Tavoliere Delle Puglie Ed Il Gargano
La Puglia e le culture neolitiche Il contesto ambientale Il Tavoliere delle Puglie ed il Gargano Tavoliere Digital Elevation Model dell’area settentrionale della Puglia L’altopiano delle Murge e la costa adriatica La Murgia Il Salento Penisola Salentina Il sistema idrografico della regione Fiume Fortore Fiume Cervaro Fiume Carapelle Fiume Ofanto Il rilievo altimetrico della regione Digital Elevation Model Il promontorio del Gargano L’appennino Dauno L’altopiano delle Murge Gli effetti del fenomeno carsico in Puglia Stretta gola carsica (Gargano) Tipiche incisioni vallive (Salento) Il Pulo di Altamura Distribuzione delle aree carsiche sul territorio italiano Il Pulicchio di Gravina Grotte, gravi e inghiottitoi: l’idrografia sotterranea Grava di Farauall (Murgia Orientale) • La quasi completa assenza di un reticolo idrografico superficiale ha reso difficile sulla Murgia, fin dal più remoto passato, l’approvvigionamento delle acque a uso domestico e produttivo. La particolare conformazione fisica della Murgia rende, del resto, quasi impossibile la permanenza dell’acqua in superficie. Il carsismo, le infinite fessurazioni della roccia calcarea, trasformano questo territorio in una spugna che assorbe l’acqua piovana immettendola nel sistema di falde sotterranee e lasciandola defluire verso il mare. Nonostante il discreto apporto meteorico (600 mm circa di precipitazione annua), le acque vanno ad alimentare l’idrografia sotterranea. Esistono tuttavia ancora oggi piccole oasi acquatiche la cui rarità le rende di estrema importanza, si tratta di piccoli laghi carsici, più o meno perenni grazie ai depositi di terre alluvionali che riempiono le fessure calcaree dei bacini in cui l’acqua confluisce. Il particolare rapporto che l’uomo ha intrattenuto con questo ambiente fin dall’Olocene, a cominciare dalla conoscenza del sistema idrico, ha permesso la realizzazione di innumerevoli manufatti rurali, grazie ai quali l’acqua diventa risorsa a cui attingere nel momento del bisogno. -

04 Parise.Pdf
Atti del 45° Corso CNSS-SSI di III livello “Geomorfologia Carsica” (a cura di M. Parise, S. Inguscio & A. Marangella) Grottaglie, 2-3 febbraio 2008 ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA CARSICA DELLA PUGLIA MARIO PARISE CNR - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, Bari ([email protected]) Gruppo Puglia Grotte, Castellana-Grotte 1. INTRODUZIONE La Puglia è tra le regioni d’Italia più importanti per i fenomeni carsici, grazie alla presenza di rocce carbonatiche in affioramento su gran parte della propria estensione. Tali rocce si sono depositate nell’ambito del dominio paleogeografico della piattaforma Apula, che nel Mesozoico costituiva uno dei principali corpi carbonatici del bordo meridionale della Tetide. La piattaforma Apula era un promontorio della zolla africana, e risultava compresa tra due zone di mare più profondo (Fig. 1), il Bacino Ionico ad E e quello Lagonegrese-Molisano ad W. L’evoluzione degli studi geologici negli ultimi anni ha portato a rivedere significativamente le ipotesi di ricostruzione paleogeografica di questi territori (BOSELLINI, 2002), con ovvie conseguenze anche per quanto riguarda lo sviluppo del carsismo. Ciò è avvenuto principalmente grazie a recenti scoperte sul territorio pugliese, con ritrovamenti di orme di dinosauri in vari siti, dalle Murge (lungo la strada Santeramo- Altamura, Fig. 2; NICOSIA et alii, 2000) al Gargano, presso Borgo Celano ed a Mattinata. Fig. 1 – Distribuzione delle piattaforme carbonatiche Cretacee nell’area adriatica e ionica (da BOSELLINI, 2002). Gli asterischi indicano i siti di ritrovamento di impronte di dinosauro. Mario Parise Fig. 2 – Pista di impronte di dinosauri all’interno della Cava Pontrelli, presso Altamura. La conformazione geografica della Puglia, sotto forma di lunga e stretta penisola, fa sì che, oltre al carsismo classico, essa rivesta eccezionale valenza anche per quanto riguarda il carsismo costiero. -

2016 Tecniche Di Rilievo Digitale In
TECNICHE DI RILIEVO DIGITALE IN GROTTA. L’ESEMPIO DELLE GROTTE “GRAVE DEL PULO” E “GROTTA MARIO” DEL PULO DI ALTAMURA Teresa Denora, Domenico Capolongo CONDIZIONI DI STABILITà IN UNA PORZIONE DELL’AREA PEDEMONTANA DELL’APPENNINO DAUNO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMUNE DI TROIA (FG) Rosa Pagliarulo, Rosamaria Trizzino LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN PUGLIA: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE Giuseppe Cesario Calò, Donato Lucrezio, Roccaldo Tinelli 1 - 2016 SOMMARIO 2 Editoriale del Presidente dell’ORG - Puglia Salvatore Valletta Direttore editoriale: Valletta Salvatore Direttore responsabile: 3 Alfarano Espedito TECNICHE DI RILIEVO DIGITALE IN GROTTA. Comitato di redazione: L’ESEMPIO DELLE GROTTE “GRAVE DEL PULO” Dibenedetto Michele, Di Fazio Antonio, E “GROTTA MARIO” DEL PULO DI ALTAMURA De Razza Tiziana, Corvasce Maddalena A., Teresa Denora, Domenico Capolongo Bonora Davide, d’Amico Nicola A., D’Amico Vincenzo, Ieva Maria Costantina, Impagnatiello Domenico P., Quarta Giovanni, Valletta Salvatore 13 CONDIZIONI DI STABILITÀ IN UNA PORZIONE Comitato scientifico: DELL’AREA PEDEMONTANA DELL’APPENNINO Antonicelli Antonello, Assennato Giorgio, Baldassarre Giuseppe, Blonda Massimo, DAUNO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO Borri Dino, Capolongo Domenico, AL COMUNE DI TROIA (FG) Cotecchia Federica, Del Gaudio Vincenzo, Rosa Pagliarulo, Rosamaria Trizzino Dellino Pierfrancesco, Di Fazio Antonio, Di Santo Antonio R., Fornelli Annamaria, Gallicchio Salvatore, Leucci Giovanni, Monterisi Luigi, Negri Sergio, Pagliarulo Rosa, 21 Polemio Maurizio, -

Inventario Fondo Antonio Lucarelli
Biblioteca metropolitana “De Gemmis” - Bari FONDO Antonio Lucarelli INVENTARIO 1896 – 1953 a cura di Rosanna D’Angella 2020 L’immagine di copertina è un particolare del ritratto di Antonio Lucarelli, opera di C. Cipriani, di proprietà della Biblioteca Metropolitana “De Gemmis” di Bari e ubicata nella Sala dell’Archivio De Gemmis che ospita anche il Fondo Lucarelli. SOMMARIO Introduzione p. IV Premessa p. V Note biografiche p. V Nota archivistica p. IX Tavola delle abbreviazioni p. XIV Avvertenza alla consultazione dell’inventario p. XIV Inventario p. 1 Serie I. Corrispondenza p. 1 Sottoserie I.1 Corrispondenza di A.L. con diversi (A-Z) p. 1 Sottoserie I.2 Corrispondenza fra terzi p. 21 Serie II. Documentazione bio-bibliografica p. 23 Serie III. Fotografie p. 26 Serie IV. Bozze di opere edite p. 27 Serie V. Appunti, copie e trascrizioni di documenti p. 31 Serie VI. Rassegna stampa, recensioni di opere e articoli di A.L. p. 42 Serie VII. Riviste, giornali e stampati p. 48 Serie VIII. Mappe geografiche, cliché per tipografia e bozzetti p. 55 Indice dei nomi di persona p. 57 Indice dei nomi di luogo p. 60 Indice dei nomi di enti p. 61 Bibliografia p. 62 Introduzione Premessa Premesso che con determina dirigenziale n. 5890 del 23/10/2019 del Servizio beni e attività artistiche e culturali della Città metropolitana di Bari è stato approvato il progetto redatto per la schedatura informatizzata, riordinamento e redazione dell'inventario analitico del fondo archivistico “Antonio Lucarelli” conservato presso la Biblioteca metropolitana “De Gemmis” ed avviata una procedura comparativa di selezione per titoli per il conferimento di un incarico professionale occasionale ad un archivista qualificato; considerando che la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia ha autorizzato la Biblioteca “De Gemmis” a procedere con il progetto stesso, con successiva determina dirigenziale n. -

Sinkhole Genesis and Evolution in Apulia, and Their Interrelations with the Anthropogenic Environment M
Sinkhole genesis and evolution in Apulia, and their interrelations with the anthropogenic environment M. Delle Rose, A. Federico, M. Parise To cite this version: M. Delle Rose, A. Federico, M. Parise. Sinkhole genesis and evolution in Apulia, and their interrelations with the anthropogenic environment. Natural Hazards and Earth System Science, Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union, 2004, 4 (5/6), pp.747- 755. <hal-00301619> HAL Id: hal-00301619 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00301619 Submitted on 18 Nov 2004 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Natural Hazards and Earth System Sciences (2004) 4: 747–755 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2004-4-747 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2004 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Sinkhole genesis and evolution in Apulia, and their interrelations with the anthropogenic environment M. Delle Rose1, A. Federico2, and M. Parise1 1National Research Council, IRPI, Via Amendola 122-I, 70125, Bari, Italy 2Politecnico di Bari, II Facolta` di Ingegneria, V.le del Turismo 8, 74100, Taranto, Italy Received: 6 August 2004 – Revised: 3 November 2004 – Accepted: 9 November 2004 – Published: 18 November 2004 Part of Special Issue “Natural and anthropogenic hazards in karst areas” Abstract. -

Sinkhole Genesis and Evolution in Apulia, and Their Interrelations with the Anthropogenic Environment M
Sinkhole genesis and evolution in Apulia, and their interrelations with the anthropogenic environment M. Delle Rose, A. Federico, M. Parise To cite this version: M. Delle Rose, A. Federico, M. Parise. Sinkhole genesis and evolution in Apulia, and their interrela- tions with the anthropogenic environment. Natural Hazards and Earth System Sciences, Copernicus Publ. / European Geosciences Union, 2004, 4 (5/6), pp.747-755. hal-00301619 HAL Id: hal-00301619 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00301619 Submitted on 18 Nov 2004 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Natural Hazards and Earth System Sciences (2004) 4: 747–755 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2004-4-747 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2004 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Sinkhole genesis and evolution in Apulia, and their interrelations with the anthropogenic environment M. Delle Rose1, A. Federico2, and M. Parise1 1National Research Council, IRPI, Via Amendola 122-I, 70125, Bari, Italy 2Politecnico di Bari, II Facolta` di Ingegneria, V.le del Turismo 8, 74100, Taranto, Italy Received: 6 August 2004 – Revised: 3 November 2004 – Accepted: 9 November 2004 – Published: 18 November 2004 Part of Special Issue “Natural and anthropogenic hazards in karst areas” Abstract. -

Elenco Candidati Esterni A
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi PEC: [email protected] - PEO: [email protected] ELENCO CANDIDATI ESTERNI A . S. 2020/2021 AGGIORNATO AL 10/02/2021 13:17 DATA CAP COGNOME NOME DENOMINAZIONE SCUOLA CITTA' SCUOLA INDIRIZZO DI SCUOLA NASCITA SCUOLA ADDARI Saulo 06/04/1984 IISS Basile Caramia Gigante Locorotondo 70010 Via Cisternino 284 ALHASSANE HAMIDOU Abdoulaye 21/08/1998 IISS Don Tonino Bello Molfetta 70056 Viale XXV Aprile ALTAMURA Anna 10/05/1974 IISS Ilaria Alpi Rutigliano 70018 Via Conversano Km 0,500 ALTOMARE Antonio 29/03/1998 IISS Ferraris Molfetta 70056 Via Togliatti 4 ALVISI Eleonora Fortuna 13/03/2003 LS Cafiero Barletta 76121 Via Dante Alighieri 1 AMADOU Bah 14/01/1998 IISS Cosmai Bisceglie 70100 Via Gandhi 1 AMODIO Michele 29/08/2001 IT Nervi Galilei Altamura 70022 Viale Padre Pio AMOIA Luigi 18/12/1981 IISS Don Tonino Bello Molfetta 70056 Viale XXV Aprile ANGELILLO Angela 25/12/1994 IISS Sette Santeramo 70029 Via Pietro Sette 3 ANNOSCIA Antonella 24/02/1994 IPSSEOA Perotti Bari 70100 Via Niceforo 8 ANTENORE Massimiliano 29/01/1985 IT Euclide Caracciolo Bari 70126 Via Prezzolini ARMENISE Nicola 10/06/1986 IPSSEOA Perotti Bari 70132 Via Niceforo 8 AYROLDI Raffaella 11/11/1995 IISS Don Tonino Bello Molfetta 70056 Viale XXV Aprile BARGAGNI Giulia 03/11/1996 IISS De Nora Altamura 70022 Via Lago Passarello 3 BARILE Vincenzo 12/08/1990 IISS Lotti Andria 76123 Via Cinzio Violante 1 BARNABA' Adele 27/01/2001 IPSSEOA Perotti Bari 70100 Via Niceforo 8 BASILE Angelo Demi 15/01/1983 IISS Consoli Pinto Castellana Grotte 70013 Via Rosatella 7 BATTISTA Angelo 26/05/1980 IISS Da Vinci Majoprana Mola di Bari 70042 Viale Aldo Moro 1/17 BATTISTA Marianna 19/08/1982 ITGC Salvemini Molfetta 70056 Via Ten. -

0 Introduzione
Studio Particolareggiato dell’Agro di Molfetta Piano di settore delle aree rurali 0 1 Introduzione Relazione Studio Particolareggiato dell’Agro di Molfetta Piano di settore delle aree rurali 0.1 Premessa Lo Studio Particolareggiato dell’Agro è la sintesi progettuale dello spazio rurale agricolo e fondiario-non agricolo appartenente comunque all’ambiente rurale. Tale strumento non rientra tra i piani particolareggiati o piani esecutivi di cui alle vigenti disposizioni di legge, non potendo interessare solo una parte della zona produttiva agricola ovvero assumere funzione di raccordo tra il P.R.G.C. e la realizzazione materiale degli interventi in esso previsti. I piani particolareggiati definiscono, in quanto strumenti esecutivi la “forma” urbana, la struttura che una porzione più o meno grande di città o di territorio dovrà assumere, indicando in modo dettagliato la rete delle mobilità, le aree destinate ai servizi pubblici, i lotti edificabili, la previsione di massima delle opere di infrastrutturazione del suolo e del sottosuolo, le aree soggette a esproprio. Lo Studio Particolareggiato dell’Agro invece mette in 12 luce – definendole e normalizzandole – le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio rurale e quindi fornisce indirizzi, prescrizioni e proposizioni volte a garantire lo sviluppo di attività agricole/produttive sostenibili. Nell’ultimo ventennio l’Unione Europea ha inteso rilanciare la funzione del territorio rurale come spazio di interazione tra varie attività (agricoltura, artigianato, turismo, commercio, servizi), soggetti economici afferenti al tessuto produttivo e componenti sociali del territorio. In quest’ottica, le aree rurali identificano territori che risultano costituiti sia da spazi agricoli, destinati alla coltivazione e all’allevamento, sia da spazi fondiari non agricoli, destinati ad usi diversi dall’agricoltura ed in particolare all’insediamento residenziale e alle molteplici attività degli abitanti dell’ambiente rurale 1.