04 Parise.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fenomeni Di Subsidenza Carsica
PROBLEMATICHE CONNESSE A FENOMENI DI SUBSIDENZA CARSICA E SINKHOLES IN PUGLIA DELLE ROSE MARCO*, FEDERICO ANTONIO** & PARISE MARIO* *CNR-IRPI, sezione di Bari **II Facoltà di Ingegneria (Taranto) - Politecnico di Bari INTRODUZIONE La regione Puglia presenta distinti contesti geologici con differenti condizioni di propen- sione al dissesto idrogeologico e di vulnerabilità ambientale. Tra queste, data la natura prevalentemente carbonatica delle rocce affioranti, i fenomeni di subsidenza carsica e di sprofondamento (sinkholes) hanno un ruolo notevole. Negli ultimi decenni sono stati, infatti, registrati numerosi eventi, alcuni dei quali hanno arrecato danni a strutture antropiche presenti sul territorio. Il presente contributo intende esaminare, dopo una introduzione agli aspetti generali del carsismo del territorio pugliese, le principali pro- blematiche relative a questo tipo di fenomeni sulla base di alcuni casi di studio. 1. ASSETTO GEOLOGICO E FENOMENI DI SINKHOLES I territori carsici sono caratterizzati da peculiari aspetti geologici, morfologici e idrogeo- logici, che li rendono particolarmente inclini allo sviluppo di fenomeni di subsidenza e di sinkholes (NICOD, 1972; WHITE, 1988). La solubilità delle rocce carbonatiche, e il conse- guente sviluppo ed evoluzione di processi carsici e speleogenetici (FORD, 1988) si combi- nano in tali ambienti all’azione antropica, di frequente producendo situazioni di rischio. Fig. 1 - Schema geologico della Puglia, con indicazione dei casi citati nel testo. Legenda: 1) depo- siti alluvionali, argille e calcareniti (Pliocene – Pleistocene); 2) rocce carbonatiche bioclastiche (Paleogene) e calcareniti (Miocene); 3) rocce di piattaforma carbonatica (Cretaceo). 377 La Regione Puglia è prevalentemente caratterizzata dall’affioramento di rocce carbona- tiche, per cui i processi carsici risultano di estrema rilevanza praticamente sull’intero territorio. -

Paesaggi Di Pietra
Geologia dell’Ambiente Supplemento al n. 3/2020 Periodico trimestrale della SIGEA ISSN 1591-5352 Società Italiana di Geologia Ambientale ATTI DEI CONVEGNI SUI PAESAGGI DI PIETRA PERETO (AQ) 9 AGOSTO 2019 A CURA DI GIUSEPPE GISOTTI OSTUNI (BR) 18 OTTOBRE 2019 A CURA DI EMANUELE GIACCARI EVENTI IN SICILIA Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 - DCB Roma n° 46) art. 1 comma in L. 27/02/2004 (conv. 353/2003 - D.L. Postale - Spedizione in Abbonamento Italiane S.p.a. Poste 2019 A CURA DI MICHELE ORIFICI Società Italiana di Geologia Ambientale Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale riconosciuta dal Ministero dell’ambiente, Sommario della tutela del territorio e del mare con D.M. 24/5/2007 e con successivo D.M. 11/10/2017 PRESIDENTE Antonello Fiore CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE Lorenzo Cadrobbi, Franco D’Anastasio (Segretario), Daria Duranti (Tesoriere), Ilaria Falconi, Antonello Fiore (Presidente), Sara Frumento, Presentazione Fabio Garbin, Enrico Gennari, Giuseppe Gisotti Giuseppe Gisotti, Emanuele Giaccari, Michele Orifici 3 (Presidente onorario), Gioacchino Lena, Luciano Masciocco, Michele Orifici (Vicepresidente), Vincent Ottaviani (Vicepresidente), Paola Pino d’Astore, Livia Soliani PERETO Geologia dell’Ambiente A cura di Giuseppe Gisotti Periodico trimestrale della SIGEA La calce a Pereto (L’Aquila) Supplemento al N. 3/2020 Anno XXVIII • luglio-settembre 2020 Massimo Basilici 9 Iscritto al Registro Nazionale della Stampa n. 06352 Autorizzazione -

Materiale Divulgativo
Castel Garagnone Lama Viola e Graviglione AGRO 4 05 Maggio 2013 9 03 Novembre 2013 ECO da Azienda Ventura - Masseria Sacromonte - Spinazzola da Azienda Scalera - Masseria Lamia di Giacomo - Altamura SISTEMI dalla qualità dell’ambiente alla qualità delle produzioni I LUOGHI Emergenze ambientali: DEL PARCO Prodotti agroalimentari: Emergenze ambientali: Dodici escursioni tra i luoghi più belli e significativi Prodotti agroalimentari: del PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA AGRISTUDIO S.r.l. AGRICOLTURA GEOLOGIA AMBIENTE escursioni Necropoli Coppa di Sotto Pulicchio di Gravina Pulicchio di Toritto 1 10 Febbraio 2013 5 12 Maggio 2013 10 08 Dicembre 2013 da Azienda Caputi - Masseria Coppa di Sopra - Ruvo di Puglia da Azienda Cifarelli - Gravina in Puglia da Azienda Viti De Angelis - Casino De Angelis - Altamura Il tragitto risulta semplice da un punto di vista dell’orientamento seguendo escursionistico parte dall’azienda Cifarelli in agro di Gravina in Il percorso parte da Masseria Viti, in territorio di Altamura, uno dei comples- sempre tratturi e muretti a secco ben definiti. Luoghi di interesse sono -
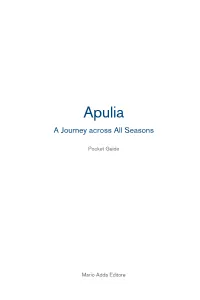
Apulia a Journey Across All Seasons
Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

GEOLOGICAL and GEOMORPHOLOGICAL CONTROLS on FLOOD PHENOMENA in the PUTIGNANO TOWN, SOUTHERN ITALY Paolo Giannandrea 1, Salvatore
Available online http://amq.aiqua.it ISSN (print): 2279-7327, ISSN (online): 2279-7335 Alpine and Mediterranean Quaternary, 31 (2), 2018, 221 - 234 https://doi.org/10.26382/AMQ.2018.17 GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL CONTROLS ON FLOOD PHENOMENA IN THE PUTIGNANO TOWN, SOUTHERN ITALY Paolo Giannandrea 1, Salvatore Laurita 1, Francesca Pugliese 2 1 Dipartimento di Scienze, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, Italy 2 Via Roma, 13, 70017 Putignano (BA), Italy Corresponding author: P. Giannandrea <[email protected]> ABSTRACT: The geological/geomorphological map of Putignano town (Bari, Southern Italy) contains useful evidence of landforms and sedimentary successions in both urbanized and industrial areas, contributing also to a better understanding of floodings dur- ing high-magnitude pluviometric events in the area. The analyzed flooded areas correspond to surfaces karst landforms with differ- ent shapes and sizes. Our detailed geological/geomorphological study shows that most of the industrial area of Putignano was built on Cretaceous calcareous units in a depressed area, which corresponds to an extensive endorheic basin (locally called "il Basso"). Part of the local urban expansion, built from 1950 to present day, occupies the most depressed areas of numerous karst valleys that, despite this urbanization, still preserve their hydraulic function. Usually these geological and geomorphological fea- tures are not yet completely identified and, unfortunately, not taken into consideration in the planning stages of the urban expan- sion and industrial settlement. Keywords: Putignano town, southern Italy, Apulian Foreland, Quaternary, flood, karst 1. INTRODUCTION thropogenic deposits. Putignano is a small town in the south-eastern 2. GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL Murge, an area frequently exposed to alluvial events SETTING OF THE MURGE RELIEF that occur despite the numerous mitigation actions tak- en to reduce or eliminate long-term risk to people and The carbonate rocks of the Murge hills, with the infrastructure. -

Piano Di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (Pai)
Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino della Puglia PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) RELAZIONE DI PIANO DICEMBRE 2004 Autorità di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico Capitolo I Il Piano di Bacino come Strumento di Pianificazione Territoriale....................................................... 1 I.1 Il Piano di Bacino ...................................................................................................................................... 1 I.2 La Pianificazione Stralcio nell’Ambito del Piano di Bacino ..................................................................... 3 I.3 Gli Obiettivi e le Finalità del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ....................................... 4 I.4 Quadro Normativo di Riferimento............................................................................................................. 6 I.5 Lo Stato della Pianificazione Territoriale e della Pianificazione Urbanistica............................................ 8 Capitolo II Il Quadro Conoscitivo Generale del Territorio dell’Autorità di Bacino della Puglia......................... 9 II.1 Premessa.................................................................................................................................................... 9 II.2 I Caratteri Morfologici............................................................................................................................. 10 II.3 I -

La Puglia E Le Culture Neolitiche Il Contesto Ambientale Il Tavoliere Delle Puglie Ed Il Gargano
La Puglia e le culture neolitiche Il contesto ambientale Il Tavoliere delle Puglie ed il Gargano Tavoliere Digital Elevation Model dell’area settentrionale della Puglia L’altopiano delle Murge e la costa adriatica La Murgia Il Salento Penisola Salentina Il sistema idrografico della regione Fiume Fortore Fiume Cervaro Fiume Carapelle Fiume Ofanto Il rilievo altimetrico della regione Digital Elevation Model Il promontorio del Gargano L’appennino Dauno L’altopiano delle Murge Gli effetti del fenomeno carsico in Puglia Stretta gola carsica (Gargano) Tipiche incisioni vallive (Salento) Il Pulo di Altamura Distribuzione delle aree carsiche sul territorio italiano Il Pulicchio di Gravina Grotte, gravi e inghiottitoi: l’idrografia sotterranea Grava di Farauall (Murgia Orientale) • La quasi completa assenza di un reticolo idrografico superficiale ha reso difficile sulla Murgia, fin dal più remoto passato, l’approvvigionamento delle acque a uso domestico e produttivo. La particolare conformazione fisica della Murgia rende, del resto, quasi impossibile la permanenza dell’acqua in superficie. Il carsismo, le infinite fessurazioni della roccia calcarea, trasformano questo territorio in una spugna che assorbe l’acqua piovana immettendola nel sistema di falde sotterranee e lasciandola defluire verso il mare. Nonostante il discreto apporto meteorico (600 mm circa di precipitazione annua), le acque vanno ad alimentare l’idrografia sotterranea. Esistono tuttavia ancora oggi piccole oasi acquatiche la cui rarità le rende di estrema importanza, si tratta di piccoli laghi carsici, più o meno perenni grazie ai depositi di terre alluvionali che riempiono le fessure calcaree dei bacini in cui l’acqua confluisce. Il particolare rapporto che l’uomo ha intrattenuto con questo ambiente fin dall’Olocene, a cominciare dalla conoscenza del sistema idrico, ha permesso la realizzazione di innumerevoli manufatti rurali, grazie ai quali l’acqua diventa risorsa a cui attingere nel momento del bisogno. -

2016 Tecniche Di Rilievo Digitale In
TECNICHE DI RILIEVO DIGITALE IN GROTTA. L’ESEMPIO DELLE GROTTE “GRAVE DEL PULO” E “GROTTA MARIO” DEL PULO DI ALTAMURA Teresa Denora, Domenico Capolongo CONDIZIONI DI STABILITà IN UNA PORZIONE DELL’AREA PEDEMONTANA DELL’APPENNINO DAUNO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMUNE DI TROIA (FG) Rosa Pagliarulo, Rosamaria Trizzino LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN PUGLIA: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE Giuseppe Cesario Calò, Donato Lucrezio, Roccaldo Tinelli 1 - 2016 SOMMARIO 2 Editoriale del Presidente dell’ORG - Puglia Salvatore Valletta Direttore editoriale: Valletta Salvatore Direttore responsabile: 3 Alfarano Espedito TECNICHE DI RILIEVO DIGITALE IN GROTTA. Comitato di redazione: L’ESEMPIO DELLE GROTTE “GRAVE DEL PULO” Dibenedetto Michele, Di Fazio Antonio, E “GROTTA MARIO” DEL PULO DI ALTAMURA De Razza Tiziana, Corvasce Maddalena A., Teresa Denora, Domenico Capolongo Bonora Davide, d’Amico Nicola A., D’Amico Vincenzo, Ieva Maria Costantina, Impagnatiello Domenico P., Quarta Giovanni, Valletta Salvatore 13 CONDIZIONI DI STABILITÀ IN UNA PORZIONE Comitato scientifico: DELL’AREA PEDEMONTANA DELL’APPENNINO Antonicelli Antonello, Assennato Giorgio, Baldassarre Giuseppe, Blonda Massimo, DAUNO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO Borri Dino, Capolongo Domenico, AL COMUNE DI TROIA (FG) Cotecchia Federica, Del Gaudio Vincenzo, Rosa Pagliarulo, Rosamaria Trizzino Dellino Pierfrancesco, Di Fazio Antonio, Di Santo Antonio R., Fornelli Annamaria, Gallicchio Salvatore, Leucci Giovanni, Monterisi Luigi, Negri Sergio, Pagliarulo Rosa, 21 Polemio Maurizio, -

Sinkhole Genesis and Evolution in Apulia, and Their Interrelations with the Anthropogenic Environment M
Sinkhole genesis and evolution in Apulia, and their interrelations with the anthropogenic environment M. Delle Rose, A. Federico, M. Parise To cite this version: M. Delle Rose, A. Federico, M. Parise. Sinkhole genesis and evolution in Apulia, and their interrelations with the anthropogenic environment. Natural Hazards and Earth System Science, Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union, 2004, 4 (5/6), pp.747- 755. <hal-00301619> HAL Id: hal-00301619 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00301619 Submitted on 18 Nov 2004 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. Natural Hazards and Earth System Sciences (2004) 4: 747–755 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2004-4-747 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2004 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Sinkhole genesis and evolution in Apulia, and their interrelations with the anthropogenic environment M. Delle Rose1, A. Federico2, and M. Parise1 1National Research Council, IRPI, Via Amendola 122-I, 70125, Bari, Italy 2Politecnico di Bari, II Facolta` di Ingegneria, V.le del Turismo 8, 74100, Taranto, Italy Received: 6 August 2004 – Revised: 3 November 2004 – Accepted: 9 November 2004 – Published: 18 November 2004 Part of Special Issue “Natural and anthropogenic hazards in karst areas” Abstract. -

Sinkhole Genesis and Evolution in Apulia, and Their Interrelations with the Anthropogenic Environment M
Sinkhole genesis and evolution in Apulia, and their interrelations with the anthropogenic environment M. Delle Rose, A. Federico, M. Parise To cite this version: M. Delle Rose, A. Federico, M. Parise. Sinkhole genesis and evolution in Apulia, and their interrela- tions with the anthropogenic environment. Natural Hazards and Earth System Sciences, Copernicus Publ. / European Geosciences Union, 2004, 4 (5/6), pp.747-755. hal-00301619 HAL Id: hal-00301619 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00301619 Submitted on 18 Nov 2004 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Natural Hazards and Earth System Sciences (2004) 4: 747–755 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2004-4-747 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2004 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Sinkhole genesis and evolution in Apulia, and their interrelations with the anthropogenic environment M. Delle Rose1, A. Federico2, and M. Parise1 1National Research Council, IRPI, Via Amendola 122-I, 70125, Bari, Italy 2Politecnico di Bari, II Facolta` di Ingegneria, V.le del Turismo 8, 74100, Taranto, Italy Received: 6 August 2004 – Revised: 3 November 2004 – Accepted: 9 November 2004 – Published: 18 November 2004 Part of Special Issue “Natural and anthropogenic hazards in karst areas” Abstract. -
Application Form Section A
APPLICATION FORM COOPERATION PROGRAMME: (Interreg V-A) EL-IT - Greece-Italy APPLICATION FORM DATE OF SUBMISSION: DATE OF APPROVAL: VERSION OF APPLICATION FORM: 2. 0 AMENDMENT OF APPLICATION FORM TIMETABLE BUDGET DELIVERABLES OTHER X X X Brief Description: SECTION A: PROJECT IDENTIFICATION PROJECT TITLE: Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach MIS IDENTIFICATION CODE: 5003444 PROJECT ACRONYM: P.A.T.H Project duration Start: 01/12/2017 End: 30/05/2020 Total Months: 29,97 CALL FOR PROPOSALS TITLE: 1st CALL FOR ORDINARY PROJECT PROPOSALS - PA 2: Integrated Environmental Management Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 Co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) CALL FOR PROPOSALS CODE: I1.2 COOPERATION PROGRAMME INFORMATION PROGRAMME PERIOD: 2014 - 2020 CP CODE: 23 Priority Axis 2 - Integrated Environmental Management Fund ERDF Thematic Objectives / - Priorities 06-Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency - Investment Priority 6c-Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage - Specific Objective SO2.1-Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme Area - 1007-Not applicable Categories of Intervention 24-Other unspecified services 7079-Access to public sector information (including open data, e-Culture, digital libraries, e-Content and e-Tourism) 907-Not applicable Brief Summary of the Project (Suggested to be filled in upon completion of the Application Form) P.A.T.H is based on the vision of touristic routes of different kinds (cultural, environmental, rural, etc), which in the recent years has been consolidated so as to reflect the evolution of the concept of such heritage and its projection in society. -

Il Patrimonio Geologico in Puglia: Dall’Indifferenza Alla Valorizzazione
2/2009 Periodico della SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale ISSN 1591-5352 oma Atti del Convegno Geositi Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. 46) art. 1 comma - DCB R Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in il patrimonio geologico tra conservazione e fruizione Il patrimonio geologico in Puglia: dall’indifferenza alla valorizzazione. Iniziativa legislativa della Regione Puglia ANTONIO FI ORE VI NCENZO IURILLI PI ETRO BLU GI ANDONATO GI USEPPE MASTRONUZZI ORONZO SI MONE LUI SA SABATO DONATO SOLLI TTO SALVATORE VALLETTA GRUPPO LAVORO GEOSITI SI GEA PUGLIA GRUPPO LAVORO GEOSITI SI GEA PUGLIA DI PARTI MENTO DI GEOLOGI A E GEOFI SI CA, UNIVERSITÀ DI BARI [email protected] [email protected] [email protected] 1. PREMESSA azioni atte a favorire e rendere possibili la Un altro caso-limite è rappresentato dal a recente approvazione da parte fruizione e la valorizzazione. Basti citare il sito di Punta delle Pietre Nere, che è stato della Giunta Regionale della Puglia caso dei cosiddetti “puli” (esempio di geo- quasi del tutto smantellato per far posto ad di un disegno di legge sulla “Tute- siti di interesse nazionale) o della cava dei opere antropiche di basso valore sociale Lla e valorizzazione del patrimonio dinosauri nei pressi di Altamura (esempio di ed economico, ma di alto impatto paesag- geologico e speleologico”, già licenziata fa- geosito di interesse internazionale), o anco- gistico. vorevolmente dalla Commissione