Le Acque Sotterranee E L'intrusione Marina in Puglia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Prefettura Di Bari Ufficio Territoriale Del Governo Ordine E Sicurezza Pubblica – Area I
Prefettura di Bari Ufficio territoriale del Governo Ordine e Sicurezza Pubblica – Area I PIANO PROVINCIALE PER LA RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARSE 1 Prefettura di Bari Ufficio territoriale del Governo Ordine e Sicurezza Pubblica – Area I Indice ELENCO DI DISTRIBUZIONE Pag. 3/4 • PREMESSA Pag. 5 • FINALITA’ Pag. 5 • SCENARIO TERRITORIALE Pag. 6/12 • TIPOLOGIE DI SCOMPARSA Pag. 12 • SOGGETTI COINVOLTI Pag. 13 • FASI OPERATIVE Pag.14 a) allarme scomparsa e fase informativa Pag.15 b) attivazione del piano di ricerca Pag. 15/18 c) pianificazione dell’intervento Pag. 18 d) gestione dell'intervento Pag. 19 e) sospensione o chiusura delle ricerche Pag. 20 f) rapporto finale Pag. 20 • RAPPORTI CON I FAMILIARI DEGLI SCOMPARSI Pag.21 • RAPPORTI CON I FAMILIARI DGELI SCOMPARSI Pag.21 Allegati: all. 1 Numeri utili all. 2 Motivazione della scomparsa all. 3 Questionario Alzheimer All.4 Questionario ricezione segnalazione All. 5 Comunicazione istituzione punto di coordinamento All. 6 Comunicazione di fine ricerca 2 Prefettura di Bari Ufficio territoriale del Governo Ordine e Sicurezza Pubblica – Area I ELENCO DI DISTRIBUZIONE REGIONE PUGLIA Protezione Civile Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Servizio Protezione Civile QUESTURA COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA COMPARTIMENTO DI POLIZIA FERROVIARIA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO CAPITANERIA DI PORTO CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO BARI DIREZIONE CENTRALE OPERATIVA SOVRAPROVINCIALE 118 BARI - BAT COMITATO PROVINCIALE CROCE ROSSA ITALIANA AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI COMUNI PROVINCIA LORO SEDI ASSOCIAZIONE “PENELOPE” ASSOCIAZIONE “PSICOLOGI PER I POPOLI” Destinatari per conoscenza COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE R O M A PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per la Protezione Civile R O M A MINISTERO DELL’INTERNO Gabinetto del Ministro Dipartimento della P.S. -

Fenomeni Di Subsidenza Carsica
PROBLEMATICHE CONNESSE A FENOMENI DI SUBSIDENZA CARSICA E SINKHOLES IN PUGLIA DELLE ROSE MARCO*, FEDERICO ANTONIO** & PARISE MARIO* *CNR-IRPI, sezione di Bari **II Facoltà di Ingegneria (Taranto) - Politecnico di Bari INTRODUZIONE La regione Puglia presenta distinti contesti geologici con differenti condizioni di propen- sione al dissesto idrogeologico e di vulnerabilità ambientale. Tra queste, data la natura prevalentemente carbonatica delle rocce affioranti, i fenomeni di subsidenza carsica e di sprofondamento (sinkholes) hanno un ruolo notevole. Negli ultimi decenni sono stati, infatti, registrati numerosi eventi, alcuni dei quali hanno arrecato danni a strutture antropiche presenti sul territorio. Il presente contributo intende esaminare, dopo una introduzione agli aspetti generali del carsismo del territorio pugliese, le principali pro- blematiche relative a questo tipo di fenomeni sulla base di alcuni casi di studio. 1. ASSETTO GEOLOGICO E FENOMENI DI SINKHOLES I territori carsici sono caratterizzati da peculiari aspetti geologici, morfologici e idrogeo- logici, che li rendono particolarmente inclini allo sviluppo di fenomeni di subsidenza e di sinkholes (NICOD, 1972; WHITE, 1988). La solubilità delle rocce carbonatiche, e il conse- guente sviluppo ed evoluzione di processi carsici e speleogenetici (FORD, 1988) si combi- nano in tali ambienti all’azione antropica, di frequente producendo situazioni di rischio. Fig. 1 - Schema geologico della Puglia, con indicazione dei casi citati nel testo. Legenda: 1) depo- siti alluvionali, argille e calcareniti (Pliocene – Pleistocene); 2) rocce carbonatiche bioclastiche (Paleogene) e calcareniti (Miocene); 3) rocce di piattaforma carbonatica (Cretaceo). 377 La Regione Puglia è prevalentemente caratterizzata dall’affioramento di rocce carbona- tiche, per cui i processi carsici risultano di estrema rilevanza praticamente sull’intero territorio. -

Did Adria Rotate Relative to Africa?
Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Solid Earth Discuss., 6, 937–983, 2014 Open Access www.solid-earth-discuss.net/6/937/2014/ Solid Earth doi:10.5194/sed-6-937-2014 Discussions © Author(s) 2014. CC Attribution 3.0 License. This discussion paper is/has been under review for the journal Solid Earth (SE). Please refer to the corresponding final paper in SE if available. Did Adria rotate relative to Africa? D. J. J. van Hinsbergen1, M. Mensink1, C. G. Langereis1, M. Maffione1, L. Spalluto2, M. Tropeano2, and L. Sabato2 1Department of Earth Sciences, Utrecht University, Budapestlaan 4, 3584 CD Utrecht, the Netherlands 2Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, Universitá degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Via E. Orabona 4, 70125, Bari, Italy Received: 17 March 2014 – Accepted: 18 March 2014 – Published: 28 March 2014 Correspondence to: D. J. J. van Hinsbergen ([email protected]) Published by Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union. 937 Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Abstract The first and foremost boundary condition for kinematic reconstructions of the Mediter- ranean region is the relative motion between Africa and Eurasia, constrained through reconstructions of the Atlantic Ocean. The Adria continental block is in a downgoing 5 plate position relative to the strongly curved Central Mediterranean subduction-related orogens, and forms the foreland of the Apennines, Alps, Dinarides, and Albanides- Hellenides. It is connected to the African plate through the Ionian Basin, likely with lower Mesozoic oceanic lithosphere. If the relative motion of Adria vs. Africa is known, its po- sition relative to Eurasia can be constrained through the plate circuit, and hard bound- 10 ary conditions for the reconstruction of the complex kinematic history of the Mediter- ranean are obtained. -

Studio Idrogeologico Tufarelle – Prof. Pagliarulo
Università degli Studi di Bari Dipartimento di Geologia e Geofisica Studio idrogeologico della contrada Tufarelle (Canosa di Puglia – Minervino Murge) Bari, 10 maggio 2010 1 Studio idreogeologico della contrada Tufarelle (Canosa di Puglia - Minervino Murge) ©2010 - Pietro Pagliarulo ©2010 - Bleu Srl Editore Lanciano - TUTTI I DIRITTI RISERVATI I edizione: ottobre 2010 ISBN 978-88-905418-0-3 Studio idreogeologico della contrada Tufarelle (Canosa di Puglia - Minervino Murge) INDICE 1. La contrada Tufarelle 8 2. Inquadramento geologico e idrogeologico 10 3. Il sottosuolo di contrada Tufarelle 20 4. Direzione di flusso delle acque sotterranee 24 5. Composizione geochimica delle acque di falda 31 6. Il sistema di monitoraggio della falda idrica in contrada Tufarelle 43 7. Considerazioni conclusive 49 - Appendice – Valori dei parametri per la caratterizzazione del 57 sottosuolo in contrada Tufarelle - Bibliografia 62 Il presente lavoro di ricerca è stato realizzato nell’ambito di una convenzione tra il Dipartimento di Geologia e Geofisica dell’Università di Bari e la Bleu S.r.l. di Lanciano (CH), stipulata in data 3 marzo 2008. Il responsabile scientifico della Convenzione Prof. Pietro Pagliarulo Il direttore del Dipartimento Prof. Giuseppe Baldassarre Bari, 10 maggio 2010 Dipartimento di Geologia e Geofisica, Università degli Studi di Bari Bleu S.r.l. Lanciano (CH) 3 Studio idreogeologico della contrada Tufarelle (Canosa di Puglia - Minervino Murge) Dipartimento di Geologia e Geofisica, Università degli Studi di Bari Bleu S.r.l. Lanciano (CH) 4 Studio idreogeologico della contrada Tufarelle (Canosa di Puglia - Minervino Murge) Elenco delle figure: 1. Il bordo delle Murge verso la piana del Fiume Ofanto 2. -

Paesaggi Di Pietra
Geologia dell’Ambiente Supplemento al n. 3/2020 Periodico trimestrale della SIGEA ISSN 1591-5352 Società Italiana di Geologia Ambientale ATTI DEI CONVEGNI SUI PAESAGGI DI PIETRA PERETO (AQ) 9 AGOSTO 2019 A CURA DI GIUSEPPE GISOTTI OSTUNI (BR) 18 OTTOBRE 2019 A CURA DI EMANUELE GIACCARI EVENTI IN SICILIA Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 - DCB Roma n° 46) art. 1 comma in L. 27/02/2004 (conv. 353/2003 - D.L. Postale - Spedizione in Abbonamento Italiane S.p.a. Poste 2019 A CURA DI MICHELE ORIFICI Società Italiana di Geologia Ambientale Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale riconosciuta dal Ministero dell’ambiente, Sommario della tutela del territorio e del mare con D.M. 24/5/2007 e con successivo D.M. 11/10/2017 PRESIDENTE Antonello Fiore CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE Lorenzo Cadrobbi, Franco D’Anastasio (Segretario), Daria Duranti (Tesoriere), Ilaria Falconi, Antonello Fiore (Presidente), Sara Frumento, Presentazione Fabio Garbin, Enrico Gennari, Giuseppe Gisotti Giuseppe Gisotti, Emanuele Giaccari, Michele Orifici 3 (Presidente onorario), Gioacchino Lena, Luciano Masciocco, Michele Orifici (Vicepresidente), Vincent Ottaviani (Vicepresidente), Paola Pino d’Astore, Livia Soliani PERETO Geologia dell’Ambiente A cura di Giuseppe Gisotti Periodico trimestrale della SIGEA La calce a Pereto (L’Aquila) Supplemento al N. 3/2020 Anno XXVIII • luglio-settembre 2020 Massimo Basilici 9 Iscritto al Registro Nazionale della Stampa n. 06352 Autorizzazione -

Senato Della Repubblica X Legislatura
SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. 2549 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori PETRARA, NEBBIA, TORNATI, CORLEO. NE, VOLPONI, DIPAOLA, LOPS, BUSSETI, ANDREINI, IANNONE, SCARDAONI, NESPOLO, CARDINALE, MONTINARO, TRIPODI, PUTIGNANO, CASADEl LUCCnI e POLLICE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1990 Istituzione del Parco nazionale dell' Alta Murgia ONOREVOLISENATORI.~ L'area interessata de i residui di una vegetazione boschiva al Parco dell' Alta Murgia è la parte più spontanea (11 mila ettari); la porzione più interna dell'Altopiano delle Murge di nord~ consistente di territorio è costituita da ovest della provincia di Bari. pascoli nudi e arborati (60 mila ettari); le Si tratta di un sistema collinare in forma attività agricole sono tradizionalmente limi~ di quadrilatero allungato che corre paralle- tate alle sacche di terra rossa adagiate negli lamente alla costa adriatica con una lar- avvallamenti e nelle lame dove prevalenti ghezza pressochè costante (circa 20 chilo~ sono le colture cerealicole (19 mila ettari). metri) e i cui confini con il Tavoliere La presenza storica dell'uomo è forte~ dauno, l'Appennino lucano e le Murge di mente documentata dalla straordinaria tes~ sud-est sono naturalmente segnati, rispetti~ situra di architetture e manufatti legati alla vamente dalla Valle dell'Ofanto, dalla Fossa viabilità, alla pastorizia, all'agricoltura, alla Premurgiana e dall'insellatura di Gioia del raccolta delle acque. Colle. Amministrativamente, l'area interessa L'area da destinare a parco è evidenziata parzialmente gli agri di dieci comuni della nella cartografia allegata. Detta area si provincia di Bari e precisamente quelli di estende per circa 90 mila ettari e compren~ Poggiorsini, Gravina, Altamura, Carata, Ru~ TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Tutela dell'ambiente) Atti parlamentari ~ 2 ~ Senato della Repubblica ~ 2549 X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI va, Spinazzola, Minervino Murge, Andria, ne e grotte riccamente adornate da colorate Bitonto e Toritto. -

“Accoglienza: CUP-Hospitality”
0093196|18/10/2019 |ASL_FG|N_10021|I - Azienda Sanitaria Locale FG Provincia di Foggia Direzione Strategica Via M. Protano s.n.c Foggia Partita IVA e C.F. 03499370710 Tel. 0881884609 Fax 0881884614 AZIENDA SANITARIA LOCALE FG Foggia Progetto “Accoglienza: CUP-Hospitality” Definizione di un nuovo modello di gestione dei servizi di front office attraverso un sistema coordinato di reception e accoglienza Vito Piazzolla Comuni ASL FG: Foggia - Cerignola - Manfredoni - San Severo - Lucera - San Giovanni Rotondo - Orta Nova – Torremaggiore - San Nicandro – Direttore Generale Garganico - San Marco in Lamis – Vieste – Apricena - Monte Sant'Angelo - Vico del Gargano - Troia - Cagnano Varano - CarapelleMattinata – Lesina - Ascoli Satriano - San Paolo di Civitate – Stornara – Stornarella – Ischitella – Carpino – Peschici – Serracapriola - Delicato - Rodi Garganico – Bovino – Zapponata – Biccari - Orsara di Puglia - Poggio Imperiale – Pietramontecorvino – Ordina – Candela – Accadia - Rignano Garganico - Castelluccio dei Sauri - Sant'Agata di Puglia - Casalvecchio di Puglia - Rocchetta - Sant'Antonio – Volturino – Chiesti - Celenza Valfortore - Casalnuovo Monterotaro - Anzano di Puglia - Castelnuovo della Daunia - Castelluccio Valmaggiore - Roseto Valfortore - San Marco la Catola - Monteleone di Puglia - Carlantino - Alberona - Panni - Motta - Montecorvino - Faeto - Volturara Appula - Isole Tremiti - Celle di San Vito Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, -

Vino-Rosso-Pugliese.Pdf
Vini Rossi Pugliesi Ebook - www.vinook.it Aleatico di Puglia In questa pagina parleremo di : La Puglia vinicola I vitigni rossi L'Aleatico di Puglia DOC rosso Le aziende La Puglia vinicola L'Aleatico è prodotto in tutta la regione Puglia, che è divisa in otto subregioni geograficamente differenti, con due zone montuose, il Gargano e l'Appennino Dauno, con i loro 1000 metri circa di altitudine; il Tavoliere delle Puglie, la piu grande pianura italiana dopo quella Padana; la zona collinare di origine calcarea delle Murge con caratteristiche carsiche; il Salento con zone collinari e pianeggianti alternate, la Terra di Bari, caratterizzata dal dolci e basse colline e terreni pianeggianti; la Valle dell'Itria, l'Arco Ionico in provincia di Taranto e infine le isole. La regione è a prevalenza calcarea e dolomitica, formata dall'emersione delle terre dalle profondità marine. È da qui che si formò il ricco strato sedimentario di calcare, con presenza di microrganismi fossili che caratterizza il suolo pugliese. Questo lungo processo prevede la formazione di tufo e calcare tenero, che arricchisce gli elementi nutritivi della vite. La regione è divisa esattamente tra zone pianeggianti e zone collinari dolci, mentre le montagne rappresentano meno del 2% del territorio, ubicate al confine con la Campania. Il clima è mediterraneo, con estati lunghe e secche, che concentrano gli elementi presenti nelle uve. Gli inverni sono miti e brevi. I vitigni rossi 2 www.vinook.it I vitigni rossi coltivati per questa denominazione sono l'Aleatico, il Negro Amaro, La Malvasia Nera e il Primitivo. L'Aleatico è conosciuto anche con il nome di Leatico o Agliano ed è una varietà italiana particolare caratterizzata da un forte aroma di Muscat. -

Francesco Violante Organizzazione Del Territorio E Strutture Produttive Tra XI E XVI Secolo
Francesco Violante Organizzazione del territorio e strutture produttive tra XI e XVI secolo [A stampa in Storia di Manfredonia, dir. S. Russo, I, Il Medioevo, a cura di R. Licinio, Edipuglia, Bari 2008, pp. 101-123 © dell’autore e dell’editore - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, www.biblioteca.retimedievali.it]. ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E STRUTTURE PRODUTTIVE TRA XI E XVI SECOLO di Francesco Violante Siponto-Manfredonia: il territorio Nella vicenda storica della città di Siponto e, in seguito, di Manfredonia, un ruolo peculiare e originale svolgono le caratteristiche geo-morfologiche, litologiche e idro- logiche del territorio e le loro dinamiche. Siponto sorgeva infatti sul mare, nell’ansa formata dalla costa pugliese a sud del Gargano, in un territorio costituito in preva- lenza, dal punto di vista geologico e litologico, da calcari di piattaforma risalenti al Cretacico alternati ad argille e calcareniti pleistoceniche e plioceniche e a detriti di falda e depositi alluvionali databili all’Olocene e continuamente accresciuti, in epoca storica, dal corso dei fiumi Candelaro, Cervaro, Carapelle e affluenti minori, attualmente so- pravviventi in forma torrentizia 1. L’evoluzione delle forme insediative e del paesaggio agrario sono state strettamente legate a questa conformazione geofisica. Il progressivo impaludamento dell’insenatura che ospitava Siponto nel corso del XIII secolo, processo definitivamente concluso alla fine del XVI secolo, è dovuto infatti all’azione dei depo- siti alluvionali di corsi d’acqua dotati di una portata maggiore rispetto all’attuale, fe- nomeno probabilmente causato da condizioni climatiche generalmente più calde, mentre il paesaggio agrario si strutturava nelle forme dello sfruttamento cerealicolo- pastorale nelle zone argillose pedemontane e della piana del Tavoliere 2. -
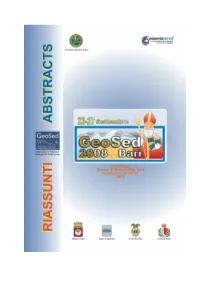
Abstract (Pdf)
2 Congresso GeoSed 25-26 Settembre 2008 Aula Magna Palazzo di Scienze della Terra Campus Universitario Via E. Orabona 4 BARI Atti del Congresso a cura di: Massimo Moretti ORGANIZZAZIONE Coordinamento Luisa Sabato Segreteria Luigi Spalluto Comitato organizzatore Salvatore Gallicchio Massimo Moretti Luisa Sabato Luigi Spalluto Marcello Tropeano Collaboratori Alessia Barchetta Elisa Costantini Antonietta Cilumbriello Antonio Grippa Michele Labriola Rosanna Laragione Stefania Lisco Vincenzo Onofrio Mariangela Pepe Patrocinio e Contributo Università degli Studi di Bari Dipartimento di Geologia e Geofisica Dottorato di Scienze della Terra Regione Puglia Regione Basilicata Provincia di Bari Comune di Bari Commissione Italiana “Anno Internazionale del Pianeta Terra” 4 INDICE DEL VOLUME G. Aiello, A. Conforti, B. D’Argenio Regional marine geologic cartography of the Naples Bay (scale 1:10.000): the geological map n. 465 “Procida” pag. 1 G. Aiello, E. Marsella, S. Passaro The continental slopes off the Ischia island (Naples Bay): submarine gravity instability processes investigated by means of marine geological and geophysical data pag. 4 M. Aldinucci, I. Martini, F. Sandrelli The Pliocene deposits of the northern Siena Basin (Tuscany, Italy) revised through unconformity-bounded stratigraphic units pag. 6 A. Alfarano, M. Delle Rose, L. Orlanducci, F. Resta Rapporti stratigrafici tra pietra leccese, piromafo e Calcareniti di Andrano (area urbana e periferia est di Lecce) pag. 8 S. Andreucci, V. Pascucci, M. D. Bateman Record of three peaks during the Marine Isotopic Stage MIS5 along the Alghero coast, NW Sardinia, Italy: Sea level implication pag. 10 A. Barchetta, L. Spalluto Stratigrafia e caratteri di facies delle successioni carbonatiche affioranti nell’area compresa tra Binetto e Grumo Appula (Murge baresi, Puglia) pag. -

Materiale Divulgativo
Castel Garagnone Lama Viola e Graviglione AGRO 4 05 Maggio 2013 9 03 Novembre 2013 ECO da Azienda Ventura - Masseria Sacromonte - Spinazzola da Azienda Scalera - Masseria Lamia di Giacomo - Altamura SISTEMI dalla qualità dell’ambiente alla qualità delle produzioni I LUOGHI Emergenze ambientali: DEL PARCO Prodotti agroalimentari: Emergenze ambientali: Dodici escursioni tra i luoghi più belli e significativi Prodotti agroalimentari: del PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA AGRISTUDIO S.r.l. AGRICOLTURA GEOLOGIA AMBIENTE escursioni Necropoli Coppa di Sotto Pulicchio di Gravina Pulicchio di Toritto 1 10 Febbraio 2013 5 12 Maggio 2013 10 08 Dicembre 2013 da Azienda Caputi - Masseria Coppa di Sopra - Ruvo di Puglia da Azienda Cifarelli - Gravina in Puglia da Azienda Viti De Angelis - Casino De Angelis - Altamura Il tragitto risulta semplice da un punto di vista dell’orientamento seguendo escursionistico parte dall’azienda Cifarelli in agro di Gravina in Il percorso parte da Masseria Viti, in territorio di Altamura, uno dei comples- sempre tratturi e muretti a secco ben definiti. Luoghi di interesse sono -

The Paleozoic Record of Thaumatoporella PIA, 1927?
Geologia Croatica 66/3 155–182 12 Figs. 3 Tabs. 8 Pls. Zagreb 2013 Palaeozoic record of Thaumatoporella PIA, 1927 (incertae sedis)? Felix Schlagintweit1, Jindrich Hladil2, Martin Nose3 and Carlo Salerno4 1 Lerchenauerstr. 167, 80935 München, Germany; ([email protected]) 2 Institute of Geology ASCR, v. v. i., Rozvojová 269, 16500 Praha, Czech Republic; ([email protected]) 3 SNSB-Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, GeoBioCenterLMU, Richard-Wagner-Str. 10, 80333 München, Germany; ([email protected]) 4 Lenzhalde 70, 70192 Stuttgart, Germany; ([email protected]) doi: 10.4154/gc.2013.14 GeologiaGeologia CroaticaCroatica AB STRA CT From Palaeozoic (mainly Devonian) shallow-water carbonates, spherical to irregular shaped microfossils with thin, apparently homogeneous or perforate micritic walls are widely reported. They are classically referred either to uniloc- ular parathuramminid foraminifera, algae incertae sedis or calcispheres (e.g., Bisphaera, Cribrosphaeroides, Uslo nia, Vermiporella myna, Irregularina). Due to their morphology and microstructural features, they are interpreted here as possibly belonging to Thaumatoporella PIA, a widespread Mesozoic-Early Cenozoic taxon of incertae sedis showing a remarkably high morphological variability. In analogy to Mesozoic thaumatoporellaceans, Bisphaera ma levkensis BIRINA is interpreted as the cyst (i.e.= resting) stage of forms ascribed to different genera, i.e., Cribro sphaeroides, Uslonia and Vermiporella (here: Vermiporella myna WRAY). Note that in the Mesozoic many taxa were also synonymized with Thaumatoporella: Polygonella ELLIOTT, Lithoporella elliotti (EMBERGER), Messopota mella DRAGASTAN et al., Vermiporella crisiae DRAGASTAN et al., Micritosphaera SCOTT. This new interpretation, based on material from the Devonian of W-Germany and the Czech Republic, leads to taxonomic reassessment as Thaumatoporella? malevkensis (BIRINA) nov.