Vinca Apr2016
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Prefettura Di Bari Ufficio Territoriale Del Governo Ordine E Sicurezza Pubblica – Area I
Prefettura di Bari Ufficio territoriale del Governo Ordine e Sicurezza Pubblica – Area I PIANO PROVINCIALE PER LA RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARSE 1 Prefettura di Bari Ufficio territoriale del Governo Ordine e Sicurezza Pubblica – Area I Indice ELENCO DI DISTRIBUZIONE Pag. 3/4 • PREMESSA Pag. 5 • FINALITA’ Pag. 5 • SCENARIO TERRITORIALE Pag. 6/12 • TIPOLOGIE DI SCOMPARSA Pag. 12 • SOGGETTI COINVOLTI Pag. 13 • FASI OPERATIVE Pag.14 a) allarme scomparsa e fase informativa Pag.15 b) attivazione del piano di ricerca Pag. 15/18 c) pianificazione dell’intervento Pag. 18 d) gestione dell'intervento Pag. 19 e) sospensione o chiusura delle ricerche Pag. 20 f) rapporto finale Pag. 20 • RAPPORTI CON I FAMILIARI DEGLI SCOMPARSI Pag.21 • RAPPORTI CON I FAMILIARI DGELI SCOMPARSI Pag.21 Allegati: all. 1 Numeri utili all. 2 Motivazione della scomparsa all. 3 Questionario Alzheimer All.4 Questionario ricezione segnalazione All. 5 Comunicazione istituzione punto di coordinamento All. 6 Comunicazione di fine ricerca 2 Prefettura di Bari Ufficio territoriale del Governo Ordine e Sicurezza Pubblica – Area I ELENCO DI DISTRIBUZIONE REGIONE PUGLIA Protezione Civile Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Servizio Protezione Civile QUESTURA COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA COMPARTIMENTO DI POLIZIA FERROVIARIA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO CAPITANERIA DI PORTO CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO BARI DIREZIONE CENTRALE OPERATIVA SOVRAPROVINCIALE 118 BARI - BAT COMITATO PROVINCIALE CROCE ROSSA ITALIANA AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI COMUNI PROVINCIA LORO SEDI ASSOCIAZIONE “PENELOPE” ASSOCIAZIONE “PSICOLOGI PER I POPOLI” Destinatari per conoscenza COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE R O M A PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per la Protezione Civile R O M A MINISTERO DELL’INTERNO Gabinetto del Ministro Dipartimento della P.S. -

Fenomeni Di Subsidenza Carsica
PROBLEMATICHE CONNESSE A FENOMENI DI SUBSIDENZA CARSICA E SINKHOLES IN PUGLIA DELLE ROSE MARCO*, FEDERICO ANTONIO** & PARISE MARIO* *CNR-IRPI, sezione di Bari **II Facoltà di Ingegneria (Taranto) - Politecnico di Bari INTRODUZIONE La regione Puglia presenta distinti contesti geologici con differenti condizioni di propen- sione al dissesto idrogeologico e di vulnerabilità ambientale. Tra queste, data la natura prevalentemente carbonatica delle rocce affioranti, i fenomeni di subsidenza carsica e di sprofondamento (sinkholes) hanno un ruolo notevole. Negli ultimi decenni sono stati, infatti, registrati numerosi eventi, alcuni dei quali hanno arrecato danni a strutture antropiche presenti sul territorio. Il presente contributo intende esaminare, dopo una introduzione agli aspetti generali del carsismo del territorio pugliese, le principali pro- blematiche relative a questo tipo di fenomeni sulla base di alcuni casi di studio. 1. ASSETTO GEOLOGICO E FENOMENI DI SINKHOLES I territori carsici sono caratterizzati da peculiari aspetti geologici, morfologici e idrogeo- logici, che li rendono particolarmente inclini allo sviluppo di fenomeni di subsidenza e di sinkholes (NICOD, 1972; WHITE, 1988). La solubilità delle rocce carbonatiche, e il conse- guente sviluppo ed evoluzione di processi carsici e speleogenetici (FORD, 1988) si combi- nano in tali ambienti all’azione antropica, di frequente producendo situazioni di rischio. Fig. 1 - Schema geologico della Puglia, con indicazione dei casi citati nel testo. Legenda: 1) depo- siti alluvionali, argille e calcareniti (Pliocene – Pleistocene); 2) rocce carbonatiche bioclastiche (Paleogene) e calcareniti (Miocene); 3) rocce di piattaforma carbonatica (Cretaceo). 377 La Regione Puglia è prevalentemente caratterizzata dall’affioramento di rocce carbona- tiche, per cui i processi carsici risultano di estrema rilevanza praticamente sull’intero territorio. -

Studio Idrogeologico Tufarelle – Prof. Pagliarulo
Università degli Studi di Bari Dipartimento di Geologia e Geofisica Studio idrogeologico della contrada Tufarelle (Canosa di Puglia – Minervino Murge) Bari, 10 maggio 2010 1 Studio idreogeologico della contrada Tufarelle (Canosa di Puglia - Minervino Murge) ©2010 - Pietro Pagliarulo ©2010 - Bleu Srl Editore Lanciano - TUTTI I DIRITTI RISERVATI I edizione: ottobre 2010 ISBN 978-88-905418-0-3 Studio idreogeologico della contrada Tufarelle (Canosa di Puglia - Minervino Murge) INDICE 1. La contrada Tufarelle 8 2. Inquadramento geologico e idrogeologico 10 3. Il sottosuolo di contrada Tufarelle 20 4. Direzione di flusso delle acque sotterranee 24 5. Composizione geochimica delle acque di falda 31 6. Il sistema di monitoraggio della falda idrica in contrada Tufarelle 43 7. Considerazioni conclusive 49 - Appendice – Valori dei parametri per la caratterizzazione del 57 sottosuolo in contrada Tufarelle - Bibliografia 62 Il presente lavoro di ricerca è stato realizzato nell’ambito di una convenzione tra il Dipartimento di Geologia e Geofisica dell’Università di Bari e la Bleu S.r.l. di Lanciano (CH), stipulata in data 3 marzo 2008. Il responsabile scientifico della Convenzione Prof. Pietro Pagliarulo Il direttore del Dipartimento Prof. Giuseppe Baldassarre Bari, 10 maggio 2010 Dipartimento di Geologia e Geofisica, Università degli Studi di Bari Bleu S.r.l. Lanciano (CH) 3 Studio idreogeologico della contrada Tufarelle (Canosa di Puglia - Minervino Murge) Dipartimento di Geologia e Geofisica, Università degli Studi di Bari Bleu S.r.l. Lanciano (CH) 4 Studio idreogeologico della contrada Tufarelle (Canosa di Puglia - Minervino Murge) Elenco delle figure: 1. Il bordo delle Murge verso la piana del Fiume Ofanto 2. -

Paesaggi Di Pietra
Geologia dell’Ambiente Supplemento al n. 3/2020 Periodico trimestrale della SIGEA ISSN 1591-5352 Società Italiana di Geologia Ambientale ATTI DEI CONVEGNI SUI PAESAGGI DI PIETRA PERETO (AQ) 9 AGOSTO 2019 A CURA DI GIUSEPPE GISOTTI OSTUNI (BR) 18 OTTOBRE 2019 A CURA DI EMANUELE GIACCARI EVENTI IN SICILIA Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 - DCB Roma n° 46) art. 1 comma in L. 27/02/2004 (conv. 353/2003 - D.L. Postale - Spedizione in Abbonamento Italiane S.p.a. Poste 2019 A CURA DI MICHELE ORIFICI Società Italiana di Geologia Ambientale Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale riconosciuta dal Ministero dell’ambiente, Sommario della tutela del territorio e del mare con D.M. 24/5/2007 e con successivo D.M. 11/10/2017 PRESIDENTE Antonello Fiore CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE Lorenzo Cadrobbi, Franco D’Anastasio (Segretario), Daria Duranti (Tesoriere), Ilaria Falconi, Antonello Fiore (Presidente), Sara Frumento, Presentazione Fabio Garbin, Enrico Gennari, Giuseppe Gisotti Giuseppe Gisotti, Emanuele Giaccari, Michele Orifici 3 (Presidente onorario), Gioacchino Lena, Luciano Masciocco, Michele Orifici (Vicepresidente), Vincent Ottaviani (Vicepresidente), Paola Pino d’Astore, Livia Soliani PERETO Geologia dell’Ambiente A cura di Giuseppe Gisotti Periodico trimestrale della SIGEA La calce a Pereto (L’Aquila) Supplemento al N. 3/2020 Anno XXVIII • luglio-settembre 2020 Massimo Basilici 9 Iscritto al Registro Nazionale della Stampa n. 06352 Autorizzazione -

Senato Della Repubblica X Legislatura
SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA N. 2549 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori PETRARA, NEBBIA, TORNATI, CORLEO. NE, VOLPONI, DIPAOLA, LOPS, BUSSETI, ANDREINI, IANNONE, SCARDAONI, NESPOLO, CARDINALE, MONTINARO, TRIPODI, PUTIGNANO, CASADEl LUCCnI e POLLICE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1990 Istituzione del Parco nazionale dell' Alta Murgia ONOREVOLISENATORI.~ L'area interessata de i residui di una vegetazione boschiva al Parco dell' Alta Murgia è la parte più spontanea (11 mila ettari); la porzione più interna dell'Altopiano delle Murge di nord~ consistente di territorio è costituita da ovest della provincia di Bari. pascoli nudi e arborati (60 mila ettari); le Si tratta di un sistema collinare in forma attività agricole sono tradizionalmente limi~ di quadrilatero allungato che corre paralle- tate alle sacche di terra rossa adagiate negli lamente alla costa adriatica con una lar- avvallamenti e nelle lame dove prevalenti ghezza pressochè costante (circa 20 chilo~ sono le colture cerealicole (19 mila ettari). metri) e i cui confini con il Tavoliere La presenza storica dell'uomo è forte~ dauno, l'Appennino lucano e le Murge di mente documentata dalla straordinaria tes~ sud-est sono naturalmente segnati, rispetti~ situra di architetture e manufatti legati alla vamente dalla Valle dell'Ofanto, dalla Fossa viabilità, alla pastorizia, all'agricoltura, alla Premurgiana e dall'insellatura di Gioia del raccolta delle acque. Colle. Amministrativamente, l'area interessa L'area da destinare a parco è evidenziata parzialmente gli agri di dieci comuni della nella cartografia allegata. Detta area si provincia di Bari e precisamente quelli di estende per circa 90 mila ettari e compren~ Poggiorsini, Gravina, Altamura, Carata, Ru~ TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Tutela dell'ambiente) Atti parlamentari ~ 2 ~ Senato della Repubblica ~ 2549 X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI va, Spinazzola, Minervino Murge, Andria, ne e grotte riccamente adornate da colorate Bitonto e Toritto. -

Materiale Divulgativo
Castel Garagnone Lama Viola e Graviglione AGRO 4 05 Maggio 2013 9 03 Novembre 2013 ECO da Azienda Ventura - Masseria Sacromonte - Spinazzola da Azienda Scalera - Masseria Lamia di Giacomo - Altamura SISTEMI dalla qualità dell’ambiente alla qualità delle produzioni I LUOGHI Emergenze ambientali: DEL PARCO Prodotti agroalimentari: Emergenze ambientali: Dodici escursioni tra i luoghi più belli e significativi Prodotti agroalimentari: del PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA AGRISTUDIO S.r.l. AGRICOLTURA GEOLOGIA AMBIENTE escursioni Necropoli Coppa di Sotto Pulicchio di Gravina Pulicchio di Toritto 1 10 Febbraio 2013 5 12 Maggio 2013 10 08 Dicembre 2013 da Azienda Caputi - Masseria Coppa di Sopra - Ruvo di Puglia da Azienda Cifarelli - Gravina in Puglia da Azienda Viti De Angelis - Casino De Angelis - Altamura Il tragitto risulta semplice da un punto di vista dell’orientamento seguendo escursionistico parte dall’azienda Cifarelli in agro di Gravina in Il percorso parte da Masseria Viti, in territorio di Altamura, uno dei comples- sempre tratturi e muretti a secco ben definiti. Luoghi di interesse sono -

Guida a DOG Scopri Cosa Fare Con Il Cane Nei Dintorni Di Monopoli
Guida A DOG Scopri cosa fare con il cane nei dintorni di Monopoli 5 Idee di Viaggio A DOG nei dintorni di Monopoli Itinerario con il cane in Puglia - il più grande acquedotto d’europa Puglia - Cultura Dista 13 km Se cercate un itinerario con il cane in Puglia vi consigliamo una meta diversa dalle solite, un percorso che si snoda lungo la via dell’acquedotto pugliese, il più grande acquedotto d’Europa. Qui vi si apre lo scenario adatto per lunghe passeggiate con il cane sospesi sull’acqua ed immersi in campi coltivati, tratturi, boschi di querce e lecci, masserie e trulli. Occhio sempre alla sicurezza, cercate di incamminarvi con il cane al guinzaglio. In auto si raggiunge Putignano e da qui si seguono le indicazioni per Alberobello e dopo alcuni chilometri si può lasciare l’automobile per camminare a piedi con il cane per circa 2 chilometri sospesi sull’acqua, si attraversa la strada che collega Castellana Grotte ad Alberobello quindi si attraversa un tratturo che porta ad una masseria e si giunge sulla strada che da Alberobello porta alla Coreggia. Seguendo sempre le insegne Eaap (Ente autonomo acquedotto pugliese) ci si immerge nella natura per arrivare infine al pontecanale di 20 metri davanti ad un panorama mozzafiato. Fasano - Spiagge organizzate per i cani in Puglia Puglia - Città Dista 13 km Se avete voglia di rilassanti giornate al sole, le spiagge organizzate per i cani in Puglia sono diverse: vicino Alberobello avete Fasano con la sua Santos Bau beach, una vera spiaggia animal friendly, premiata nel 2011 come “esempio di funzionalità nel settore” dal Ministro del Turismo. -

Le Alluvioni Nel Settore Adriatico Delle Murge (Terra Di Bari): Cause Geologiche E Ruolo Dell’Azione Antropica
GEOLOGI e TERRITORIO ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI - PUGLIA n° 3/2005 pagg. 11-22 LE ALLUVIONI NEL SETTORE ADRIATICO DELLE MURGE (TERRA DI BARI): CAUSE GEOLOGICHE E RUOLO DELL’AZIONE ANTROPICA Massimo Moretti Iscritto n° 121/ES ORG–Puglia Dipartimento di Geologia e Geofisica Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valutazione e Mitigazione del Rischio Sismico e Vulcanico Università degli Studi di Bari RIASSUNTO - In questo lavoro viene discusso il ruolo dell’azione antropica nell’amplificazione del rischio di alluvione nell’area urbana di Bari. In que- st’area convergono le acque di numerosi corsi d’acqua a carattere torrentizio che, nella notte fra il 22 ed il 23 ottobre 2005, hanno determinato un forte evento allu- vionale (con vittime e numerosi danni materiali). Il grande bacino idrografico sotteso dall’area urbana del capoluogo pugliese è situato sul bordo adriatico delle Murge e comprende un settore più elevato (Murge alte) ed un settore costiero poco elevato (Murge basse). L’a- nalisi dell’ultimo evento alluvionale e di quelli del pas- sato ed il quadro geologico ed idrologico di riferimento indicano che l’area urbana di Bari ha una naturale pre- disposizione ad essere soggetta a forti eventi alluvio- nali. L’impatto antropico determina un aumento delle acque di ruscellamento superficiale ed è rappresentato principalmente dalla progressiva impermeabilizza- zione del suolo nelle aree urbane (localizzate soprat- tutto nelle Murge basse) e ad operazioni di “migliora- mento fondiario” nelle aree rurali (che caratterizzano le Murge alte). In conclusione vengono proposte alcune soluzioni a breve e medio termine al fine di ridurre il rischio alluvione nell’area di interesse sottolineando l’importanza dello studio dell’ambiente fisico in tutte le fasi di pianificazione territoriale. -
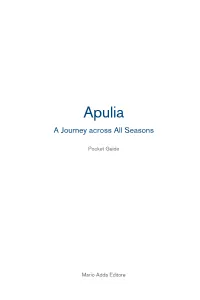
Apulia a Journey Across All Seasons
Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

Preistoria E Protostoria Della Basilicata Prehistory And
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA LV RIUNIONE SCIENTIFICA Preistoria e Protostoria della Basilicata MATERA, 15-19 APRILE 2020 55TH SCIENTIFIC CONFERENCE Prehistory and Protohistory of Basilicata MATERA, 15-19 APRIL 2020 ORGANIZZATA DA IN COLLABORAZIONE CON Logo: Protome antropomorfa dal villaggio neolitico di Rendina (Melfi) PROGRAMMA COMUNICAZIONI E POSTER Sede della Riunione Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata Palazzo Lanfranchi - Sala Carlo Levi Piazza G. Pascoli, 1 Matera Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola Via Ridola, 24 Matera Comitato d’onore SALVATORE ADDUCE, VITO BARDI, SALVATORE BUONOMO, FRANCESCO CANESTRINI, RAFFAELLO DE RUGGIERI, ANTONIO DE SIENA, RENATA GRIFONI CREMONESI, MICHELE LAMACCHIA, ELENA LATTANZI, MARTA RAGOZZINO Comitato Scientifico CLARISSA BELARDELLI, MARCO BETTELLI, SALVATORE BIANCO, MARIA BERNABÒ BREA, MIRELLA CIPOLLONI SAMPÒ, ALESSANDRO GUIDI, JEAN GUILAINE, MARCO PACCIARELLI, MARCELLO PIPERNO, GIOVANNA RADI, ROXANE ROCCA Comitato Organizzativo LUCIA ANGELI, MARTA BARBATO, MARCO BETTELLI, SAVINO GALLO, SABRINA MUTINO, ANNAMARIA PATRONE Segreteria organizzativa LUCIA ANGELI, CLARISSA BELARDELLI, MARCO BETTELLI email: [email protected] con il patrocinio di Comune di Matera Regione Basilicata Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano Fondazione Matera 2019 con il finanziamento di Comune di Matera Scuola Francese di Roma Italcementi, Heildelbergcement Group - Cementeria di Matera PROGRAMMA mercoledì 15 aprile 15.00 Registrazione 15.30 -

GEOLOGICAL and GEOMORPHOLOGICAL CONTROLS on FLOOD PHENOMENA in the PUTIGNANO TOWN, SOUTHERN ITALY Paolo Giannandrea 1, Salvatore
Available online http://amq.aiqua.it ISSN (print): 2279-7327, ISSN (online): 2279-7335 Alpine and Mediterranean Quaternary, 31 (2), 2018, 221 - 234 https://doi.org/10.26382/AMQ.2018.17 GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL CONTROLS ON FLOOD PHENOMENA IN THE PUTIGNANO TOWN, SOUTHERN ITALY Paolo Giannandrea 1, Salvatore Laurita 1, Francesca Pugliese 2 1 Dipartimento di Scienze, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, Italy 2 Via Roma, 13, 70017 Putignano (BA), Italy Corresponding author: P. Giannandrea <[email protected]> ABSTRACT: The geological/geomorphological map of Putignano town (Bari, Southern Italy) contains useful evidence of landforms and sedimentary successions in both urbanized and industrial areas, contributing also to a better understanding of floodings dur- ing high-magnitude pluviometric events in the area. The analyzed flooded areas correspond to surfaces karst landforms with differ- ent shapes and sizes. Our detailed geological/geomorphological study shows that most of the industrial area of Putignano was built on Cretaceous calcareous units in a depressed area, which corresponds to an extensive endorheic basin (locally called "il Basso"). Part of the local urban expansion, built from 1950 to present day, occupies the most depressed areas of numerous karst valleys that, despite this urbanization, still preserve their hydraulic function. Usually these geological and geomorphological fea- tures are not yet completely identified and, unfortunately, not taken into consideration in the planning stages of the urban expan- sion and industrial settlement. Keywords: Putignano town, southern Italy, Apulian Foreland, Quaternary, flood, karst 1. INTRODUCTION thropogenic deposits. Putignano is a small town in the south-eastern 2. GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL Murge, an area frequently exposed to alluvial events SETTING OF THE MURGE RELIEF that occur despite the numerous mitigation actions tak- en to reduce or eliminate long-term risk to people and The carbonate rocks of the Murge hills, with the infrastructure. -

Magna Grecia, Murgia E Gravine Poggiorsini
ITA /ENG MAGNA GRECIA, MURGIA E GRAVINE Poggiorsini 1 Santeramo in Colle 2 TaranTo Grottaglie Ginosa 24h TaranTo p. 6 1 Ippovie e buona cucina Bridleways and good food p. 9 2 Canyon di Puglia Canyon of Puglia p. 17 MAGNA GRECIA, MURGIA E GRAVINE Qui la pietra è protagonista assoluta. Crepacci profondi, montagne al contrario, grotte naturali, terrazze a mezz’aria e pareti scoscese. Vi sembrerà di stare in un canyon americano e invece vi trovate nell’Alta Murgia barese e nelle Gravine tarantine. Si affaccia su un burrone Gravina in Puglia ed è sede del Par- co Nazionale dell’Alta Murgia. Tra le tante chiese rupestri, non perdete quella di San Michele. Altamura è famosa per il pane a marchio Dop unico in Europa; per le oltre trecento- mila Orme di Dinosauri nella cava Pontrelli e per “l’Uomo di Altamura”, uno scheletro collocabile tra il tipo Neanderthal e Herectus. In sella a un cavallo murgese percorrete il primo tratto dell’Ippovia dei Trulli e della Murgia inaugurato nel 2011 e arrivate a Cassano delle Murge, attraversando la Fo- resta di Mercadante. Se siete ghiotti di mozzarelle e burra- te fate tappa a Gioia del Colle, mentre Santeramo in Colle è il regno della carne equina e dei “fornelli pronti” o rosticce- rie annesse alle macellerie. Più a sud nel Parco delle Gravi- ne, che circonda il golfo di Taranto, Laterza è il canyon più grande d’Europa lungo 12 chilometri e nota per la tradizio- ne del pane; Mottola merita una visita per la cripta di San Nicola con il grande affresco del Giudizio Universale; men- tre a Massafra fate il tour delle chiese rupestri del X-XI seco- lo.