Venuto Al Mondo Di Margaret Mazzantini: Dal Testo Al Paratesto, E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tuttolibri Che Legge Agassi Del Carcere Delle Langhe
Pagina Fisica: INSERTI - NAZIONALE - 1 - 10/12/11 - Pag. Logica: INSERTI/PAGINE [TTL01] - Autore: ANTGIR - Ora di stampa: 08/12/11 13.08 1 Oggi COMODINO VIDEOINTERVISTA MEMORIA Luca Argentero Fabio Geda Cesare Pavese la iena torinese sui maestri l’americano tuttoLIBRI che legge Agassi del carcere delle Langhe iPad Edition Con le recensioni e le classifiche dei bestseller NUMERO 1795 ANNO XXXV SABATO 10 DICEMBRE 2011 LA STAMPA A cura di: BRUNO VENTAVOLI con BRUNO QUARANTA Grafica: MARINA CARPINI tuttoLIBRI [email protected] www.lastampa.it/tuttolibri/ STEFANIA BERTOLA Una guida al libro di Natale, GIUSEPPE CULICCHIA ERNESTO FERRERO con 200 suggerimenti FABRI FIBRA e 12 consigli di scrittori CHRISTIAN FRASCELLA BRUNO GAMBAROTTA FABIO GEDA MARGARET MAZZANTINI LORENZO MONDO MARGHERITA OGGERO regaloLo ANTONIO SCURATI a... ... alla mamma e al babbo, alla zia e all’amica col cuore infranto, al bibliofilo e al musicofilo, al cinefilo e al cinofilo, a un bambino che fa le elementari, a chi ama il giallo e a chi preferisce la moda... Con Martini, tra fede e umanità oche persone hanno saputo interpretareil e consente di percorrere la ricca raccolta di dialogo come il cardinal Martini: per lui il testi di ogni tipo - dagli esercizi spirituali confronto tra quanti non condividono la sui testi biblici alle lettere pastorali alla medesima fede non è mai stato un cedere al diocesi,fino ai «discorsi alla città» rivolti a sincretismo o al relativismo, ma piuttosto quanti hanno responsabilità nella polis - P un arricchire il rispettivo patrimonio di così da far emergere la tempra del Le illustrazioni «d’epoca» di questo numero sono aneliti e convinzioniproprio grazie alla cristiano e del pastore che alimenta la di un artista a tutto tondo, pittore, scultore, ENZO «differenza» che accetta di lasciarsi propria fede giorno dopo giorno alle incisore, scrittore, interior designer. -

1861-2011. L'italia Dei Libri, Esposta Al XXIV Salone Internazionale Del Libro Di Torino
1861-2011. L'Italia dei Libri I 150 Grandi Libri che - anno dopo anno – dal 1861 al 2011 hanno scandito la storia d’Italia e contribuito a plasmare il nostro costume, il gusto, il nostro pensiero. I libri che ci hanno resi un po’ più italiani. Proponiamo i 150 libri scelti dai curatori della mostra 1861-2011. L'Italia dei Libri, esposta al XXIV Salone internazionale del Libro di Torino. Narrativa, fiabe, poesia, storia e divulgazione scientifica, storia dell’arte e teologia, sperimentazione e umorismo, antropologia criminale e manuali di cucina, bestseller e rarità particolarmente significativi per la storia culturale del nostro Paese. E’ indicata la breve descrizione bibliografica e la collocazione per i libri presenti in biblioteca. 1862 - Paolo Giacometti, La morte civile 1866 - Massimo d’Azeglio, I miei ricordi Massimo d'Azeglio, I miei ricordi, Torino, Einaudi, 1971 853.8 DAZ 1868-1869 - Giuseppe Rovani, Cento anni Giuseppe Rovani, Cento anni, Torino, Einaudi, 2005 853.8 ROV 1869 - Igino Ugo Tarchetti, Fosca Igino Ugo Tarchetti, Una nobile follia; Fosca, Novara, Edizioni per il Club del libro, 1971 853.8 TAR 1871 - Vittorio Bersezio, Le miserie del signor Travetti 1873 - Paolo Mantegazza, Fisiologia dell’amore 1873 - Graziadio Isaia Ascoli, Proemio all’«Archivio glottologico italiano» 1876 - Cesare Lombroso, L’uomo delinquente 1876 - Antonio Stoppani, Il Bel Paese 1877 - Olindo Guerrini (Lorenzo Stecchetti), Postuma 1877 - Vittorio Imbriani, Fame usurpate 1878 - Pasquale Villari, Lettere meridionali 1879 - Paolo Valera, Milano sconosciuta 1881 - Giovanni Verga, I Malavoglia Giovanni Verga, I Malavoglia, Milano, Bompiani, 1990 853.8 VER 1882 - Renato Fucini, Le veglie di Neri Renato Fucini, Le veglie di Neri, Roma, TEN, 1993 mag. -

The Englished Sciascia: Translations 1960-2010
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Salford Institutional Repository [Pre-publication version] Todomodo, Associazione degli Amici di L Sciascia, Leo S. Olschki Editore. November 2011. The Englished Sciascia: Translations 1960-2010 Gillian Ania, University of Salford 1. Contexts Translation, like any writing, is usually practiced in solitary conditions. But it links multitudes.1 How do books, and the ideas within them, travel between countries (where the language is not the same)? While some Europeans are indeed able and willing to read fiction in English, this is not true for a majority of readers, and English readers are hardly noted for their abilities vis-à-vis other languages. Translation is the vehicle that overcomes this hiatus. Nevertheless, and as has frequently been stated in research studies, the UK has long been the largest „exporting‟ country of published fiction within Europe, thus frequently being seen as the „centre‟ exporting its works, via translation, to the „periphery‟, or peripheries. Italy, by contrast has traditionally had only a small „export market‟ as far as literature is concerned.2 Novelist Ian McEwan spoke recently of a country‟s “creative energy index”, calculated from a range of attributes including the numbers of its books which have been translated.3 But who „chooses‟ which books for translation, and what determines their choices? Translations of Dante, for example, continue to appear, and many classic works are repeatedly retranslated.4 Moreover, the 1 Lawrence Venuti, The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference (London: Routledge, 1998), p. -
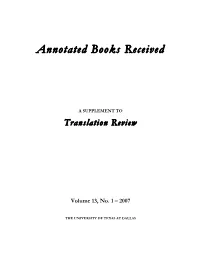
Annotated Books Received
Annotated Books Received A SUPPLEMENT TO Translation Review Volume 13, No. 1 – 2007 THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS CONTRIBUTORS Rainer Schulte Christopher Speck DESIGNER Michelle Long All correspondence and inquiries should be directed to: Translation Review The University of Texas at Dallas Box 830688 (JO 51) Richardson TX 75083-0688 Telephone: 972-883-2092 or 2093 Fax: 972-883-6303 E-mail: [email protected] Annotated Books Received, published twice a year, is a supplement of Translation Review, a joint publication of the American Literary Translators Association and The Center for Translation Studies at The University of Texas at Dallas. ISSN 0737-4836 Copyright © 2007 by American Literary Translators Association and The University of Texas at Dallas The University of Texas at Dallas is an equal opportunity/affirmative action employer. ANNOTATED BOOKS RECEIVED 13.1 TABLE OF CONTENTS Arabic .................................................................................................................... 1 Bulgarian................................................................................................................ 5 Chinese .................................................................................................................. 5 Czech ..................................................................................................................... 8 Danish.................................................................................................................... 9 Dutch .................................................................................................................... -

Scarica Il File
TAVOLA CRONOLOGICA DEGLI AUTORI E DELLE AUTRICI 1500 William Shakespeare 1564-1616 Regno Unito 1600 Blaise Pascal 1623-1662 Francia 1700 Georges-Louis 1707-1788 Francia Leclerc de Buffon Gotthold E. Lessing 1729-1781 Germania Johann W. Goethe 1749-1832 Germania Fran çois-René de 1768-1848 Francia Chateaubriand Ugo Foscolo 1778-1827 Italia Stendhal 1783-1842 Francia Claudia Masia – Roberta Mazzoni, Dino Audino editore 2020 1 Scrivere Arthur Schopenhauer 1788-1860 Polonia John Keats 1795-1821 Regno Unito Giacomo Leopardi 1798-1837 Italia 1800 Ralph Waldo 1803-1882 Stati Uniti Emerson Edgar A. Poe 1809-1849 Stati Uniti Walt Whitman 1819-1892 Stati Uniti Herman Melville 1819-1891 Stati Uniti Gustave Flaubert 1821-1880 Francia Fëdor Dostoevskij 1821-1881 Russia Lev Tolstoj 1828-1910 Russia Emily Dickinson 1830-1886 Stati Uniti Giovanni Verga 1840-1922 Italia Henry James 1843-1916 Stati Uniti Isidore D. 1846-1870 Francia de Lautréamont Guy de Maupassant 1850-1893 Francia Robert Louis 1850-1894 Regno Unito Stevenson Oscar Wilde 1854-1900 Irlanda Joseph Conrad 1857-1924 Regno Unito 2 Claudia Masia – Roberta Mazzoni, Dino Audino editore 2020 Tavola cronologica Arthur C. Doyle 1859-1930 Regno Unito Anton Čechov 1860-1904 Russia Benedetto Croce 1866-1952 Italia André Gide 1869-1951 Francia Marcel Proust 1871-1922 Francia Hugo von 1874-1929 Austria Hofmannsthal Gertrude Stein 1874-1946 Stati Uniti William Somerset 1874-1965 Regno Unito Maugham Rainer Maria Rilke 1875-1926 Repubblica Ceca Jack London 1876-1916 Stati Uniti Herman Hesse 1877-1962 Germania Robert Walser 1878-1956 Svizzera Edward M. Forster 1879-1970 Regno Unito Robert Musil 1880-1942 Austria Virginia Woolf 1882-1941 Regno Unito James Joyce 1882-1941 Irlanda Franz Kafka 1883-1924 Repubblica Ceca José Ortega y Gasset 1883-1955 Spagna David H. -

Graduate Liberal Studies Course Proposal for Spring 2019 Instructor: Jeanne Bonner Italian Women Writers
Wesleyan University – Graduate Liberal Studies course proposal For Spring 2019 Instructor: Jeanne Bonner Italian Women Writers: Before and After #FerranteFever From Grazia Deledda in the early part of the 20th century (the only Italian woman to win the Nobel Prize for Literature), Elsa Morante and Natalia Ginzburg of the wartime era to Anna Maria Ortese in the postwar period, and Margaret Mazzantini and Elena Ferrante in more recent times, Italian literature by women, and in particular fiction or fictionalized memoir, provides a window on the times, as well as a portrait of a gender enshrined as Madonna-like on the one hand or sultry, sexual objects on the other but whose ambitions, in any event, have been vigorously policed (to quote playwright and actress Franca Rame, “All home, bed and church”). In this course, we will focus primarily on Italian women novelists and short story writers of the 20th and 21st century, with a few examples of earlier writers as well as two standout poets. And in doing so, we will read not only a Nobel laureate but also multiple writers who have won Italy’s highest literary prize, the Premio Strega. Indeed, the women authors who paved the way for #FerranteFever form a rich canon of literature unto themselves, despite the obstacles placed in their way. We will examine the social and political issues addressed by these works while also paying close attention to the context in which these Italian women writers wrote. That includes the political and social developments in Italy in the 19th and 20th centuries, with an emphasis on issues of special relevance to women. -

Osservatorio Bibliografico Della Letteratura Italiana Otto-Novecentesca
ob io Oblio Osservatorio Bibliografico della Letteratura Italiana Otto-novecentesca Anno I, numero 1 Aprile 2011 OBLIO – Periodico trimestrale on-line – Anno I, n. 1 – Aprile 2011 sito web: www.progettoblio.com e-mail: [email protected] ISSN: 2039-7917 Direttore: Nicola MEROLA Direttore responsabile: Giulio MARCONE Redazione: Laura ADRIANI, Saverio VECCHIARELLI Amministratore: Saverio VECCHIARELLI Realizzazione Editoriale: Vecchiarelli Editore S.r.l. Comitato dei referenti scientifici: Giovanni BARBERI SQUAROTTI, Floriana CALITTI, Giovanna CALTAGIRONE, Luca CLERICI, Francesco DE NICOLA, Matilde DILLON, Marco DONDERO, Enrico ELLI, Patrizia FARINELLI, Lucio FELICI, Ombretta FRAU, Margherita GANERI, Lucio Antonio GIANNONE, Stefano GIOVANNUZZI, Vicente GONZÁLEZ MARTÍN, Cristina GRAGNANI, Monica LANZILLOTTA, Giuseppe LO CASTRO, Giovanni MAFFEI, Marco MANOTTA, Aldo MORACE, Mariella MUSCARIELLO, Giorgio NISINI, Massimo ONOFRI, Marina PAINO, Nunzia PALMIERI, Antonio PIETROPAOLI, Elena PORCIANI, Giancarlo QUIRICONI, Mario SECHI, Carlo SERAFINI, Silvana TAMIOZZO GOLDMANN, Dario TOMASELLO, Caterina VERBARO VECCHIARELLI EDITORE S.R.L. Piazza dell’Olmo, 27 – 00066 Manziana (Rm) Tel/Fax: 06 99674591 Partita IVA 10743581000 Iscrizione C.C.I.A.A. 10743581000 del 13/01/2010 VECCHIARELLI EDITORE Elenco Recensori Oblio I, 1 Ilaria ACCARDO Chiara LOMBARDI Federica ADRIANO Silvia LUTZONI Celia ARAMBURU SÁNCHEZ Giovanni MAFFEI Francesco Mattia ARCURI Beatrice MANETTI Luigi Ernesto ARRIGONI Chiara MARASCO Luca BANI Alessandro MARONGIU Maria Ginevra BARONE -

5. Numeri Di Letterature
I PRIMI 9 ANNI DI LETTERATURE Festival Internazionale di Roma Nelle prime 9 EDIZIONI di Letterature Festival Internazionale di Roma, la Basilica di Massenzio ha ospitato 300.000 SPETTATORI in 91 SERATE . 183 SCRITTORI e POETI , accompagnati da 88 ATTORI , 123 MUSICISTI o GRUPPI e 14 VIDEO ARTISTI , sono saliti sul palco e hanno letto 150 TESTI INEDITI scritti appositamente per le diverse edizioni del Festival e poi raccolti in 9 CATALOGHI. Durante il periodo del festival nei 9 ANNI di programmazione oltre 200.000 PERSONE hanno visitato il sito www.festivaldelleletterature.it dove è possibile rileggere i testi inediti e avere maggiori informazioni su autori e artisti partecipanti. Dallo scorso anno, inoltre, il Festival è sbarcato sui social network: è stato creato il canale FLICKR che al momento raccoglie 279 FOTO , il canale youtube con 49 VIDEO , la pagina FACEBOOK e la pagina TWITTER. 2002 | SOLI, INSIEME Una riflessione sul rapporto tra la memoria del vissuto individuale e di quello collettivo. Michael Chabon, Jonathan Coe, Jostein Gaarder, Günter Grass, David Grossman, J.T. Leroy, Frank McCourt, Ian McEwan, Patrick McGrath, Toni Morrison, Amélie Nothomb, Luis Sepúlveda, Manuel Vázquez Montálban, Derek Walcott, Abraham B. Yehoshua. 2003 | PASSATO, FUTURO Una riflessione sul rapporto tra l’esperienza del passato e le brucianti questioni del domani Doris Lessing, Jonathan Lethem, Jeffrey Eugenides, Andrea Camilleri, Boris Akunin, Alan Warner, Don DeLillo, Tracy Chevalier, Daniel Pennac, Susan Sontag, Alice Sebold, Irina Denezkina, Dacia Maraini, Paco Ignacio Taibo II, Hanif Kureishi, Paul Auster. 2004 | REALE, IMMAGINARIO Il vissuto e l’immaginazione, la realtà e la fantasia, la Letteratura ne fa oggetto costante di riflessione, propria “materia” di lavoro . -

Composizione Biblioteca (In Ordine Di Lingua) La Biblioteca (Por Orden De
La biblioteca (Los libros de la biblioteca) 2452 (1690 archiviati / archivados + 762 da archiviare / para archivar) Autori presenti (Autores presentes) 600 Lingue presenti (Lenguas presentes) 47 lingue/idiomas (rappresentati 17 alfabeti / alfabetos) Per Written in Italy a Montevideo (Biblioteca nacional de Uruguay, 19 – 23 marzo 2012) si ringraziano: Por Written in Italy in Montevideo (Biblioteca naciona de Uruguay, 19 – 23 marzo 2012) muchas gracias: Ambasciata d'Italia in Uruguay Embajada de Italia en Uruguay Istituto italiano di cultura Instituto Italiano de Cultura Biblioteca nazionale dell'Uruguay Biblioteca nacional de Uruguay e con il sostegno di con la collaboración de Composizione biblioteca (in ordine di lingua) La biblioteca (por orden de idioma) Libro tradotto / Libro traducido Autore / Autor Lingua / Idioma Paese / Pais Año Un borghese piccolo piccolo Vincenzo Cerami Afrikaans Republic of South Africa 2008 La forza del passato Sandro Veronesi Albanian Prato, Italy 2008 Todo modo Il contesto Leonardo Sciascia Albanian Palermo, Italy 2009 I fuochi del Basento Raffaele Nigro Albanian Bari, Italy 2008 La lunga vita di Marianna Ucrìa Dacia Maraini Albanian Rome, Italy 2008 La donna leopardo Alberto Moravia Albanian Rome, Italy 2008 Mal di pietre Milena Agus Albanian Rome, Italy 2010 Oceano mare Alessandro Baricco Albanian Rome, Italy 2008 La baronessa dell'Olivento Raffaele Nigro Albanian Bari, Italy 2008 Le avventure di Pinocchio Carlo Collodi Arabic Milano, Italy 2008 La Divina commedia Dante Alighieri Arabic Milano, Italy 2011 -

“Gli Echi E Il Ricordo”: La Narrativa Di Nelida Milani
Corso di Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura Italiana Tesi di Laurea Magistrale “Gli echi e il ricordo”: la narrativa di Nelida Milani Relatrice Prof.ssa Michela Rusi Correlatrici Prof.ssa Silvana Tamiozzo Prof.ssa Monica Giachino Laureanda Silvia Toniolo 833754 Anno Accademico 2015/ 2016 INDICE Introduzione ............................................................................................... p. 3 Cap. I – Nelida Milani e l’Istria................................................................ p. 7 1.1 La vita e gli studi ............................................................................. p. 13 1.2 L’attività letteraria ........................................................................... p. 15 Cap. II – Le ricorrenze tematiche ............................................................ p. 33 2.1 L’Esodo a Pola ................................................................................. p. 36 2.2 I temi della crisi d’identità ............................................................... p. 45 2.2.1 La città come specchio del cambiamento .............................. p. 46 2.2.2 Il plurilinguismo ..................................................................... p. 50 2.2.3 Le convivenze difficili, l’odio e il pregiudizio ....................... p. 53 2.3 I temi della memoria ......................................................................... p. 57 2.3.1 La casa e il paesaggio ............................................................ p. 59 2.3.2 La componente autobiografica .............................................. -

Elenco Libri Completo Al 4-11-2017 in Ordine Di Anno E Titolo Titolo Autore Tipo Anno Cod
Elenco libri completo al 4-11-2017 in ordine di Anno e titolo Titolo Autore Tipo Anno Cod. Classificazione I racconti di Gramigna Don Vago Gabriele Libro 2017 6000 Narrativa Un caffè amaro per il commissario Dupin Jean Luc Bannalec Libro 2017 5699 Romanzo Duecentosei ossa Kathy Reichs Libro 2016 5700 Romanzo Il romanzo di mafia capitale Massimo Lugli Libro 2016 5701 Romanzo Il treno per Tallin Arno Saar Libro 2016 5707 Romanzo La civiltà perduta Elio Riviera Libro 2016 5537 Narrativa La costa Cremisi Douglas Preston Libro 2016 5702 Thriller La primavera tarda ad arrivare Flavio Santi Libro 2016 5701 Romanzo La ragazza di Brooklyn Guillaume Musso Libro 2016 5698 Thriller La ragazza del parco Alafair Burke Libro 2016 5699 Thriller La stanza delle torture Stuart Macbride Libro 2016 5700 Romanzo Thriller L'angelo Sandrone Dazieri Libro 2016 5706 Thriller Le solite sospette John Niven Libro 2016 5710 Romanzo Niceville Carsten Stroud Libro 2016 5711 Romanzo Thriller Urlare non basterà Brian McGilloway Libro 2016 5712 Romanzo Thriller Vicino al cadavere Stuart Macbride Libro 2016 5713 Romanzo Thriller Amore e altri imprevisti Maria Murnane Libro 2015 5731 Romanzo Binari divaganti Matteo Melotti Libro 2015 5518 Narrativa Central Park Guillaume Musso Libro 2015 5697 Thriller Come un ricordo che uccide Sabine Durrant Libro 2015 5478 Thriller Cuore depravato Patricia Cornwell Libro 2015 5694 Romanzo Homo dieteticus Marino Niola Libro 2015 5695 Diete I peccati della bocciofila Marco Ghizzoni Libro 2015 5511 Romanzo Il coraggio di ritornare liberi -

Titolo Libro Autore Genere Casa Editrice I Negri in America Arnold
Titolo libro Autore Genere Casa editrice I negri in America Arnold Rose Saggistica Einaudi Rapporto dal Vietnam Emilio Sarzi Amadè saggistica Einaudi Chi gioca solo Danilo Dolci saggistica Einaudi La rivoluzione permanente Lev Trotskij saggistica Einaudi Conversazioni Danilo Dolci saggistica Einaudi Isonzo 1917 Mario Silvestri saggistica Einaudi Bonaparte in Egitto J. Christopher Herold saggistica Enaudi La strada del Davai Nuto Revelli saggistica Enaudi I russi a Berlino Erich Kuby saggistica Enaudi Il caso Sorge F.W. Deakin e G.R. Storry saggistica Enaudi Storia degli ebrei in Italia Attilio Milano saggistica Enaudi La politica italiana da Porta Pia Vittorio Veneto 1870-1918 Ivanoe Bonomi Storia Enaudi George Macaulay Storia della società inglese Trevelyan storia Enaudi Chiesa e stato in Italia negli ultimi cento anni Arturo Carlo Jemolo storia Enaudi La società feudale Marc Bloch storia Enaudi Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II Fernand Braunel storia Enaudi Storia della dominazione europea in Asia Kavalam M. Panikkar storia Enaudi La Rivoluzione francese Georges Lefebvre storia Enaudi La prima guerra d'Africa Roberto Battaglia storia Enaudi Storia della guerra civile americana Raimondo Luraghi storia Enaudi Maometto il Conquistatore Babinger storia Enaudi La città greca Glotz storia Enaudi L'Era dei buoni sentimenti Dangerfield storia Enaudi Lutero Bainton storia Enaudi Storia degli Stati Uniti Nevins e Commager storia Enaudi Russia e stati italiani nel Risorgimento Berti storia Enaudi Rinascimento e Riforma Hauser-Renaudet