Università Degli Studi Di Padova
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Europa E Italia. Studi in Onore Di Giorgio Chittolini
21 VENICE AND THE VENETO DURING THE RENAISSANCE THE LEGACY OF BENJAMIN KOHL Edited by Michael Knapton, John E. Law, Alison A. Smith thE LEgAcy of BEnJAMin KohL BEnJAMin of LEgAcy thE rEnAiSSAncE thE during VEnEto thE And VEnicE Smith A. Alison Law, E. John Knapton, Michael by Edited Benjamin G. Kohl (1938-2010) taught at Vassar College from 1966 till his retirement as Andrew W. Mellon Professor of the Humanities in 2001. His doctoral research at The Johns Hopkins University was directed by VEnicE And thE VEnEto Frederic C. Lane, and his principal historical interests focused on northern Italy during the Renaissance, especially on Padua and Venice. during thE rEnAiSSAncE His scholarly production includes the volumes Padua under the Carrara, 1318-1405 (1998), and Culture and Politics in Early Renaissance Padua thE LEgAcy of BEnJAMin KohL (2001), and the online database The Rulers of Venice, 1332-1524 (2009). The database is eloquent testimony of his priority attention to historical sources and to their accessibility, and also of his enthusiasm for collaboration and sharing among scholars. Michael Knapton teaches history at Udine University. Starting from Padua in the fifteenth century, his research interests have expanded towards more general coverage of Venetian history c. 1300-1797, though focusing primarily on the Terraferma state. John E. Law teaches history at Swansea University, and has also long served the Society for Renaissance Studies. Research on fifteenth- century Verona was the first step towards broad scholarly investigation of Renaissance Italy, including its historiography. Alison A. Smith teaches history at Wagner College, New York. A dissertation on sixteenth-century Verona was the starting point for research interests covering the social history of early modern Italy, gender, urban elites, sociability and musical academies. -

L'oro Dei Tiranni: I Vicari Venali Di Enrico
Riccardo Rao L’oro dei tiranni: i vicariati venali di Enrico VII e la signoria cittadina nell’Italia padana Reti Medievali Rivista, 15, 1 (2014) <http://rivista.retimedievali.it> Enrico VII e il governo delle città italiane (1310-1313) a cura di Gian Maria Varanini Firenze University Press 1 Reti Medievali Rivista, 15, 1 (2014) <http://rivista.retimedievali.it> ISSN 1593-2214 © 2014 Firenze University Press DOI 10.6092/1593-2214/413 Enrico VII e il governo delle città italiane (1310-1313) a cura di Gian Maria Varanini L’oro dei tiranni: i vicariati venali di Enrico VII e la signoria cittadina nell’Italia padana di Riccardo Rao Durante l’avventura di Enrico VII in Italia, tra il 1310 e il 1313, l’imperatore concesse a numerosi signori dell’Italia padana il titolo di vicario in cambio del- l’esborso di consistenti somme di denaro che servirono a finanziare la spedi- zione. Tali transazioni non mancarono di colpire l’attenzione dei contemporanei. Nelle cronache dell’epoca, tali episodi sono riferiti in più occasioni con una pun- ta di disprezzo. Per il fiorentino Giovanni Villani, Enrico VII «in Milano lasciò per vicaro e capitano messer Maffeo Visconti, e in Verona messer Cane della Scala, e in Mantova messer Passerino di Bonaposi, e in Parma messer Ghiberto da Coreggia e così in tutte l’altre terre di Lombardia lasciò a tiranni, non pos- sendo altro per lo suo male stato, e da ciascuno ebbe moneta assai, e brivileg- 1 giogli de le dette signorie» . Sulla stessa lunghezza d’onda, per il cronista aste- se Guglielmo Ventura, l’imperatore «constituit ex auro Mapheum Vicecomitem in Mediolano Canem de Scala in Verona dominos, qui semper in dictis civita- 2 tibus tiranni fuerunt» . -
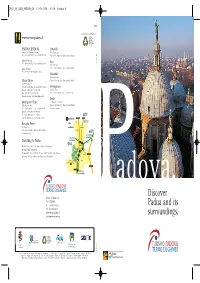
Discover Padua and Its Surroundings
2647_05_C415_PADOVA_GB 17-05-2006 10:36 Pagina A Realized with the contribution of www.turismopadova.it PADOVA (PADUA) Cittadella Stazione FS / Railway Station Porta Bassanese Tel. +39 049 8752077 - Fax +39 049 8755008 Tel. +39 049 9404485 - Fax +39 049 5972754 Galleria Pedrocchi Este Tel. +39 049 8767927 - Fax +39 049 8363316 Via G. Negri, 9 Piazza del Santo Tel. +39 0429 600462 - Fax +39 0429 611105 Tel. +39 049 8753087 (April-October) Monselice Via del Santuario, 2 Abano Terme Tel. +39 0429 783026 - Fax +39 0429 783026 Via P. d'Abano, 18 Tel. +39 049 8669055 - Fax +39 049 8669053 Montagnana Mon-Sat 8.30-13.00 / 14.30-19.00 Castel S. Zeno Sun 10.00-13.00 / 15.00-18.00 Tel. +39 0429 81320 - Fax +39 0429 81320 (sundays opening only during high season) Teolo Montegrotto Terme c/o Palazzetto dei Vicari Viale Stazione, 60 Tel. +39 049 9925680 - Fax +39 049 9900264 Tel. +39 049 8928311 - Fax +39 049 795276 Seasonal opening Mon-Sat 8.30-13.00 / 14.30-19.00 nd TREVISO 2 Sun 10.00-13.00 / 15.00-18.00 AIRPORT (sundays opening only during high season) MOTORWAY EXITS Battaglia Terme TOWNS Via Maggiore, 2 EUGANEAN HILLS Tel. +39 049 526909 - Fax +39 049 9101328 VENEZIA Seasonal opening AIRPORT DIRECTION TRIESTE MOTORWAY A4 Travelling to Padua: DIRECTION MILANO VERONA MOTORWAY A4 AIRPORT By Air: Venice, Marco Polo Airport (approx. 60 km. away) By Rail: Padua Train Station By Road: Motorway A13 Padua-Bologna: exit Padua Sud-Terme Euganee. Motorway A4 Venice-Milano: exit Padua Ovest, Padua Est MOTORWAY A13 DIRECTION BOLOGNA adova. -

Per L'attribuzione Del Carme Scaliger Interea Canis: Aspetti Stilistici E Metrici
Università degli Studi di Padova Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna Classe LM-14 Tesi di Laurea Per l’attribuzione del carme Scaliger interea Canis: aspetti stilistici e metrici Relatore Laureando Prof. Giovanna Maria Gianola Silvia Berti n° matr.1104222 / LMFIM Anno Accademico 2016 / 2017 1 INDICE PREMESSA 3 LA VITA E LE OPERE 5 DE SCALIGERORUM ORIGINE 11 1. Composizione e tradizione 13 2. Lo studio del lessico 15 2.1 Ezzelino e i proceres 15 2.2 I conflitti 24 2.3 Le vittime 28 2.4 I della Scala 32 3. Retorica e sintassi 45 4. Uno sguardo d’insieme 59 DOPO IL DE SCALIGERORUM ORIGINE: OSSERVAZIONI SULL’HISTORIA 63 SCALIGER INTEREA CANIS 71 1. Composizione e tradizione 73 2. Lo studio del lessico 79 2.1 I personaggi 79 2.2 I conflitti 88 2.3 Le vittime 90 2.4 La toponomastica 92 3. Retorica e sintassi 99 ASPETTI METRICI 105 1. Metodo e strumenti 107 2. Gli schemi metrici 109 3. La sinalefe 113 4. Le cesure 117 2 CONCLUSIONI 121 TRADUZIONE 125 APPENDICE 149 BIBLIOGRAFIA 177 3 PREMESSA «La volta che Lila e io decidemmo di salire per le scale buie che portavano, gradino dietro gradino, rampa dietro rampa, fino alla porta dell’appartamento di don Achille, cominciò la nostra amicizia.»1 E cominciò così anche uno dei casi editoriali più discussi dell’ultimo quarto di secolo. L’autrice della tetralogia L’amica geniale, infatti, si è da allora celata dietro lo pseudonimo di Elena Ferrante. -

Dante and Giovanni Del Virgilio : Including a Critical Edition of the Text
Digitized by the Internet Archive in 2007 with funding from IVIicrosoft Corporation http://www.archive.org/details/dantegiovannidelOOdantuoft DANTE AND GIOVANNI DEL VIEGILIO. W^ Dante and Giovanni del Virgilio Including a Critical Edition of the text of Dante's " Eclogae Latinae " and of the poetic remains of Giovanni del Virgilio By Philip H. Wicksteed, M.A. and Edmund G. Gardner, M.A. Solatur maesti nunc mea fata senis Westminster Archibald Constable & Company, Ltd. 1902 GLASGOW: PRINTED AT THE UNIVERSITY PRESS BV ROBERT MACLEHOSB AND CO. TO FRANCIS HENRY JONES AND FRANCIS URQUHART. PREFACE. Our original intention was merely to furnish a critical edition, with a translation and commentary, of the poetical correspondence between Dante and Del Virgilio. But a close study of Del Virgilio's poem addressed to Mussato, with a view to the discovery of matter illustrative of his correspondence with Dante, convinced us that Dante students would be glad to be able to read it in its entirety. And when we found ourselves thus including the greater part of Del Virgilio's extant work in our book, the pious act of collecting the rest of his poetic remains naturally sug- gested itself; and so our project took the shape of an edition of Dante's Latin Eclogues and of the poetic remains of Del Virgilio, The inclusion in our work of the Epistle to Mussato made some introductory account of the Paduan poet necessary ; and his striking personality, together with the many resemblances and contrasts between his lot and that of Dante, encouraged us to think that such an account would be acceptable to our readers. -

The States of Italy History of Verona Am
www.cristoraul.org THE STATES OF ITALY HISTORY OF VERONA A. M. ALLEN 1 www.cristoraul.org PREFACE THERE is no need to explain the origin of this attempt to write the history of Verona, the inherent fascination of the subject speaks for itself. But I cannot let this volume appear without expressing my sincere thanks to all who have assisted me during its preparation. First and foremost I desire to thank the cavaliere Gaetano da Re, of the Biblioteca Comunale at Verona, who, during my two visits to Verona, in 1904 and 1906, placed at my disposal the treasures both of the library and of his learning with the most generous kindness, and since then has settled more than one difficult point. From the other officials of this library, and those of the other libraries I visited, the Biblioteca Capitolare at Verona, the Biblioteca Marciana and the Archivio di Stato (in the Frari) at Venice, and the Archivio Gonzaga at Mantua, I met with the same unfailing and courteous assistance. Among modern works I have found Count Carlo Cipolla’s writings on Verona and his scholarly edition of the early Veronese chroniclers invaluable, while J. M. Gittermann’s Ezzelino III. da Romano, E. Salzer’s Ueber die Anfange der Signorie in Oberitalien, and H. Spangenberg’s Cangrande I are all of the first importance for various periods of Veronese history. My thanks are also due to Miss Croom-Brown, who constructed the three maps, the result of much careful research, and to my cousin, Mr. Alfred Jukes Allen, who read the proofs with minute accuracy. -

Novembre Dicembre 2018
6 9 1 ‘Taxe Percue’ ‘Tassa Riscossa’ - Padova C.M.P. Poste Italiane s.p;a. - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - DCB Padova Abbonamento annuo: Italia 30,00 - Estero 60,00 - Fascicolo separato 6,00 rivista distoria artecultura ANNO XXXIII D I CEMBRE 2018 ISSN 1120-9755 BELVEST.COM BELVEST_Padova_Campagna FW18-19_210x295_MM.indd 1 07/09/18 14:31 3 Editoriale 4 Padova Urbs picta patrimonio mondiale dell’Unesco Giorgio Andrian 7 Albertino Mussato e Padova Rino Modonutti 10 Marsilio da Padova difensore dell’Impero Gregorio Piaia 14 I Carraresi “zitadini de Padoa” Dario Canzian 20 Giovanni Dondi dall’Orologio Enrio Berti 23 I Santasofia. Una dinastia di medici nella Padova del Trecento Claudio Caldarazzo 26 Vita quotidiana a Padova nel Medioevo Francesco Jori 28 Le mura trecentesche di Padova Ugo Fadini 34 Guariento e la Padova carrarese: opere, committenti, contesti Zuleika Murat 39 Giusto de’ Menabuoi a Padova Pasquale Francesco Antonino Giambò 44 Altichiero e Jacopo Avanzi al Santo Luca Baggio 50 La perduta Sala degli Uomini illustri Giulio Bodon 52 Jacopo da Verona e la Cappella di S. Maria Davide Banzato 56 Pagine dipinte per Padova Urbs picta Giordana Mariani Canova 62 Padova Urbs Musicae Antonio Lovato 68 Rubriche Rivista bimestrale • Anno XXXIII • Fascicolo 196 • Novembre-Dicembre 2018 Associazione “Padova e il suo territorio”: Presidente: Antonio Cortellazzo Vice Presidente: Giorgio Ronconi Consiglieri: Gianni Callegaro, Paolo Maggiolo, Luisa Scimemi di San Bonifacio, Anna Soatto, Mirco -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die Ausstattung der Cappella Carrara in der Reggia Carrarese in Padua Verfasserin Kornelia Mohl Angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. Phil.) Wien, im März 2011 Studienkennzahl laut Studienblatt: A 315 Studienrichtung laut Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuerin: Ao. Prof. Dr. Monika Dachs-Nickel Meinen Eltern Mein Dank gilt an erster Stelle meiner Betreuerin Dr. Monika Dachs-Nickel für ihre wissenschaftlichen Ratschläge und ihre Unterstützung in allen Bereichen bezüglich der Umsetzung meiner Diplomarbeit. Prof. Diego Rossi, dem Leiter der Bibliothek der Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, danke ich für die Unterstützung bei der Literaturrecherche und für die geduldige Beantwortung meines nicht enden wollenden Fragenkataloges. Ebenso dem Team von Legambiente, das für die Betreuung der Cappella Carrarese während meiner Besuche zuständig war. Meinen Kommilitonen danke ich für die anregenden Gespräche und Ratschläge. Ein großer Dank gebührt vor allem meinen Eltern, Maria und Werner, die mich immer unterstützt haben und immer an mich glaubten, ebenso meiner Schwester Elisabeth und meinem Freund Alex. Für die aufmunternden Gespräche und den festen Glauben an mich bin ich meinen Freunden, Bekannten, Verwandten und Arbeitskollegen zu besonderem Dank verpflichtet. Hervorheben möchte ich insbesondere Andreas Deppe, der wesentlichen Anteil an der Endfassung meiner Arbeit trägt. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2 2. Padua und das Geschlecht Carrara 5 2.1 Zur künstlerischen -
Di Marino Zabbia
Albertino Mussato da filologo a storico di Marino Zabbia Reti Medievali Rivista, 19, 1 (2018) <http://www.retimedievali.it> Tra storiografia e retorica: prospettive nel basso medioevo italiano a cura di Marino Zabbia Firenze University Press Reti Medievali Rivista, 19, 1 (2018) <http://rivista.retimedievali.it> ISSN 1593-2214 © 2018 Firenze University Press DOI 10.6092/1593-2214/5460 Tra storiografia e retorica: prospettive nel basso medioevo italiano a cura di Marino Zabbia Albertino Mussato da filologo a storico* di Marino Zabbia Il saggio ricostruisce l’ambiente culturale in cui Albertino Mussato ha maturato la propria voca- zione a storico. Formatosi studiando i classici latini secondo l’esempio di Lovato Lovati, Mussato ha utilizzato quanto appreso con le sue letture per diventare egli stesso autore e comporre opere in versi e in prosa. Ma se ai suoi scritti in versi arrise immediata, ampia e, per qualche opera, anche durevole fortuna, le sue lunghe cronache in prosa, pur lette e ammirate dai contempora- nei, non riuscirono ad affermarsi come modello storiografico da imitare. The essay reconstructs the cultural milieu within which Albertino Mussato nurtured his vocation as a chronicler. Trained in the Latin classics according to the example of Lovato Lovati, Mussato used the knowledge he acquired from these texts to become himself an author of both verse and prose. His writings in verse enjoyed immediate, widespread, and (in certain cases) long-lasting fortune. Conversely, his long Chronicles written in prose, even if widely read and admired by his contemporaries, were never considered as a historiographical model worthy of imitation. Medioevo; secoli XIII-XIV; Italia; cronache; epistolografia; poesia epica; preumanesimo pado- vano; Albertino Mussato. -

Andrea Castagnetti Famiglie Di Governo E Storia Di Famiglie
Andrea Castagnetti Famiglie di governo e storia di famiglie. Gli esempi di Verona e Padova (secoli XI- XIV)∗ [A stampa con il titolo Famiglie di governo e storia di famiglie in Il Veneto nel Medioevo. Le signorie trecentesche, a cura di A. Castagnetti - G. M. Varanini, Verona 1995, pp. 201-248 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"] 1. Introduzione 2. La struttura familiare della domus dai ceti signorili e feudali a quelli dell'aristocrazia cittadina 2.1. Le famiglie comitali, signorili e feudali 2.2. Strategia familiare e politica delle famiglie signorili 2.3. La domus dei ceti cittadini di governo 3. La crisi delle antiche domus veronesi fra il dominio ezzeliniano e il 'comune di popolo' 4. I della Scala da cittadini a signori 5. La formazione di una nuova classe dirigente in età signorile 6. Le casate a Padova tra evoluzione politica e tradizione storiografica 7. Le casate padovane del primo Trecento e la tradizione magnatizia 8. I da Carrara, signori rurali, 'magnati', signori cittadini 9. Il consiglio generale dell'anno 1372: vecchie e nuove famiglie 'nobili' 10. Il consiglio del signore 11. Casate e politica 1. Introduzione Il contributo riprende il tema della «formazione di una nuova classe dirigente in età signorile»1, da me affrontato tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, nell'ambito di una storia della Marca Veronese-Trevigiana nei secoli XI-XIV, non considerata, come di tradizione, di 'terraferma', ma presentata e trattata con una propria individualità storica, che si era concretizzata nella costituzione della Marca Veronese ad opera di Ottone I alla metà del secolo X2, un ampio distretto pubblico, sottoposto alla giurisdizione di duchi di Baviera e poi di Carinzia: avviatosi verso la dissoluzione, esso fu riorganizzato verso la metà del secolo XIII, quando fu affidato a governatori imperiali e assunse il nome di Marca Trevigiana3. -

Archivio Veneto
ARCHIVIO VENETO SESTA SERIE - n. 15 (2018) Federico Pigozzo L’AMMINISTRAZIONE SCALIGERA DEL DISTRETTO DI MONSELICE (1317-1338) Tra la fine degli anni Venti e la fine degli anni Trenta del XIV secolo la signoria scaligera di Verona visse il suo periodo d’oro, costituendo un vasto dominio territoriale prima con Cangrande I e poi con i nipoti Mastino II e Alberto II: le città di Vicenza, Feltre, Belluno, Treviso, Padova, Brescia, Parma e Lucca costituirono le tappe di un’espansione territoriale che all’epoca ebbe pochi confronti. All’ampiezza delle di- mensioni, tuttavia, fa da contrappunto la drammatica carenza di docu- mentazione, dal momento che, come è noto, la mancata conservazione dei materiali archivistici coevi in quasi tutte le città coinvolte (con rare eccezioni come Treviso e Lucca), impedisce di indagare a fondo le strut- ture e i meccanismi del governo scaligero e consente solamente rari sondaggi nelle località più fortunate1. Si offre ora la possibilità di svolgere un’indagine, non approfondita quanto si vorrebbe, ma comunque ricca di spunti, su Monselice, un centro minore dello stato territoriale scaligero, situato sul margine me- ridionale dei Colli Euganei, una ventina di chilometri a sud di Padova. Il destro è fornito dal riconoscimento, all’interno di una miscellanea di protocolli notarili padovani anonimi, di due fascicoli appartenenti a notai operanti a Monselice nei primi anni Trenta. Il primo fascicolo si compone di 67 carte contenenti atti misti del 1330-1331, un atto del 1333, due del 1336 e una serie di testamenti dettati durante l’assedio 1 G.M. Varanini, Pietro Dal Verme podestà scaligero di Treviso (1329-1336), in Isti- tuzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). -

Documento Su Albertino Mussato (1293), in «Quaderni Veneti», 8 (1988), Pp
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E LETTERARI SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE LINGUISTICHE FILOLOGICHE E LETTERARIE INDIRIZZO DI ITALIANISTICA (XXV CICLO) IL DE GESTIS ITALICORUM POST HENRICUM SEPTIMUM CESAREM DI ALBERTINO MUSSATO EDIZIONE CRITICA E TRADUZIONE DEI LIBRI I-IV DIRETTORE DELLA SCUOLA DI DOTTORATO ch.mo prof. ROSANNA BENACCHIO COORDINATORE D’INDIRIZZO ch.mo prof. GUIDO BALDASSARRI SUPERVISORE ch.mo prof. GIOVANNA M. GIANOLA DOTTORANDO dott. RINO MODONUTTI PREMESSA Questa tesi nasce all’interno di un progetto di ricerca che mira a provvedere nuove edizioni critiche delle opere di Albertino Mussato (soprattutto delle opere storiografiche), studiando meglio di quanto sinora non sia stato fatto il latino del primo Umanesimo. Nel 1999 è uscita l’edizione critica del poema storico De obsidione. Sono in corso di stampa le edizioni della Traditio Padue ad Canem Grandem e del Ludovicus Bavarus; le riviste «Filologia mediolatina» e «Italia medioevale e umanistica» hanno ospitato negli ultimi numeri alcuni importanti contributi sulla storia della tradizione delle opere storiografiche del Mussato, dedicati in particolare al De gestis Henrici septimi Cesaris e al Ludovicus Bavarus. Fuori dal campo d’indagine era finora rimasta la seconda grande opera storica del Mussato, il De gestis Italicorum post Henricum septimum Cesarem, che presenta una situazione testuale ed editoriale particolarmente complessa. Solo parzialmente pubblicata nel Seicento e nel Settecento, affidata per più della metà della sua estensione a un solo mediocrissimo testimone, trascritto in edizione diplomatica all’inizio del Novecento, l’opera è rimasta quasi del tutto ignorata dagli studiosi. La mia tesi di dottorato vuole iniziare a dissodare questo campo incolto, realizzando l’edizione dei primi quattro libri dell’opera.