Origini Dell'arbitrato Commerciale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The King Heir. Claiming Vacant Estate Succession in Europe and in the Spanish World (13Th-18Th Centuries)
Français Partager CATALOGUE Tout ACCUEIL DES 549 OPENEDITION SEARCH OpenEdition REVUES Accueil L’Atelier du CRH 22 The King Heir. Claiming Vacant Es... L’Atelier du Centre de recherches historiques Revue électronique du CRH 22 | 2020 : Sous tutelle. Biens sans maître et successions vacantes dans une perspective comparative, XIIIe-XXe siècles The King Heir. Claiming Vacant Estate Succession in Europe and in the Spanish World (13th-18th Centuries) Le roi héritier. Les revendications sur la succession vacante en Europe et dans le Monde espagnol XIIIe - XVIIIe siècles ALESSANDRO BUONO https://doi.org/10.4000/acrh.10917 Résumés English Français This article deals with the claims on “vacant successions” (bona vacantia) and on “property of none” (res nullius) in early modern Europe, with a focus on the case of the Spanish monarchy between the thirteenth and eighteenth centuries (both in the old and in the new world). After briefly reconstructing the legal debate on the matter, the essay tries to demonstrate how the control over successions was at the centre of competing and conflicting claims, among which that of the “king heir”. In the end, what the analysis of this problem shows is that the discontinuity created by the inability of human beings to manage family and community goods and resources was a constant threat to the corporate membership- based societies of those times. Therefore, a number of corporate bodies and institutions (such as the Spanish Juzgado de bienes de difuntos) were encouraged to mobilize in order to ensure that no patrimony were left without an owner, and that there was always someone responsible for responding to the obligations deriving from the ownership of goods. -

Les Lectures Des Théologiens Moralistes À La Fin Du Xvie
Mémoire 2 professionnel / septembre 2014 Spécialité - cultures de l’écrit et de l’image Mention - sciences de l’information et des bibliothèques Domaine - sciences humaines et sociales Diplôme national de master Professeur d'histoire moderne – UniversitéPhilippe Lyon 2 Martin ENSSIB Conservateur d’État – Bibliothèque cantonaleFabienneSous Henryot de direction la et universitaire de Lausanne / Lucie HUMEAU Gregory Sayer) / Annexes (Jean Benedicti, Francisco de Toledo, moralistes à la fin du XVI Les lectures des théologiens e siècle Droits d’auteurs Cette création est mise à disposition selon le Contrat : Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France disponible en ligne http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/ ou par courrier postal à Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. HUMEAU Lucie | Master 2 CEI | Mémoire de maîtrise | septembre 2014 - 2 - Sommaire SOURCES........................................................................................................................5 TABLE DES ANNEXES...............................................................................................7 TABLE DES MATIÈRES........................................................................................217 HUMEAU Lucie | Master 2 CEI | Mémoire de maîtrise | septembre 2014 - 3 - Sources Les manuels de confession : • BENEDICTI, Jean, La somme des pechez, et le remede d'icevx. Comprenant tous les cas de conscience, & la resolution des doubtes touchant les Pechez, -

Turtas, Raimondo (1988) Umanisti Sassaresi Del '500: Le "Biblioteche" Di Giovanni Francesco Fara E Alessio Fontana
Cadoni, Enzo; Turtas, Raimondo (1988) Umanisti sassaresi del '500: le "biblioteche" di Giovanni Francesco Fara e Alessio Fontana. Sassari, Edizioni Gallizzi. 240 p., 12 p. di tav. (Quaderni di Sandalion, 2). http://eprints.uniss.it/7732/ Documento digitalizzato dallo Staff di UnissResearch Questo li bro avvia un piano mollo ambizioso articolato su duf' diremici: la prima vor· l"!! Enzo Cadoni - Raimondo Turtas rebbe aver ... come punto d 'arrivo la pubblicazion ... di tutti gli inventari librari redatti • in Sardegna nd corso de! XVI secolo, al fine di offrire agli studiosi d ... Ua cultuni scritta n nell'isola un cvrpl/$ il piu possibile completo di tutto il patrimonio librario esistente DI in questo ste s50 periodo in Sard egna. La seconda, che si spera di compl ... tar ...... ntro il 1991, si propone l'edizion ... critica (ormai già avviata) ddle opere di Giovanni Fran· Co cesco Fara, il fondai or... della conoscenza scientifica della storia e della geogr:lfia della g lhnanisti Sassaresi del '500 Sardegna. In particolare questo volume è dedicalO a due ~rsonalità sassaresi eh ... si formarono •• Le -biblioteche. culturalmente prima che nell a nostra ciu à venisse aperto il collegio gesuitico destinato I a diveni are, nei primi dl."CCnni del 1600, l'Università di Sassari. Essi sono r3ppresen· di Giovanni Francesco Fara tativi di un groppo non molto foho di intellettuali sardi che compirono gli studi in ••= e Alessio Fontana uno dei due versanti allora aprrti ai giovani desiderosi di istruzione, quello spagnolo e quello ilaliano. AI primo si rivolse Alessio Fontana che, pur inserilO nella burocrazia imperiale al servizio del principe reggente Filippo e dello stesso imperatore Carlo V, si mantenne costantemente attenlO ai fermenli della cuhura classica del tardo Rinasci mento mediata attraverso la visione erasmbna. -

8 the Ignorant Seller's Liability for Latent Defects: One
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by DSpace at VU 8 The Ignorant Seller’s Liability for Latent Defects: One Regula or Various Sets of Rules? Jan Hallebeek* A. INTRODUCTION B. ROMANLAW (1) Traces of historical developments in the Corpus iuris (2) Justinianic law C. THE ERA OF THE GLOSSATORS (1) Early legal scholarship (2) Placentinus and Johannes Bassianus (3) Azo (4) The last generation of glossators (5) Conclusions (a) Actio empti; actio quanti minoris (b) Praetorian remedies (c) The view of Accursius D. FROM THE GLOSSA ORDINARIA TO THE FOURTEENTH CENTURY (1) Romano-canonical procedure (2) The school of Orleans and Cinus E. THE ERA OF THE COMMENTATORS (1) Liability of the ignorant seller in case oflatent defects (2) The scope of the Aedilician actio quanti minoris (3) Claiming price reduction: one remedy or various sets of rules? F. CONCLUSIONS * The author is grateful to Kees Bezemer (Leiden) and Wim Decock (Leuven) for their comments on a draft version of this paper and to Margaret Hewett (Cape Town) for correcting the English and for further advice. 170 EUP_Cairns_09_Ch8.indd 170 24/02/2010 14:50 the ignorant seller’s liability for latent defects 171 A. INTRODUCTION In 1999 a European Directive was issued that required specific protection for the buyer of consumer goods. This was subsequently implemented in the various European jurisdictions. When repair or replacement of these goods, in the case of non-conformity, is impossible or cannot be demanded or when the seller refuses to provide either of these solutions, the buyer has the remedies of reduction in price and rescission.1 The corresponding liability of the seller does not necessarily depend on explicit warranties, contractual clauses or any kind of malicious intent (mens rea) on his side, but is simply imposed by the law or based on an implied warranty. -

“Talk” on Albanian Territories (1392–1402)
Doctoral Dissertation A Model to Decode Venetian Senate Deliberations: Pregadi “Talk” on Albanian Territories (1392–1402) By: Grabiela Rojas Molina Supervisors: Gerhard Jaritz and Katalin Szende Submitted to the Medieval Studies Department Central European University, Budapest In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Medieval Studies, Budapest, Hungary 2020 CEU eTD Collection To my parents CEU eTD Collection Table of Contents Acknowledgments .................................................................................................................................. 1 List of Maps, Charts and Tables .......................................................................................................... 2 Introduction ............................................................................................................................................ 3 A Survey of the Scholarship ........................................................................................................................... 8 a) The Myth of Venice ........................................................................................................................... 8 b) The Humanistic Outlook .................................................................................................................. 11 c) Chronicles, Histories and Diaries ..................................................................................................... 14 d) Albania as a Field of Study ............................................................................................................. -
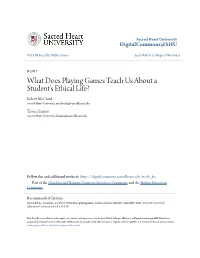
What Does Playing Games Teach Us About a Student's Ethical Life? Robert Mccloud Sacred Heart University, [email protected]
Sacred Heart University DigitalCommons@SHU WCOB Faculty Publications Jack Welch College of Business 9-2017 What Does Playing Games Teach Us About a Student's Ethical Life? Robert McCloud Sacred Heart University, [email protected] Tamara Luarasi Sacred Heart University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.sacredheart.edu/wcob_fac Part of the Graphics and Human Computer Interfaces Commons, and the Higher Education Commons Recommended Citation McCloud, R., & Luarasi, T. (2017). What does playing games teach us about a student's ethical life? Beder University Journal of Educational Sciences 15 & 16, 151-159. This Peer-Reviewed Article is brought to you for free and open access by the Jack Welch College of Business at DigitalCommons@SHU. It has been accepted for inclusion in WCOB Faculty Publications by an authorized administrator of DigitalCommons@SHU. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Volume 15 & 16 BJES “BEDËR”UNIVERSITY Faculty of Philology and Educational Sciences BJES BEDER JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES Volume 15 & 16 SEPTEMBER & DECEMBER 2017 www.bjes.beder.edu.al i Volume 15 & 16 BJES Faculty of Philology and Education at “Beder” University offers Scientific Journal ‘Beder Journal of BJES publishes three issues per year. BJES is blind peer reviewed by the members of editorial board. The main aim of the BJES is to serve the interests of contemporary and specialized academic works about different theories and practices in the education area seeking to promote the analysis of educational issues with social, cultural, technological, political and economical,ect perspectives. BJES welcomes a wide range of original articles, research papers, proposed models, reviews of current literature, book reviews etc. -

Le Vite Dei Dogi, 1423-1474 II
MARIN SANUDO IL GIOVANE LE VITE DEI DOGI 1423-1474 II TOMO 1457-1474 Introduzione, edizione e note a cura di ANGELA CARACCIOLO ARICÒ Trascrizione a cura di CHIARA FRISON Venezia 2004 Direttore della collana FERIGO FOSCARI Venezia La Malcontenta 2004 Tutti i diritti riservati INDICE DEL II TOMO Doge Pasquale Malipiero 3 Doge Cristoforo Moro 32 Doge Nicolò Tron 154 Doge Nicolò Marcello 191 Bibliografia del I e del II tomo – Principali studi e strumenti utilizzati 283 – Fonti edite 288 – Fonti manoscritte 290 Indice dei nomi del I tomo (Serena de Pont) 291 Indice dei nomi del II tomo (Elena Bocchia) 345 “VENETIAE GENIO URBIS” perché non tutto vada perduto A Chiara e ai miei studenti MARIN SANUDO IL GIOVANE LE VITE DEI DOGI 1423-1474 II TOMO 1457-1474 |f. 76v|a) [1457] Pasqualb) Malipiero Doxe fo creado per l’absolucion1 fat- ta nel Conseio d’i X con la Zonta di Francesco Foscari Doxe, non potendo più il Duca exercitar per la vechieza.2 A dì 23 ottubrio et a dì 24 fo chiamado Gran Conseio per dar principio alla elecione, et forno a Conseio zentilomeni circha nu- mero 800; et prima fo fatti li cinque Coretori qualli fo: sier Pollo Tron Procurator sier Christoffollo Moro Procurator questi veneno dopij et non sier Orsato Zustignian Procurator funo balotadi sier Michel Venier Procurator sier Nicolò Bernardo Questi Coretori il zorno drio – a dì 25 – meseno le sue parti,c) qual fo prese, zoè: sopra il terzo capittollo, che il Doxe sia obligatto far justicia, sia azonto: etiam alli nostri suditi; sopra il 333 che il Doxe non apri letere dil Papa, -

Prizrenvenue of Civilizations
PRIZRENVENUE OF CIVILIZATIONS MUNICIPALITY OF PRIZREN Publisher Municipality of Prizren Department for Tourism and Economic Development Editor Samir Karahoda Photos SK-Foto Captions NGO EC Ma Ndryshe Professional consultant Prof. Sokol Cena Design Lum Çeku ISBN 978-9951-636-02-5 © All rights reserved, 2012 October 2012 Content Introduction 6 About Prizren 10 Monuments 18 Religion 46 Art and culture 74 Clothing and folklore 92 Cuisine 102 Nature 112 Information 126 Introduction Foreword This catalogue is another evidence that Prizren possesses a perfect cultural and of cultural development in Prizren. shows the commitment of the local govern- natural heritage. Superimposed in this ment of Prizren for protection of cultural context are the rich cultural life and the well The catalogue is the evidence of the com- and historical values of Prizren and their preserved popular practices of the citizens of mitment of the local government of Prizren promotion in order to cultivate the cul- Prizren. for the comprehensive development of the tural tourism in Prizren. The catalogue was city through cultural tourism. At the same prepared by a group of professionals and The main flaw of all this treasure is the time, it represents the will and commitment it’s a product of an advanced cooperation structured offer to attract the attention of of the culture community in Prizren and between local government, civil society and the visitors. At a time when most touristic the other community groups to promote the professionals. Catalogue aims to increase movements become culturally motivated, cultural content of Prizren. the tourist attractiveness of Prizren through the catalogue you have in your hands comes structured presentation of cultural events. -

I Balcani Romanico E Bizantino
Aleksandra Filipović Aleksandra Filipović I Balcani I Balcani occidentali tra romanico e bizantino e romanico tra occidentali Balcani I occidentali tra romanico e bizantino Tradizione e sperimentazione nell’architettura serba della seconda metà del XII secolo a cura di A.Alberti, F.Romoli a cura di a cura di Alberto Alberti Francesca Romoli FIRENZE PRESSUNIVERSITY EUROP E IN BETWeeN – 1 – EUROPE IN BETWEEN. HISTORIES, CULTURES AND LANGUAGES FROM CENTRAL EUROPE TO THE EURASIAN STEPPES Editor-in-Chief Marcello Garzaniti, University of Florence, Italy Lorenzo Pubblici, srisa, Santa Reparata International School of Art City of Florence, Italy Scientific Board Alberto Alberti, University of Bologna, Italy Maddalena Betti, University of Padua, Italy Ivan Biliarsky, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Marie-Hélène Blanchet, cnrs, French National Centre for Scientific Research, France Nicola Di Cosmo, Institute for Advanced Study, United States Maria Chiara Ferro, Gabriele d’Annunzio University, Italy Pierre Gonneau, Panthéon-Sorbonne Paris 1 University, France Christian Hannick, University of Würzburg, Germany Jakub Niedzwiedz, Jagiellonian University, Poland Antonio Rigo, University of Venice Ca’ Foscari, Italy Francesca Romoli, University of Pisa, Italy Marco Scarpa, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria Giovanna Siedina, University of Florence, Italy Sergejus Temčinas, Institute of the Lithuanian Language, Lithuania Mateo Žagar, University of Zagreb, Croatia Natalja Nikolaevna Zapol’skaja, Lomonosov Moscow State University, Russian Federation Aleksandra Filipović I Balcani occidentali tra romanico e bizantino Tradizione e sperimentazione nell’architettura serba della seconda metà del xii secolo a cura di Alberto Alberti Francesca Romoli FIRENze UNIveRSITY PResS 2020 I Balcani occidentali tra romanico e bizantino : tradizione e sperimentazione nell’architettura serba della se- conda metà del XII secolo / Aleksandra Filipović / a cura di Alberto Alberti, Francesca Romoli. -

The 12Th Congress of South-East European Studies Bucharest, 2-7 September 2019
THE 12TH CONGRESS OF SOUTH-EAST EUROPEAN STUDIES BUCHAREST, 2-7 SEPTEMBER 2019 POLITICAL, SOCIAL AND RELIGIOUS DYNAMICS IN SOUTH-EAST EUROPE / DYNAMIQUES POLITIQUES, SOCIALES ET RELIGIEUSES DANS LE SUD-EST EUROPEEN LIST OF ACCEPTED ABSTRACTS (UNTIL FEBRUARY, 3rd 2019) Elena Gritti (University of Bergamo) Gaudentius’ travel towards Constantinople (Pall. dial. 3,133 - 4,28): a Brixiensis bishop along the sea between the Aegean Sea and Pontus Euxeinos on behalf of theologian bishop Iohannes Chrysostomus Abstract. In the year 406 AD, Gaudentius, bishop of Brixia (nowadays Brescia, in north Italy), took part in an embassy with other four italians bishops, two priests and a diacon. They were sent towards Constantinople by Emperor Honorius and Pope Innocentius I, in order to meet Arcadius, Emperor’s brother, ruler of the eastern part of Roman Empire, asking for a review of the Iohannes Chrysostomus’ condemnation. Chrysostomus, Archbishop of Constantinople in 397 AD, developed a lot of struggles against Arians and was really strict against of abuse of authority by both ecclesiastical and political leaders; so Theophilus, the Patriarch of Alexandria, and Eudoxia, wife of Emperor Arcadius, were able to condemn him to exile in Armenia e then on the bank to Pontus Euxeinos. Palladius, a monk, disciple and hagiographer of Iohannes Chrysostomus, wrote a dialogue about the life of his spiritual teacher, where he described different stages of western religious men’s travel. They were stopped by army officers before Thessalonica (nowadays Salonicco, in -

Le Competenze Canonistiche Di Un Civilista Usura, Questione Ebraica E Conflitti Di Giurisdizione Nei Consilia Di Paolo Da Castro
Università degli Studi di Milano – Bicocca Dottorato in Scienze Giuridiche Curriculum in Storia del diritto medievale e moderno Le competenze canonistiche di un civilista Usura, questione ebraica e conflitti di giurisdizione nei consilia di Paolo da Castro Bernardo Pieri Matr. 775150 XXVIII Ciclo – a. a. 2014/2015 INDICE INTRODUZIONE 1. «Qui fu Castro». Vita Pauli per verba magistri p. 5 2. Sui consilia . L’occhio della storiografia 21 3. Giustificazione del lavoro e modus operandi 26 CAPITOLO I Duæ potestates, duæ iurisdictiones, duo fora sunt – una aequitas 0. Agli albori dell’ utrumque ius 45 1. La sistemazione bartoliana 50 2. La posizione di Baldo: tra implicite conferme e stravaganze 53 3. Per alteram viam . I diversi interessi di due grandi politologi del Trecento: Oldrado da Ponte e Lorenzo Ridolfi 58 4. Paolo da Castro tra enunciazione di principio e mobilità della prassi 63 5. Un contenuto etico nella solutio dei responsi? 70 6. Il foro ecclesiastico come estrema risorsa a tutela delle miserabiles personae 76 7. Altri intrecci, nuovi contrasti: il caso spinoso delle legittimazioni e una prospettiva rovesciata 82 1 CAPITOLO II L’usura, oʃʃ ia economia e morale son due cognate 1. Storia di una polemica secolare 93 2. L’intervento del legislatore ecclesiastico: l’usura da peccato di cupidigia a peccatum secundum se 104 3. Prima eccezione al divieto: la liceità dell’interesse 109 4. L’idea di ‘capitale’ secondo l’ œconomia francescana 113 5. I primi, impacciati interventi della dottrina civilistica 121 6. Bartolo da Sassoferrato: tra velleità e reticenze 125 7. Intermedio I . L’usura tra gli ebrei, fra divieti ed esercizio 133 8. -

6 X 10 Long.P65
Cambridge University Press 978-0-521-83231-1 - The Cambridge History of the Byzantine Empire c. 500-1492 Edited by Jonathan Shepard Index More information INDEX NOTE: Page references in italics refer to maps or illustrations. Material within entries is arranged predominantly alphabetically, although some of the longer entries begin with a chronologically-ordered section, to help orient the reader. Footnotes are only referred to where the subject is not mentioned in the corresponding page of the text. Personal names of Byzantines and other individuals in the early and middle periods are generally listed by first name followed by family name (for example, John Skylitzes rather than Skylitzes, John). For the later period, some (mainly western) individuals are listed by surname (for example, Dandolo, Enrico). Entries for commonly occurring first names are sequenced thus: Byzantine emperors, patriarchs of Constantinople, popes, and then all others in alphabetical order. Aachen 417, 552–3; map 396 Acacius, bishop of Melitene 165 Abaqa, Ilkhan 722 Acciaiuoli, Antonio, duke of Athens 840 Abas Bagratuni, magistros 355 Acciaiuoli, Giovanni, archbishop of Patras 839 al-‘Abbas bin al-Ma’mun 391 Acciaiuoli, Nerio 839–40 al-‘Abbas bin al-Walid 385 Acciaiuoli, Niccolo` 839 Abbasid dynasty 386–92, 881; and Armenia 300, Acciaiuoli family 838, 839–40 348; and Byzantium 392–3, 493, 496; caliphs acclamations 398, 512, 604 917; inception 255–6, 365, 386; jihad 386–7, Acerenza 568; map 561 392–3; and Mongols 721; move capital to Achaemenids 139, 140, 881 Baghdad