Il 1809 Nelle Memorie Di Angelo Michele Negrelli
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

150 Éve Adták Át a Szuezi-Csatornát Az Ókori Csatorna
150 éve adták át a Szuezi-csatornát Dr. Nagy László BME 2019. november 17-én 150 éves a Szuezi-csatorna. Csaknem négyezer év jelenti a Földközi- és Vörös-tenger összekapcsolásának a történelmét. A csatorna terve már az ókorban foglalkoztatta az uralkodókat. Az ókor tudós mérnökei azonban nem egy észak–déli csatorna tervét készítették el, hanem egy nyugat–keleti irányban húzódó csatornáét, amely a Nílus egy új mellékága lett a delta keleti részén, a Vádi Tumiláton keresztül. Bár jó néhány kísérlet történt a helyreállítására, az ókori csatorna azonban többször eliszaposodott, tönkrement. A források szerint i.e. 767-ig többé-kevésbé használatban volt. Az 1840-es években egy észak-déli csatorna megépítésével javasolták a víziút kialakítását. A technikai fejlődés, a politikai lehetőség és nem kis részben a személyes kapcsolatok jelentették ennek a műszaki „csodának“ a megvalósíthatóságát. Talán kevés olyan műszaki létesítmény van, amelyik ilyen nagy hatással lett volna a Földi viszonyokra, és ilyen sok „törődést” igényelt volna. Fitzgerald 1876-ban megjelent könyvében azt írta, hogy a Szuezi nagy csatorna politikai, mérnöki és pénzügyi történet. Ez a megállapítás több, mint száz évvel később is igaz, ennek a hármas tagozódásnak a kialakulását szeretném bemutatni jelen tanulmányban. A szuezi földszoroson át a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel összekötő csatorna gondolata már az ókorban felmerült. A Szuezi-csatorna1 a Sínai-félsziget nyugati részén2 épült tengeri csatorna. Hossza 193,3 km, a legkeskenyebb részén 300 m széles. Ez a mesterséges vízi út Egyiptomban a Földközi-tengeri Port Said és a Vörös-tengeri Szuez városokat köti össze. A csatorna észak-déli irányú vízi szállítást tesz lehetővé Európa és Ázsia között Afrika megkerülése nélkül. -

Die Stellung Des Hafens Triest Und Die Bedeutung Des Österreichischen Lloyd Für Den Transport Aus Der Habsburgermonarchie Nach Übersee1
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE providedwbhr by DSpace 02|2014 at University of West Bohemia Die Stellung des Hafens Triest und die Bedeutung des Österreichischen Lloyd für den Transport aus der Habsburgermonarchie nach Übersee1 ALEŠ SKŘIVAN, Sr. Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University, Prague Nám. J. Palacha 2, 116 38 Prague, Czech Republic Departement of Historical Sciences, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18, 301 24, Plzeň, Czech Republic [email protected] ALEŠ SKŘIVAN, Jr. Department of Economic History, Faculty of Economics, University of Economics, Prague W. Churchill Sq. 4, 130 67 Prague, Czech Republic Departement of Historical Sciences, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18, 301 24, Plzeň, Czech Republic [email protected] Die Position Triests Eine der grundlegenden Voraussetzungen für die Entwicklung der Handelskontakte war die Sicherung des Schiffverkehrs nach Übersee, u. a. auch nach den Fernen Osten. In dieser Hinsicht spielte die Schlüsselrolle 1 Dieser Beitrag ist ein der Ergebnisse der Forschungsbeihilfe, die für den Projekt „Die wirtschaftlichen und politischen Interessen Österreich-Ungarns im Fernen Osten (China, Japan) in den Jahren 1900–1914 die Subventionsagentur der Tschechischen Republik (P 410/11/1634) erteilt hatte. 77 Aleš Skřivan, Sr. – Aleš Skřivan, Jr. Die Stellung des Hafens Triest und die Bedeutung des Österreichischen Lloyd für den Transport aus -
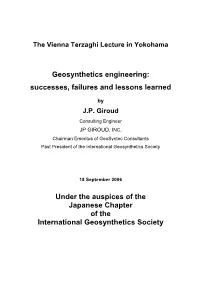
Geosynthetics Engineering: Successes, Failures and Lessons Learned
The Vienna Terzaghi Lecture in Yokohama Geosynthetics engineering: successes, failures and lessons learned by J.P. Giroud Consulting Engineer JP GIROUD, INC. Chairman Emeritus of GeoSyntec Consultants Past President of the International Geosynthetics Society 18 September 2006 Under the auspices of the Japanese Chapter of the International Geosynthetics Society The Vienna Terzaghi Lecture in Yokohama First presentation in Japan of the lecture originally presented by Dr. Giroud in Vienna, Austria, in February 2005 Geosynthetics engineering: successes, failures and lessons learned by J.P. Giroud Consulting Engineer JP GIROUD, INC. Chairman Emeritus of GeoSyntec Consultants Past President of the International Geosynthetics Society 18 September 2006 Presentation of the Vienna Terzaghi Lecture by Professor Heinz Brandl Technical University of Vienna on the next page, followed by biographical note, abstract, lecture notes and copies of all slides, and followed by a technical paper i The 2005 Vienna Terzaghi Lecture By Professor Heinz Brandl of the Technical University of Vienna On 21 and 22 February 2005, the 5th Austrian Geotechnical Conference took place in Vienna, Austria, organized by the ÖIAV (Austrian Society of Engineers and Architects) and the Austrian Member Society of ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) – in cooperation with Members of the IGS (International Geosynthetics Society). This conference takes place in two year intervals and its highlight has always been the “Vienna Terzaghi Lecture,” presented immediately after the opening ceremony. Dr. J.P. Giroud delivered this prestigious lecture choosing the title “Geosynthetics Engineering: Successes, Failures and Lessons Learned,” and he did this in a historical place, in the Festivity Hall of the Palais Eschenbach. -

Alexandria Was Our Destiny Based on the Memories of Marie-Luise Nagel
Alexandria was our Destiny Based on the Memories of Marie-Luise Nagel Bibliotheca Alexandrina Alexandria was our Destiny Based on the Memories of Marie-Luise Nagel Annelies Ismail and Mona Gabriel Translated by Leila Helmy The Austro-Hungarian Community in Alexandria by Carole Escoffey EDITORS Mohamed Awad, Sahar Hamouda & Carole Escoffey The Alexandria and Mediterranean 5 Research Center Monographs Bibliotheca Alexandrina Cataloging-in-Publication Data Ismail, Annelies. Alexandria was our destiny : based on the memories of Marie-Luise Nagel / Annelies Ismail, Mona Gabriel ; translated by Leila Helmy ; edited by Mohamed Awad, Sahar Hamouda, Carole Escoffey. – Alexandria, Egypt : Bibliotheca Alex- andrina, 2011 p. cm. – (The Alexandria and Mediterranean Research Center Monographs ; 5) ISBN 978-977-452-147-4 1. Nagel, Marie-Luise. 2. Alexandria (Egypt) -- Biography. 3. Women -- Biography. I. Gabriel, Mona. II. Helmy, Leila III. Awad, Mohamed. IV. Hamouda, Sahar. V. Escoffey, Carole. VI. Aliksandrina (Library). Alexandria and Mediterranean Research Center. VI. Title VII. Series 920.72 --dc22 20011592490 Photo credits The Bibliotheca Alexandrina wishes to thank the following persons for supplying photographs and illustrations for this publication: Rudolf Agstner xxix; Mohamed Awad xxxi, xxxiii, xxxiv, 139; Abdallah Dawestashy/Alex Med xxxix (top and bottom); Carole Escoffey: xxi, 170. All other photographs and illustrations belong to Marie-Luise Nagel. ISBN 978-977-452-147-4 Dar El Kuttub Depository No. 15612/2011 © 2012 Bibliotheca Alexandrina. NON-COMMERCIAL REPRODUCTION Information in this publication has been produced with the intent that it be readily available for personal and public non- commercial use and may be reproduced, in part or in whole and by any means, without charge or further permission from the Bibliotheca Alexandrina. -

A Camera Obscura by Voigtländer & Son Vienna
Simon Weber-Unger A Camera Obscura by 70 5 Voigtländer & Son Vienna This article treats a camera obscura that, by its provenance, maker and date, can be placed in a direct connection to the early period of Austrian photography and its development . The Changeable Picture our Society in I Description of the camera obscura Figure 1: Made in Vienna, c . 1848, signed on lens “Voigtländer & Sohn / in Wien ”. Mahogany veneer wood corpus, mirror and ground glass (not original), lacquered brass lens with lens hood and brass cap, focussing screw, brass fitted screw-on magnifier glass (fig . 4) . Dimensions: wood box c 25. 3. x 36 .4 x 30 7. cm, total length c .49 cm, lens diameter c 65. mm, focusing screen up to c 22. x 27 cm . Detailed description of the camera obscura’s lens by Dr. Milos Mladek, Vienna The lens of the camera obscura is an optical system of three glasses in two groups with a fixed intermediate diaphragm, mounted in a beautifully-made, sturdy brass barrel engraved „Voigtländer & Sohn in Wien“ . It has rack-and-pinion focusing and renders a sharp image with good contrast and no apparent distortion . As for the optical design: The heart of the system seems to be a positive meniscus in the rear, with a focal length of 12 cm and a fixed diaphragm before it . There is a strongly negative cemented meniscus (consisting of a biconvex lens in front and a biconcave lens behind) in front of these two . The focal length of the whole system is about 25 cm, with an approximate lens register of about 35 cm, the relative aperture is probably about f / 9 . -

J Eijking Experts Without Communities
Experts without communities Internationality, impartiality, and the Suez Canal Abstract How and why has expertise become such a central component of modern global governance? Neither of two dominant IR takes on the topic—functionalist approaches to epistemic communities, and poststructuralist perspectives on governmentality—have offered satisfactory answers to this arguably urgent question. This is because, respectively, epistemic communities emphasise cohesion at the expense of disunity prior to formation; and because governmentality primarily applies to neoliberal polities. Neither travels well in time. To overcome these limitations and constructively bridge the two approaches, this paper suggests a conceptual rethinking based on a surprisingly neglected but pivotal case: the 1855 International Commission on the Isthmus of Suez. Based on original archival research, the paper showcases how modern expert-based global governance emerged in practice. It argues that expert-based global governance should be understood as a practice that constructs “internationality” as a categorical claim to impartiality. What made modern global governance possible was a notion of the international as a depoliticised category. This authorised experts as central agents of international order. Consequently, expert authority is not epistemic by default: the 1855 case shows that political favour can endow experts with authority, a nexus which internationality is then able to mask as impartiality. The nineteenth-century rise of the middle class, scientific internationalism, and informal empire made such masking more desirable than the open admission of political aims. The article thus offers a corrective to existing accounts and a new avenue toward historicising a central practice of modern global governance. Keywords expertise, global governance, epistemic communities, governmentality, Suez Canal Introduction It hardly needs pointing out today that global governance is rife with deference to experts. -

Luigi Negrelli (1799-1858)
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Leonardi, Andrea Article A prominent figure in the creation of the Suez Canal: Luigi Negrelli (1799-1858) The Journal of European Economic History Provided in Cooperation with: Associazione Bancaria Italiana, Roma Suggested Citation: Leonardi, Andrea (2020) : A prominent figure in the creation of the Suez Canal: Luigi Negrelli (1799-1858), The Journal of European Economic History, ISSN 2499-8281, Associazione Bancaria Italiana, Roma, Vol. 49, Iss. 2, pp. 27-70 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/231555 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort -

Österreichische Zeitschrift Für Verkehrswissenschaft - ÖZV (Bis 1989 Verkehrsannalen)
Heft 3-4 66. Jahrgang Österreichische Zeitschrift für Verkehrswissenschaft - ÖZV (bis 1989 Verkehrsannalen) Gedruckt mit Unterstützung unserer Kuratoriumsmitglieder Medieninhaber und Herausgeber: Österreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (ÖVG); 1090 Wien, Kolingasse 13/7, Telefon: +43 / 1 / 587 97 27, Fax: +43/ 1 / 585 36 15 Redaktion: Chefredakteur: Sektionschef Prof. Mag. Dr. Gerhard H. Gürtlich Redaktionsbeirat: ao. Univ. Prof. Dr. Günter Emberger, Univ.-Prof. Dr. Norbert Ostermann, em. Univ.-Prof. Dr. Klaus Rießberger, em. Univ.-Prof. Dr. Gerd Sammer, Dr. Csaba Szèkely, Dr. Karl Frohner, Dr. Karl-Johann Hartig, Florian Polterauer, MBA alle 1090 Wien, Kolingasse 13/7 Redaktion Mag. Thomas Kratochvil, Rebacca Steinacher, BA Hersteller: OUTDOOR PRINT-MANAGEMENT Getreidemarkt 10, 1010 Wien Bezugsbedingungen: Der Bezug der Österreichischen Zeitschrift für Verkehrswissenschaft ist an die Mitgliedschaft bei der ÖVG gebunden. Jahresbeitrag: Jungmitglieder € 18,- ordentliche Mitglieder (Einzelpersonen) € 42,- fördernde Mitglieder € 190,- Unternehmensmitglieder unter 100 Mitarbeiter € 450,- Unternehmensmitglieder über 100 Mitarbeiter € 900,- Kuratoriumsmitglieder € 2.500,- Darüber hinaus kann die Österreichische Zeitschrift für Verkehrswissenschaft zu einem Kaufpreis von € 8,00 je Einzelheft zuzüglich Versandspesen erworben werden. Auskünfte erteilt das Sekretariat der ÖVG, 1090 Wien, Kolingasse 13/7, Telefon: +43 / 1 / 587 97 27, Fax: +43 / 1 / 585 36 15 E-Mail: [email protected], Homepage: www.oevg.at Die Österreichische Zeitschrift -

Bibliographie Der Schweizergeschichte. 2006
W24046_bbl_biblio_ih.qxp 13.7.2009 15:18 Uhr Seite 1 Bibliographie der Schweizergeschichte Bibliographie de l’histoire suisse Bibliografìa della storia svizzera 2006 Herausgegeben von der Schweizerischen Nationalbibliothek, Bern Publiée par la Bibliothèque nationale suisse, Berne Pubblicata dalla Biblioteca nazionale svizzera, Berna 2009 ISSN 0378-4584 W24046_bbl_biblio_ih.qxp 13.7.2009 15:18 Uhr Seite 2 II Redaktion / Pierre Louis Surchat Rédaction / Redazione: Mitarbeit / Karin von Wartburg, Nathalie Vuilleumier Collaboration / Schweizerische Nationalbibliothek / Bibliothèque nationale suisse / Collaborazione: Biblioteca nazionale svizzera Hallwylstrasse 15 CH-3003 Bern E-Mail: [email protected] Online: www.nb.admin.ch/biblio Vertrieb: BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern Fax 031 325 50 58 Internet: www.bundespublikationen.admin.ch Art.-Nr.: 304.548 Diffusion: OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne Fax 031 325 50 58 Internet: www.bundespublikationen.admin.ch No d’article: 304.548 Diffusione: UFCL, Vendita pubblicazioni federali, CH-3003 Berna Fax 031 325 50 58 Internet: www.bundespublikationen.admin.ch No dell’articolo: 304.548 Art. Nr. 304.548.d.f.i 07.09 420 860222358 W24046_bbl_biblio_ih.qxp 13.7.2009 15:18 Uhr Seite 3 III Bemerkungen des Herausgebers Die seit 1913 regelmässig erscheinende Bibliographie der Schweizergeschichte erfasst die im In- und Ausland erschienen Publikationen (Monographien, Sammelschriften, Zeitschriftenartikel und Lizenziatsarbeiten auf allen Arten von Datenträgern) zur Geschichte der Schweiz von der Urzeit bis zur Gegenwart, ohne Berücksichtigung des aktuellen Geschehens. Unter Schweiz versteht sich das Gebiet der Schweiz innerhalb der heutigen Landesgrenzen unabhängig von seiner politischen Zugehörigkeit in früheren Zeiten. Ebenfalls berücksichtigt werden einzelne ausländische Gebiete, die in der Frühen Neuzeit als Untertanenlande einzelner Kantone oder zugewandte Orte mit der Eidgenossenschaft verbunden waren (Veltlin, Bormio, Chiavenna, das heute französiche Chablais und Mülhausen). -

Luigi Negrelli: Oberingenieur Der Ersten Schweizerischen Eisenbahn
Luigi Negrelli: Oberingenieur der ersten schweizerischen Eisenbahn Autor(en): Vischer, Daniel Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt Band (Jahr): 115 (1997) Heft 50 PDF erstellt am: 29.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-79357 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Brücken bau/Baugeschichte Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 50, 11. Dezember 1997 1026 Schlussfolgerungen und Ausblick An der 25. Internationalen Erfindermesse Literatur in Genf wairde das Projekt mit einer [1] Bezzola G.R., und M.: Saltinabrücke Hubbrücken nach dem Prinzip des Goldmedaille ausgezeichnet. Zudem wurde AbeggJ. Jäggi Rekonstruktion des Gegengewichts sind seit langem bekannt und die Hubbrücke von einer Delegation Brig-Glis. -

Kreisamt I 1814-1849 Akten
Vorarlberger Landesarchiv 1/64 Rep. 14-065 Kreisamt I Akten 1814-1849 Kreisamt I 1814-1849 Akten Angelegt von Dr. Ludwig Welti; reingeschrieben von Amalie Bertsch. Schachtel 1 Adelssachen: 1833 Bau: Straßenbau, 1815 Bau: 1822, 1824, 1825 (u. a. Emmebach, Götzis-Altach) 1826, 1827 Schachtel 2 Bau: 1828, Straßenreparatur bei Brugg, Rucksteigstrasse Bau: 1829, Haus- und Straßenbau, Streit zwischen Dornbirn und Lustenau wegen des Stalden- und Mühlbaches, Regulierung des Staldenbaches und des blumischen Schwellwuhrs in Fußach, Hafen- und Dammbauten in Fußach, Brückenbau in Sulz, Austrocknung des Egelsees bei Tosters Schachtel 3 Bau: 1829 Schachtel 4 Bau: 1830 Schachtel 5 Bau: 1831 Schachtel 6 Bau: 1832 Schachtel 7 Bau: 1833 Schachtel 8 Bau: 1835 17.04.2014 Vorarlberger Landesarchiv 2/64 Rep. 14-065 Kreisamt I Akten 1814-1849 Schachtel 9 Bau: 1836 Schachtel 10 Bau: 1837 Schachtel 11 Bau: 1838-1839 Schachtel 12 Bau: 1840-1841 Schachtel 13 Bau: 1842 (Rheindorf Zollhaus) Schachtel 14 Bau: 1842 Schachtel 15 Bau: 1843 (z.B. Nr. 71: Lingenau-Langenegg, Straße; Nr. 127: Arzt- und Feuerlöschhaus in Lustenau; Nr. 1012 Landgericht Dornbirn, Projekt der Verlegung in den Palast von Hohenems; Pläne des Lugerhauses in Dornbirn) Schachtel 16 Bau: 1843 Schachtel 17 Bau: 1844 Schachtel 18 Bau: 1844 17.04.2014 Vorarlberger Landesarchiv 3/64 Rep. 14-065 Kreisamt I Akten 1814-1849 Schachtel 19 Bau: 1845 Schachtel 20 Bau: 1845 Schachtel 21 Bau: 1846 Schachtel 22 Bau: 1846 Schachtel 23 Bau: 1847 Schachtel 24 Bau: 1847 Schachtel 25 Bau: 1848 Schachtel 26 Bau: 1848 Schachtel 27 Bau: 1848 Schachtel 28 Bau: 1848 17.04.2014 Vorarlberger Landesarchiv 4/64 Rep. -
Vienna's Object Collections and Archives a Guide for Historians Of
Vienna’s Object Collections and Archives A Guide for Historians of Science Brooke Penaloza-Patzak (ed.) 2019 i Foreword Knowledge creation and science as such have long histories in the city now known as Vienna, which dates back to the Iron Age and had established itself as center of trade as early as the eleventh century. The University of Vienna, established in 1365, is the oldest university in the German-speaking world. In recent years the internet presence of written and material collections that chronicle the history of knowledge creation in the city of Vienna and its surrounding environs has become increasingly evident and accessible. Digitization projects are rendering more and more collections available to an international audience. Nonetheless, there are a truly overwhelming number of historical collections that Vienna-based historians of science have yet to fully utilize, and that remain virtually unknown to scholars based outside of Vienna. That in mind, this guide is the first step in bringing these collections together for an international audience of researchers interested in the history of the natural and human sciences, and in so doing to hopefully raise awareness about what these archives have to offer for a transnational history of science. This list presented here is far from exhaustive. This edition is the first phase of a longer-term project, and would not have been possible without the support of a number of individuals, in particular Anna Echterhölter. We thank the participants of a course on archival studies in 2019, who have made significant contributions in the form of researching and preparing the archive and collection descriptions, a feature indicated by the names that appear beneath each listing heading.