L'economia Della Camorra. Tra Dimensione Legale E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
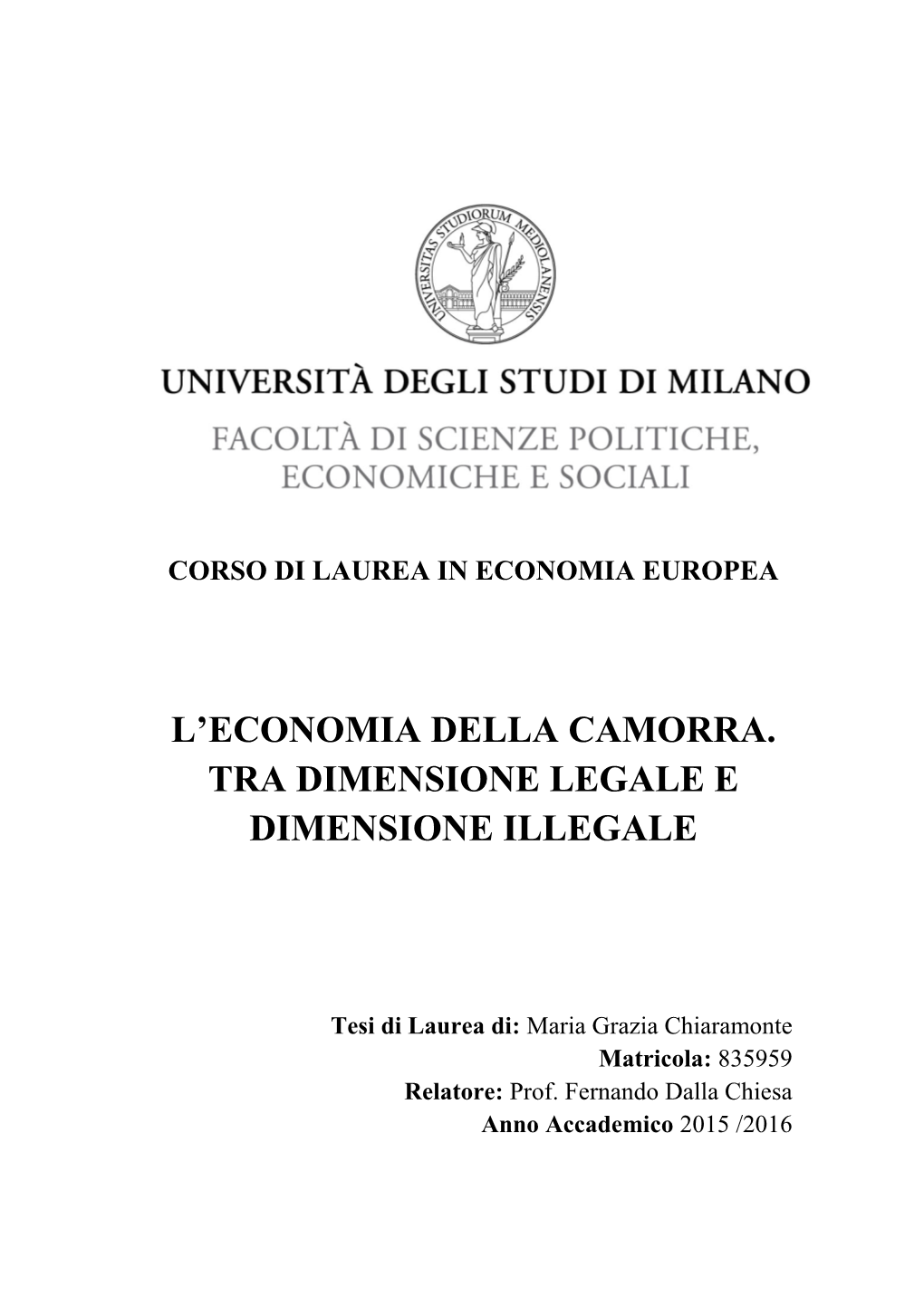
Load more
Recommended publications
-

Condannati Per Camorra, Scarcerati Di Fabio Postiglione SENTENZA SALVATORE D’ABUNDO E GENNARO ESPOSITO
mercoledì 30 marzo 2011 CRONACA DI NAPOLI 3 IL RIESAME GENNARO FERRO, FRATELLO DEL CAPOCLAN GAETANO BENEDUCE, A CASA PER MOTIVI DI SALUTE Traffico di sostanze stupefacenti, ottiene i domiciliari Tre perizie, una lotta estenuante al Riesame e alla fine la decisione di dell’operazione “Penelope” portata a termine dai carabinieri del concedere gli arresti domiciliari nonostante le gravi accuse: comando provinciale di Napoli e della compagnia di Pozzuoli contro associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal affiliati al clan Beneduce-Longobardi. Associazione mafiosa, estorsioni, metodo mafioso. Si tratta di Gennaro Ferro, fratello del capoclan detenzione di armi, tentato omicidi sono i reati contestati a vario titolo Gaetano Beneduce, 60 anni, considerato capo della cosca di Pozzuoli. I ai destinatari dei provvedimenti emessi su richiesta dei pm della Dda di difensori di Ferro, Bruno Carafa e Domenico De Rosa, sono riusciti a Napoli Antonello Ardituro, Gloria Sanseverino e Raffaella Capasso. dimostrare che il loro assistito era assolutamente incompatibile con il L’operazione rappresenta il completamento di una indagine che nel regime carcerario. E così alla fine ci sono riusciti a botta di perizie, ben 2003 portò all'arresto di 40 esponenti della cosca per estorsioni al tre che alla fine hanno dato ragione alla loro tesi. Ferro fu arrestato mercato ittico di Pozzuoli. Sono coinvolti esponenti delle due “famiglie” nella retata che il 24 giugno portò all’azzeramento della cosca che ha che presero il sopravvento nell'area flegrea nel 1997 a conclusione di un terrorizzato per mesi, per anni commercianti e residente della zona sanguinoso scontro con i rivali del clan Sebastiano-Bellofiore. -

Healing the Scars of Forced Migration: an Italian-American Story
RSAJOURNAL 30/2019 LINDSEY N. KINGSTON Healing the Scars of Forced Migration: An Italian-American Story There’s an expression for wishing someone “good luck” in Italian – in bocca al lupo – that literally translates to “in the mouth of the wolf.” I imagine my grandfather’s friends saying this to him as he left his Sicilian village, Grotte, in 1938. The expression would have certainly been fitting for the 17-year-old; the intimidating journey looming before him must have felt like staring down the jaws of a predator. He traveled to America several years after his father and two older brothers, who had saved money and made the necessary arrangements to bring the rest of the family over. Grandpa was not particularly eager to leave Sicily, but his mother and siblings were going with or without him; the decision he faced was between family and homeland. He first went to Naples, where he was awe-struck by the endless rows of ships in port. He had never been to a city before, even to nearby Agrigento to see its famed Greek temples. Yet he had already survived extreme poverty and hunger when he boarded his ship, the SS Roma (where he felt every seasickness-inspiring roll of the ocean, and where he likely spent his eighteenth birthday), so he had endured harder things than the long voyage to New York. He arrived in the United States with one suitcase and the remnants of a handmade guitar that was crushed along the way. He had no real job prospects, no education to speak of, and initially no English skills whatsoever. -

Sul Concetto Di “Contronome” in Gomorra Di Roberto Saviano
ONOMÀSTICA 4 (2018): 49–62 | RECEPCIÓ 7.1.2018 | ACCEPTACIÓ 27.7.2018 Sul conceto di “contronome” in Gomorra di Roberto Saviano Giacomo Giuntoli [email protected] Abstract: Nel 2006 Mondadori pubblica Gomorra, libro di Roberto Saviano che presto diventa un caso editoriale fnendo per varcare anche i confni nazionali. Alcuni fra gli aspeti a torto meno studiati di questo romanzo sono i nomi presenti in esso e un con- ceto che merita di essere con atenzione analizzato, quello di “contronome”, cioè il soprannome che gli afliati alle cosche mafose danno ai membri di spicco. Questo è un conceto fondamentale per comprendere la rifessione onomastica che sta alla base del libro di Saviano. L*obietivo di questo saggio è spiegare questo conceto complesso atraverso alcuni esempi sia onomastici che toponomastici come quelli di Francesco Schiavone, deto “Sandokan” o di Las Vegas, una zona degradata di Napoli Nord che prende il nome dalla famosa cità americana. Parole chiave: Roberto Saviano, onomastica leteraria, toponomastica, “contronome”, soprannome, leteratura italiana On the Concept of “Countername” in Roberto Saviano’s Gomorra Abstract: In 2006 Mondadori published Gomorra, a book by Roberto Saviano that soon became a literary sensation and thanks to which the young Italian writer became fa- mous all over the world. Some of the least studied aspects of this fction are prop- er names and a concept that deserves to be carefully analyzed, that of “contronome” (countername). “Contronome” refers to the nickname that the members of the mafa gangs used to give to their most important members. Tis is a fundamental concept to understand the onomastic refection that underlies Saviano’s book. -

Ercolano, Naples
University of Bath PHD Civil society and the anti-pizzo movement: the case of Ercolano, Naples Bowkett, Chris Award date: 2017 Awarding institution: University of Bath Link to publication Alternative formats If you require this document in an alternative format, please contact: [email protected] General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 07. Oct. 2021 Civil society and the anti-pizzo movement: the case of Ercolano, Naples Christopher Bowkett A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy University of Bath Department of Politics, Languages & International Studies September 2017 COPYRIGHT Attention is drawn to the fact that copyright of this thesis/portfolio rests with the author and copyright of any previously published materials included may rest with third parties. A copy of this thesis/portfolio has been supplied on condition that anyone who consults it understands that they must not copy it or use material from it except as permitted by law or with the consent of the author or other copyright owners, as applicable. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

Commissione Parlamentare D'inchiesta
SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI XIV LEGISLATURA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITA` ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA 73ª SEDUTA MERCOLEDI` 20 LUGLIO 2005 Presidenza del Presidente Roberto CENTARO TIPOGRAFIA DEL SENATO (320) Senato della Repubblica–2– Camera dei deputati XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI INDICE Seguito della discussione del documento su Napoli PRESIDENTE: CENTARO (FI), senatore ..............Pag. 3, 6, 14 e passim BOBBIO (AN), senatore ...............46, ...., ...., e passim DALLA CHIESA (Margh-U), senatore .... 19 FLORINO (AN), senatore ..............37, 43, 57 LUMIA (DS-U), onorevole .............23, 37, 52 e passim NAPOLI Angela (AN), onorevole ........ 43 NOVI (FI), senatore .................. 14 SINISI (Margh-U), onorevole ........... 3, 6 Sull’ordine dei lavori PRESIDENTE: CENTARO (FI), senatore ..............Pag.63 LUMIA (DS-U), onorevole ............. 62 Senato della Repubblica–3– Camera dei deputati XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI I lavori hanno inizio alle ore 20,35. Seguito della discussione del documento su Napoli PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione sul documento di Napoli, sospesa nella seduta del 12 luglio scorso. SINISI. Voglio anzitutto ringraziare la Commissione per avere voluto accogliere la proposta di affrontare la questione riguardante Napoli e la sua Provincia non attraverso una rituale discussione della pura documen- tazione acquisita all’esito delle audizioni, ma affrontando un dibattito, an- che con celerita`. Credo sia doveroso esprimere un ringraziamento per avere accettato questo metodo. Signor Presidente, articolero` il mio intervento in tre parti: la prima riguarda la bozza di relazione che ci e` stata presentata; la seconda con- cerne proposte integrative rispetto alla relazione; la terza parte riguarda proposte specifiche di intervento. -

Analysis of Organized Crime: Camorra
PREGLEDNI ČLANCI UDK 343.974(450) Prihvaćeno: 12.9.2018. Elvio Ceci, PhD* The Constantinian University, New York ANALYSIS OF ORGANIZED CRIME: CAMORRA Abstract: Organized crime is a topic that deserves special attention, not just in criminal science. In this paper, the author analyzes Italian crime organizations in their origins, features and relationships between them. These organizations have similar patterns that we will show, but the main one is the division between government and governance. After the introductory part, the author gives a review of the genesis of the crime, but also of the main functions of criminal organizations: control of the territory, monopoly of violence, propensity for mediation and offensive capability. The author also described other organizations that act on the Italian soil (Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, Napolitan Camora i Apulian Sacra Coroina Unita). The central focus of the paper is on the Napolitan mafia, Camorra, and its most famous representative – Cutolo. In this part of the paper, the author describes this organization from the following aspects: origin of Camorra, Cutulo and the New Organized Camorra, The decline of the New Organized Camorra and Cutolo: the figure of leader. Key words: mafia, governance, government, Camorra, smuggling. INTRODUCTION Referring to the “culturalist trend” in contemporary criminology, for which the “criminal issue” must include what people think about crime, certain analysts study- ing this trend, such as Benigno says, “it cannot be possible face independently to cultural processes which define it”.1 Concerning the birth of criminal organizations, a key break occured in 1876 when the left party won the election and the power of the State went to a new lead- ership. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -

Bardellino, Infatti, Viene Legalizzato E Si Lega Con Il Gruppo All'epoca
Camera dei Deputati —33— Senato della Repubblica XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Bardellino, infatti, viene legalizzato e si lega con il gruppo all’epoca dominante in Sicilia facente capo a Stefano Bontade. Lo stesso Bardellino, coadiuvato dall’altro diarca del clan Mario Iovine, accresce notevolmente il suo peso quando si schiera all’interno della Nuova Famiglia con una posizione anche di preminenza, nella lotta ai cutoliani. I cutoliani che pure erano riusciti a fare proseliti nel casertano vengono completamente annientati – ad eccezione di pochi soggetti, lasciati confluire nelle fila dei casalesi (si v. il gruppo Di Girolamo di Aversa) ed ad eccezione del gruppo operante in Marcianise e zone viciniori di cui si parlera` – ed il gruppo dei casalesi acquisisce la forza sufficiente per porsi come il principale referente di tutte le organiz- zazioni delinquenziali casertane. Con Bardellino nasce una struttura di tipo confederativo; i clan anche operanti in realta` piu` distanti – si pensi a quelli dell’area mondragonese o sessana – vengono di fatto risucchiati nella struttura unitaria, che pur lasciando una sua autonomia alle singole entita`si organizza con una sorta di cupola, il cui centro e` proprio nel gruppo dei casalesi. L’organizzazione camorristica casertana ruoto`, unita e compatta, intorno alla figura di Antonio Bardellino fino alla fine del 1987. E con Bardellino che il clan opera il salto di qualita` e comincia ad intessere significativi rapporti con il mondo della locale politica e delle istitu- zioni, controllando, ad esempio, le attivita` dei comuni di Casale e di San Cipriano. Ai primi del 1988, inizio`, con l’omicidio di Domenico Iovine, all’interno di essa, un conflitto tra i gruppi egemoni facenti capo ad Antonio Bardellino e a Mario Iovine, che culmino` nell’uccisione di Bardellino, nel maggio del 1988, in Brasile, da parte di Mario Iovine. -

Dialecto Y Lengua Regional En Italia. Una Perspectiva Contemporánea
Universidad Pontifica Comillas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Grado en Traducción e Interpretación y Diploma en Comunicación Internacional Trabajo Fin de Grado Dialecto y lengua regional en Italia. Una perspectiva contemporánea. Estudiante: Inés Llavador Bulnes Director: Dr. José Luis Aja Sánchez Madrid, junio 2018 2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 5 1.1 Finalidad y motivos .......................................................................................................................... 5 1.2 Objetivos .......................................................................................................................................... 5 1.3 Metodología ..................................................................................................................................... 6 2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................ 8 2.1 Perspectiva histórica del italiano: el proceso de la unificación lingüística .............................................. 8 2.2 El concepto de variación lingüística ...................................................................................................... 14 2.3 Dialecto, lengua estándar y lengua regional: un punto de confrontación ............................................ 17 2.4 El napolitano. Perspectiva histórica ..................................................................................................... -

L'inferno Dei Viventi Non E` Qualcosa Che Sara`
Camera dei Deputati —8— Senato della Repubblica XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI INTRODUZIONE 1. Viaggio nell’inferno « L’inferno dei viventi non e` qualcosa che sara`; se ce n’e` uno, e` quello che e` gia` qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo piu` . Il secondo e` rischioso e esige attenzione e appren- dimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non e` inferno e farlo durare, e dargli spazio », cosı` Italo Calvino nelle sue « citta` invisibili ». Anche il vasto universo della camorra napoletana si presenta come un inferno e, quel che piu` conta, rende inferno tutto cio` su cui si dispiega e anche in questo caso vi sono due modi per non soffrirne: accettare l’inferno magari negativizzan- dolo in maniera assoluta, senza tentare di indagarne le sue articolate ramificazioni, oppure impegnarsi in una analisi specifica dei suoi tratti caratterizzanti, dei suoi nuclei essenziali, dei suoi nodi fondamentali, perche´ l’inferno sia sempre piu` ridotto e, in prospettiva, eliminato nella sua configurazione e, ancor piu` decisivamente, nelle sue cause. E` questa seconda opzione la scelta che appare necessaria ed urgente, una scelta che non e` solo necessaria ma anche possibile per la corrispondenza e l’alimento che essa certamente ritrova nelle grandi energie del popolo di Napoli e della Campania, nelle risorse anche culturali e morali della citta` e della regione, nelle ricche esperienze di rinnovamento di tante citta` e tanti comuni. -

Characterising the Anthropocene: Ecological Degradation in Italian Twenty-First Century Literary Writing
Characterising the Anthropocene: Ecological Degradation in Italian Twenty-First Century Literary Writing by Alessandro Macilenti A thesis submitted to the Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Italian Literature. Victoria University of Wellington 2015 Abstract The twenty-first century has witnessed the exacerbation of ecological issues that began to manifest themselves in the mid-twentieth century. It has become increasingly clear that the current environmental crisis poses an unprecedented existential threat to civilization as well as to Homo sapiens itself. Whereas the physical and social sciences have been defining the now inevitable transition to a different (and more inhospitable) Earth, the humanities have yet to assert their role as a transformative force within the context of global environmental change. Turning abstract issues into narrative form, literary writing can increase awareness of environmental issues as well as have a deep emotive influence on its readership. To showcase this type of writing as well as the methodological frameworks that best highlights the social and ethical relevance of such texts alongside their literary value, I have selected the following twenty-first century Italian literary works: Roberto Saviano’s Gomorra, Kai Zen’s Delta blues, Wu Ming’s Previsioni del tempo, Simona Vinci’s Rovina, Giancarlo di Cataldo’s Fuoco!, Laura Pugno’s Sirene, and Alessandra Montrucchio’s E poi la sete, all published between 2006 and 2011. The main goal of this study is to demonstrate how these works offer an invaluable opportunity to communicate meaningfully and accessibly the discomforting truths of global environmental change, including ecomafia, waste trafficking, illegal building, arson, ozone depletion, global warming and the dysfunctional relationship between humanity and the biosphere.