Muntagne Noste 2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

COLLEGAMENTO HVDC ITALIA – FRANCIA Denominato “Piemonte - Savoia”
Codifica RVAR10001BSA00613 SINTESI NON TECNICA Rev. 00 Pag. 1 Del 27/04/2015 di 43 COLLEGAMENTO HVDC ITALIA – FRANCIA denominato “Piemonte - Savoia” Variante localizzativa tra i comuni di Bussoleno e Salbertrand al progetto autorizzato con decreto del MSE n.239/EL-177/141/2011 del 07/04/2011 SINTESI NON TECNICA Storia delle revisioni Rev. 00 Del 27.04.2015 Prima emissione Questo documento contiene informazioni di proprietà di Terna Rete Italia SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l’esplicito consenso di Terna Rete Italia SpA Codifica RVAR10001BSA00613 SINTESI NON TECNICA Rev. 00 Pag. 2 Del 10/02/2015 di 43 INDICE 1 PREMESSA .......................................................................................................................................................... 3 2 MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE LOCALIZZATIVA ......................................................................................... 8 3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ................................................................................................................ 10 4 DESCRIZIONE DEL PROGETTO ...................................................................................................................... 12 4.1 SVILUPPO DEL TRACCIATO ....................................................................................................................... 12 4.2 FASI OPERATIVE E GESTIONE DEL CANTIERE -

Ai Sensi Della DGR N° 45-6566 Del 15/07/2002 E Successive Modifiche
COMUNE DI OULX Verifiche di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico (PRGC) ai sensi della D.G.R. n° 45-6566 del 15/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni Sommario 1 PREMESSA......................................................................................................... 3 1.1 La definizione delle aree a diversa pericolosità ....................................................... 4 1.2 Riferimenti normativi .......................................................................................... 6 1.3 La documentazione esistente ............................................................................... 6 1.4 La cartografia di riferimento................................................................................. 7 2 LA RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE (DORA DI CESANA E DORA DI BARDONECCHIA). 7 2.1 Le richieste di integrazioni ................................................................................... 8 2.2 Il modello numerico.......................................................................................... 10 2.3 Geometria impiegata ........................................................................................ 10 2.4 Condizioni al contorno e settaggi di calcolo .......................................................... 13 2.4.1 Portate di riferimento........................................................................................ 13 2.4.2 Scabrezza ....................................................................................................... 20 -

Bumble Bees of the Susa Valley (Hymenoptera Apidae)
Bulletin of Insectology 63 (1): 137-152, 2010 ISSN 1721-8861 Bumble bees of the Susa Valley (Hymenoptera Apidae) Aulo MANINO, Augusto PATETTA, Giulia BOGLIETTI, Marco PORPORATO Di.Va.P.R.A. - Entomologia e Zoologia applicate all’Ambiente “Carlo Vidano”, Università di Torino, Grugliasco, Italy Abstract A survey of bumble bees (Bombus Latreille) of the Susa Valley was conducted at 124 locations between 340 and 3,130 m a.s.l. representative of the whole territory, which lies within the Cottian Central Alps, the Northern Cottian Alps, and the South-eastern Graian Alps. Altogether 1,102 specimens were collected and determined (180 queens, 227 males, and 695 workers) belonging to 30 species - two of which are represented by two subspecies - which account for 70% of those known in Italy, demonstrating the particular value of the area examined with regard to environmental quality and biodiversity. Bombus soroeensis (F.), Bombus me- somelas Gerstaecker, Bombus ruderarius (Mueller), Bombus monticola Smith, Bombus pratorum (L.), Bombus lucorum (L.), Bombus terrestris (L.), and Bombus lapidarius (L.) can be considered predominant, each one representing more than 5% of the collected specimens, 12 species are rather common (1-5% of specimens) and the remaining nine rare (less than 1%). A list of col- lected specimens with collection localities and dates is provided. To illustrate more clearly the altitudinal distribution of the dif- ferent species, the capture locations were grouped by altitude. 83.5% of the samples is also provided with data on the plant on which they were collected, comprising a total of 52 plant genera within 20 plant families. -
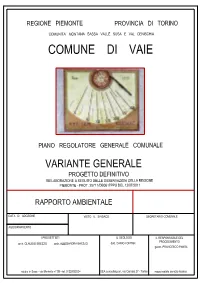
Elab. Rapporto Ambientale.Pdf
RAPPORTO AMBIENTALE QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE IN CUI SI INSERISCE LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DI VAIE ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO: • Adozione Progetto Preliminare – D.C.C. n. 6 del 23-01-2008 • Approvazione Progetto Definitivo – D.C.C. n. 27 del 30-06-2008 • Integrazione alla documentazione - D.C.C. n. 46 del 19-12-2008 • Integrazione alla documentazione - D.C.C. n. 57 del 30-11-2009 QUADRO NORMATIVO • Direttiva 2001/42/CE – 27-06-2001 – introduzione della Valutazione Ambientale Strategica nella normativa europea. Termine di adeguamento 21/07/2004 ( Italia inadempiente) • Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 – procedure per la predisposizione della VAS, della VIA e della Autorizzazione Integrata Ambientale ( i processi avviati posteriormente al 31/07/2007 entrano nella diretta applicazione del Decreto) • D.Lgs. 4/2006 del 16/01/2008 – correzione al D.Lgs. 152/2006 con la sostituzione della parte seconda e modifica del regime transitorio ( in cui rientra il piano di Vaie) • D.G.R. n. 12-8931 del 19/06/2008 - indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure VAS nei piani e nei programmi Il D.Lgs. 152/2006, così come integrato dal D.Lgs. 4/2008, è lo strumento legislativo su cui si basa la programmazione in materia ambientale, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria; in esso sono contenuti i criteri e le procedure per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Con D.G.R. n. 12-8931 del 19/06/2008. La Regione Piemonte conferma gli indirizzi per l’elaborazione del Rapporto Ambientale, identificandoli con i punti dell’allegato f all’art. -

Pdf-Arpa-Games.Pdf
Editorial and publishing coordination Elisa Bianchi Arpa Piemonte, Institutional Communication Images extracted from Arpa Piemonte archives Graphic concept and design La Réclame, Torino Translation Global Target, Torino Printed in December 2006 by Stargrafica, Torino Printed on 100% recycled paper which has been awarded the European Ecolabel ecological quality mark; manufactured by paper mills registered in compliance with EMAS, the EU eco-management and audit system. ISBN 88-7479-047-3 Copyright © 2006 Arpa Piemonte Via della Rocca, 49 – 10123 Torino Arpa Piemonte is not responsible for the use made of the information contained in this document. Reproduction is authorised when the source is indicated. Editorial and publishing coordination Elisa Bianchi Arpa Piemonte, Institutional Communication Images extracted from Arpa Piemonte archives Graphic concept and design La Réclame, Torino Translation Global Target, Torino Printed in December 2006 by Stargrafica, Torino Printed on 100% recycled paper which has been awarded the European Ecolabel ecological quality mark; manufactured by paper mills registered in compliance with EMAS, the EU eco-management and audit system. ISBN 88-7479-041-4 Copyright © 2006 Arpa Piemonte Via della Rocca, 49 – 10123 Torino Arpa Piemonte is not responsible for the use made of the information contained in this document. Reproduction is authorised when the source is indicated. CONTENTS Presentation 9 Preface 11 Contributions 13 Introduction 17 1 Instruments for planning and assessing the impacts 23 1.1 Introduction -

DICAM Costruzioni Idrauliche
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA CIVILE DICAM Costruzioni Idrauliche TESI DI LAUREA in Costruzioni idrauliche e protezione idraulica del territorio LS MODELLO QUASI-BIDIMENSIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DA ESONDAZIONE FLUVIALE NELLA PIANURA PADANA RELATORE: CANDIDATA Prof. Ing. Attilio Castellarin Francesca Carisi CORRELATORI: Dott. Ing. Alessio Domeneghetti Ing. Piero Tabellini Anno Accademico 2010/2011 Sessione III SOMMARIO 1. Introduzione .................................................................................................... 5 2. Caso di studio, dati e strumenti utilizzati ................................................... 11 2.1. Il fiume Po ............................................................................................. 11 2.1.1. Caratteristiche dei principali affluenti del Po ................................ 17 2.1.2. Regime fluviale .............................................................................. 22 2.1.3. Autorità sul Fiume ......................................................................... 30 2.2. Strumenti di analisi di dati georeferenziati: il GIS ............................... 33 2.2.1. Informazione topografica disponibile ............................................ 35 3. Valutazione del rischio idraulico e idrogeologico e classificazione delle fasce fluviali ................................................................................................... 39 3.1. Definizione di rischio -

2021 Giro Virtuale Ride Report 210602
Giro d’Italia Virtuale 2021 had not given much thought to a 2021 Giro d’Italia Virtuale until I was contacted out of the blue via LinkedIn the week before the real Giro I started. “Are you the Pike Talbert who created the Fulgaz Giro d'Italia Virtuale last year at https://fulgaz.com/my-giro-ditalia-virtuale-pike- talbert?” his note began. “If so, I'm wondering if you were going to curate a version 2.0 for the 2021 Giro?” That was all the inspiration I needed! A week later: Tahdah! An initial draft was complete: 21 stages utilising 20 FulGaz rides, 14 of which were new this year—either recently released by FulGaz, or recently discovered by moi. Several iterations later the final version was complete. The Table below provides a comparative Summary. A couple of background comments are worth highlighting: • My Giro last year was mostly about climbing as many of the famous and iconic mountain passes as possible. I have discovered the hard way that this is actually boring (not to mention painful). It turns out that flatter, rolling stages usually contain better scenery—a “smell the roses” approach that favours vistas and seeing more of Italy’s natural beauty over elevation gain and degree of difficulty. Thus, I have inserted more flatter and rolling stages. • Most of the rides I have eliminated in favour of the new ones are longer climbs (i.e., greater than 90 minutes based on videographer time and 3 of the 4 Stelvio-related ascents). It is for this reason that the total time is nearly an hour less than last year. -

Iren Group 1
Iren Group 1 2 Sustainability Report 2015 SUSTAINABILITY IN IREN: HIGHLIGHTS 2015 .................................................................................................... 4 LETTER TO THE STAKEHOLDERS ...................................................................................................................... 6 INTRODUCTION ..................................................................................................................................................... 8 THE IREN GROUP ................................................................................................................................................ 11 ABOUT US ................................................................................................................................................ 12 BUSINESS SEGMENTS ........................................................................................................................... 15 CORPORATE GOVERNANCE ................................................................................................................. 24 STRATEGIES AND POLICIES FOR SUSTAINABILITY ...................................................................................... 31 MISSION, VISION AND VALUES ............................................................................................................. 32 STRATEGIC PLAN 2015-2020 ................................................................................................................. 32 INSTRUMENTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY -

1.4 Analisi Idrometrica
Eventi alluvionali in Piemonte ANALISI METEOROLOGICA ED IDROLOGICA 1.4 ANALISI IDROMETRICA Secondo Barbero, Mariella Graziadei (**), Davide Rabuffetti (**), (**) Collaboratore esterno CSI Piemonte 1.4.1 INTRODUZIONE L’intensità, la persistenza e l’ampia distribuzione spaziale delle precipitazioni hanno generato significative onde di piena sui prin- cipali corsi d’acqua del reticolo idrografico piemontese, che hanno raggiunto carattere di eccezionalità in tutto il settore settentriona- le del bacino del Po, interessando tutti gli affluenti di sinistra sino al Ticino. Vengono evidenziati di seguito i dati di maggior interesse acquisiti dalla strumentazione idrometrica della regione Piemonte, integrata con la rete nazionale del Servizio Idrografico e Mareografico, disponibile in tempo reale ai sensi del protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali del 24/4/1996. Figura 1.39 Rete idrografica con l’ubicazione delle stazioni idrometriche Nel successivo capitolo l’eccezionalità dell’evento sarà evidenzia- ta dal confronto con gli eventi storici. Nella Figura 1.39 è rappre- sentato lo sviluppo della rete idrografica piemontese, con l’ubica- zione delle stazioni di misura disponibili in tempo reale durante l’evento. 45 Eventi alluvionali in Piemonte ANALISI METEOROLOGICA ED IDROLOGICA 1.4.2 L’EVENTO DI PIENA LUNGO LA RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE L’evento alluvionale appare eccezionale sull’intera asta del Po. A Carignano, grazie ai contributi della parte montana del Po, del Pellice e del Chisone, la portata ha superato i 2000 m3/s. Da segnalare la rarità dell’evento sul Chisone dove il tempo di ritorno del picco ha superato il secolo. Ulteriore notevole contributo alla formazione della piena del Po a monte di Torino è stato quello del Sangone per cui tut- tavia non si dispone di dati misurati. -

Maps -- by Region Or Country -- Eastern Hemisphere -- Europe
G5702 EUROPE. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5702 Alps see G6035+ .B3 Baltic Sea .B4 Baltic Shield .C3 Carpathian Mountains .C6 Coasts/Continental shelf .G4 Genoa, Gulf of .G7 Great Alföld .P9 Pyrenees .R5 Rhine River .S3 Scheldt River .T5 Tisza River 1971 G5722 WESTERN EUROPE. REGIONS, NATURAL G5722 FEATURES, ETC. .A7 Ardennes .A9 Autoroute E10 .F5 Flanders .G3 Gaul .M3 Meuse River 1972 G5741.S BRITISH ISLES. HISTORY G5741.S .S1 General .S2 To 1066 .S3 Medieval period, 1066-1485 .S33 Norman period, 1066-1154 .S35 Plantagenets, 1154-1399 .S37 15th century .S4 Modern period, 1485- .S45 16th century: Tudors, 1485-1603 .S5 17th century: Stuarts, 1603-1714 .S53 Commonwealth and protectorate, 1660-1688 .S54 18th century .S55 19th century .S6 20th century .S65 World War I .S7 World War II 1973 G5742 BRITISH ISLES. GREAT BRITAIN. REGIONS, G5742 NATURAL FEATURES, ETC. .C6 Continental shelf .I6 Irish Sea .N3 National Cycle Network 1974 G5752 ENGLAND. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5752 .A3 Aire River .A42 Akeman Street .A43 Alde River .A7 Arun River .A75 Ashby Canal .A77 Ashdown Forest .A83 Avon, River [Gloucestershire-Avon] .A85 Avon, River [Leicestershire-Gloucestershire] .A87 Axholme, Isle of .A9 Aylesbury, Vale of .B3 Barnstaple Bay .B35 Basingstoke Canal .B36 Bassenthwaite Lake .B38 Baugh Fell .B385 Beachy Head .B386 Belvoir, Vale of .B387 Bere, Forest of .B39 Berkeley, Vale of .B4 Berkshire Downs .B42 Beult, River .B43 Bignor Hill .B44 Birmingham and Fazeley Canal .B45 Black Country .B48 Black Hill .B49 Blackdown Hills .B493 Blackmoor [Moor] .B495 Blackmoor Vale .B5 Bleaklow Hill .B54 Blenheim Park .B6 Bodmin Moor .B64 Border Forest Park .B66 Bourne Valley .B68 Bowland, Forest of .B7 Breckland .B715 Bredon Hill .B717 Brendon Hills .B72 Bridgewater Canal .B723 Bridgwater Bay .B724 Bridlington Bay .B725 Bristol Channel .B73 Broads, The .B76 Brown Clee Hill .B8 Burnham Beeches .B84 Burntwick Island .C34 Cam, River .C37 Cannock Chase .C38 Canvey Island [Island] 1975 G5752 ENGLAND. -

Document Pdf ( 1.192
* Le but et les méthodes de la toponymie Gaston Tuaillon Ce texte jusqu’ici non publié se trouve dans les archives de Gaston Tuaillon (*1923 - †2011). Il a servi pour une conférence lors d’un Col- loque de toponymie, en l’honneur de Don Bruno, à Chianocco (Pié- mont), le 16 novembre 2002. Il s’adresse à des spécialistes et amateurs de toponymie et nous semble toujours d’actualité. (Gunhild Hoyer) Le but de la toponymie est de donner un sens aux mots qui n’en ont pas ou plutôt qui n’en ont plus. Quand ils ont donné à tel endroit une désignation précise, les hommes des générations passées savaient que le mot choisi avait un sens qui convenait à ce lieu : pour eux, le nom de lieu était un signe motivé. Cette motiva- tion a duré des siècles et, pour certains toponymes, elle peut être encore conscien- te aujourd’hui ; mais souvent cette motivation s’est éteinte. Si elle a disparu, nous ne comprenons plus le sens des toponymes créés par des hommes intelligents qui organisaient logiquement leur vocabulaire topographique. Nous disons : Mont- Cenis (ou il Cenisio), Rochemelon (ou Rocciamelone, ou Rotséméloun, si nous parlons en patois de Bessans) Susa, Modane, Lanslebourg, Lanzo Torinese et pour nous, ces mots ne signifient rien d’autre que “tel endroit”. Nous acceptons cet arbitraire commode. Le toponymiste le refuse ; son esprit curieux voudrait savoir ce que signifiaient ces mots, au moment de leur création. Trouver le sens perdu du nom de lieu, tel est le but de la toponymie. Pour l’atteindre, les chemins sont divers, car la toponymie n’est pas une scien- ce fondamentale, elle est plutôt une recherche appliquée qui doit s’appuyer sur des connaissances acquises dans d’autres sciences, la géographie, l’histoire et surtout diverses branches de la linguistique, comme la dialectologie et la phonétique évo- lutive. -

In Tema Di Inquinamento Marino • Da Un Convegno Sulla Pioppicoltura • a Proposito Delle Po
3 CROMICHE iMoEConofmcHE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO - Spedizione in abb. postale (IV gr.)/70 - 2° semestre • IN TEMA DI INQUINAMENTO MARINO • DA UN CONVEGNO SULLA PIOPPICOLTURA • A PROPOSITO DELLE PO- TENZIALITÀ EXPORT DEL PIEMONTE • LE COMUNICAZIONI IN VALLE DI SUSA • I RAPPORTI AL CLUB DI ROMA • DUE NUOVE AGENZIE DELLA CASSA DI RISPARMIO TORINO AGENZIA 30 CONCINNATO 256 CASCINE VICA P. REPUBBLICA 17 Due agenzie con tutti i servizi bancari. Tutte le più moderne box blindato per misure di sicurezza: guardia. • servizio Torino di cassa continua Tel. Oli 7395795/6 • ingresso Cascine Vica antirapina con Tel. Oli 9593037 CRT CASSA DI RISPARMIO DI TORINO LA BANCA CHE CRESCE PER VOI. OFFICINE MECCANICHE PONTI &C. 10151 TORINO (ITALY) VIA SANSOVINO 243, int. 40 TELEFONO (011) 7394747 TELEX 220302 PONTI-I PRODUZIONE PRODUCTION FOR THE PRODUCTION PRODUKTION PER IL COMMERCIO COMMERCE AND TRADE POUR LE COMMERCE FUR DEN HANDEL PORTABAGAGLI. LUGGAGE-CARRIERS. PORTE-BAGAGES. DACHGEPACKTRAGER. PORTASCI SKI-CARRIERS. PORTE-SKIS. SKITRAGER. PORTABARCHE. BOAT-CARRIERS. PORTE-CANOTS. BOOTTRAGER. PORTATUTTO ALL-CARRIERS. PORTE-TOUT. ALLESTRAGER. PRODUZIONE PRODUCTION PRODUCTION PRODUKTION PER L'INDUSTRIA FOR THE INDUSTRY POUR L'INDUSTRIE FUR DIE INDUSTRIE STAMPAGGI A FREDDO COLD FORMING REPOUSSAGE A FROID KALTUMFORMUNG (PARAURTI - LAMIERATI). (BUMPERS - PLATES). (PARE-CHOCS - PLAQUES DE (STOSSTANGEN-BLECHTEILE). TRATTAMENTI GALVANICI. GALVANIC PROCESSING. PROTECTION). GALVANISCHE BEHANDLUNGEN. STAMPAGGI TERMOPLASTICI. THERMOPLASTIC FORMING. TRAITEMENTS GALVANIQUES. THERMOPLASTFORMUNGEN. STAMPAGGI PRE-IMPREGNATO. PREIMBUED FORMING. MOULAGES PRE-IMPREGNÉS. VORIMPRÀGNIERTE FORMUNGEN. MACCHINE FORMATRICI BUMPERS-FORMING MACHINES. MACHINES POUR LA PRO- MASCHINEN ZUR HERSTELLUNG PARAURTI. TOOLS FOR PLATES, DUCTION DE PARE-CHOCS. VON STOSSTANGEN. ATTREZZATURE PER THERMOPLASTIC AND OUTILLAGES POUR WERKZEUGE FUR BLECHTEILE, LAMIERATI, TERMOPLASTICI THERMOHARDENING TOLES, THERMOPLASTIQUES THERMOPLAST-UND E TERMOINDURENTI.