COLLEGAMENTO HVDC ITALIA – FRANCIA Denominato “Piemonte - Savoia”
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ai Sensi Della DGR N° 45-6566 Del 15/07/2002 E Successive Modifiche
COMUNE DI OULX Verifiche di compatibilità idraulica delle previsioni dello strumento urbanistico (PRGC) ai sensi della D.G.R. n° 45-6566 del 15/07/2002 e successive modifiche ed integrazioni Sommario 1 PREMESSA......................................................................................................... 3 1.1 La definizione delle aree a diversa pericolosità ....................................................... 4 1.2 Riferimenti normativi .......................................................................................... 6 1.3 La documentazione esistente ............................................................................... 6 1.4 La cartografia di riferimento................................................................................. 7 2 LA RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE (DORA DI CESANA E DORA DI BARDONECCHIA). 7 2.1 Le richieste di integrazioni ................................................................................... 8 2.2 Il modello numerico.......................................................................................... 10 2.3 Geometria impiegata ........................................................................................ 10 2.4 Condizioni al contorno e settaggi di calcolo .......................................................... 13 2.4.1 Portate di riferimento........................................................................................ 13 2.4.2 Scabrezza ....................................................................................................... 20 -
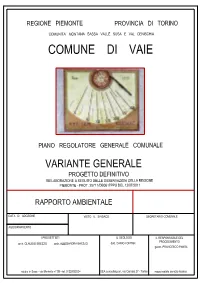
Elab. Rapporto Ambientale.Pdf
RAPPORTO AMBIENTALE QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE IN CUI SI INSERISCE LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DI VAIE ITER DI APPROVAZIONE DEL PIANO: • Adozione Progetto Preliminare – D.C.C. n. 6 del 23-01-2008 • Approvazione Progetto Definitivo – D.C.C. n. 27 del 30-06-2008 • Integrazione alla documentazione - D.C.C. n. 46 del 19-12-2008 • Integrazione alla documentazione - D.C.C. n. 57 del 30-11-2009 QUADRO NORMATIVO • Direttiva 2001/42/CE – 27-06-2001 – introduzione della Valutazione Ambientale Strategica nella normativa europea. Termine di adeguamento 21/07/2004 ( Italia inadempiente) • Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 – procedure per la predisposizione della VAS, della VIA e della Autorizzazione Integrata Ambientale ( i processi avviati posteriormente al 31/07/2007 entrano nella diretta applicazione del Decreto) • D.Lgs. 4/2006 del 16/01/2008 – correzione al D.Lgs. 152/2006 con la sostituzione della parte seconda e modifica del regime transitorio ( in cui rientra il piano di Vaie) • D.G.R. n. 12-8931 del 19/06/2008 - indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure VAS nei piani e nei programmi Il D.Lgs. 152/2006, così come integrato dal D.Lgs. 4/2008, è lo strumento legislativo su cui si basa la programmazione in materia ambientale, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria; in esso sono contenuti i criteri e le procedure per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Con D.G.R. n. 12-8931 del 19/06/2008. La Regione Piemonte conferma gli indirizzi per l’elaborazione del Rapporto Ambientale, identificandoli con i punti dell’allegato f all’art. -

Pdf-Arpa-Games.Pdf
Editorial and publishing coordination Elisa Bianchi Arpa Piemonte, Institutional Communication Images extracted from Arpa Piemonte archives Graphic concept and design La Réclame, Torino Translation Global Target, Torino Printed in December 2006 by Stargrafica, Torino Printed on 100% recycled paper which has been awarded the European Ecolabel ecological quality mark; manufactured by paper mills registered in compliance with EMAS, the EU eco-management and audit system. ISBN 88-7479-047-3 Copyright © 2006 Arpa Piemonte Via della Rocca, 49 – 10123 Torino Arpa Piemonte is not responsible for the use made of the information contained in this document. Reproduction is authorised when the source is indicated. Editorial and publishing coordination Elisa Bianchi Arpa Piemonte, Institutional Communication Images extracted from Arpa Piemonte archives Graphic concept and design La Réclame, Torino Translation Global Target, Torino Printed in December 2006 by Stargrafica, Torino Printed on 100% recycled paper which has been awarded the European Ecolabel ecological quality mark; manufactured by paper mills registered in compliance with EMAS, the EU eco-management and audit system. ISBN 88-7479-041-4 Copyright © 2006 Arpa Piemonte Via della Rocca, 49 – 10123 Torino Arpa Piemonte is not responsible for the use made of the information contained in this document. Reproduction is authorised when the source is indicated. CONTENTS Presentation 9 Preface 11 Contributions 13 Introduction 17 1 Instruments for planning and assessing the impacts 23 1.1 Introduction -

DICAM Costruzioni Idrauliche
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA CIVILE DICAM Costruzioni Idrauliche TESI DI LAUREA in Costruzioni idrauliche e protezione idraulica del territorio LS MODELLO QUASI-BIDIMENSIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DA ESONDAZIONE FLUVIALE NELLA PIANURA PADANA RELATORE: CANDIDATA Prof. Ing. Attilio Castellarin Francesca Carisi CORRELATORI: Dott. Ing. Alessio Domeneghetti Ing. Piero Tabellini Anno Accademico 2010/2011 Sessione III SOMMARIO 1. Introduzione .................................................................................................... 5 2. Caso di studio, dati e strumenti utilizzati ................................................... 11 2.1. Il fiume Po ............................................................................................. 11 2.1.1. Caratteristiche dei principali affluenti del Po ................................ 17 2.1.2. Regime fluviale .............................................................................. 22 2.1.3. Autorità sul Fiume ......................................................................... 30 2.2. Strumenti di analisi di dati georeferenziati: il GIS ............................... 33 2.2.1. Informazione topografica disponibile ............................................ 35 3. Valutazione del rischio idraulico e idrogeologico e classificazione delle fasce fluviali ................................................................................................... 39 3.1. Definizione di rischio -

Iren Group 1
Iren Group 1 2 Sustainability Report 2015 SUSTAINABILITY IN IREN: HIGHLIGHTS 2015 .................................................................................................... 4 LETTER TO THE STAKEHOLDERS ...................................................................................................................... 6 INTRODUCTION ..................................................................................................................................................... 8 THE IREN GROUP ................................................................................................................................................ 11 ABOUT US ................................................................................................................................................ 12 BUSINESS SEGMENTS ........................................................................................................................... 15 CORPORATE GOVERNANCE ................................................................................................................. 24 STRATEGIES AND POLICIES FOR SUSTAINABILITY ...................................................................................... 31 MISSION, VISION AND VALUES ............................................................................................................. 32 STRATEGIC PLAN 2015-2020 ................................................................................................................. 32 INSTRUMENTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY -

1.4 Analisi Idrometrica
Eventi alluvionali in Piemonte ANALISI METEOROLOGICA ED IDROLOGICA 1.4 ANALISI IDROMETRICA Secondo Barbero, Mariella Graziadei (**), Davide Rabuffetti (**), (**) Collaboratore esterno CSI Piemonte 1.4.1 INTRODUZIONE L’intensità, la persistenza e l’ampia distribuzione spaziale delle precipitazioni hanno generato significative onde di piena sui prin- cipali corsi d’acqua del reticolo idrografico piemontese, che hanno raggiunto carattere di eccezionalità in tutto il settore settentriona- le del bacino del Po, interessando tutti gli affluenti di sinistra sino al Ticino. Vengono evidenziati di seguito i dati di maggior interesse acquisiti dalla strumentazione idrometrica della regione Piemonte, integrata con la rete nazionale del Servizio Idrografico e Mareografico, disponibile in tempo reale ai sensi del protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali del 24/4/1996. Figura 1.39 Rete idrografica con l’ubicazione delle stazioni idrometriche Nel successivo capitolo l’eccezionalità dell’evento sarà evidenzia- ta dal confronto con gli eventi storici. Nella Figura 1.39 è rappre- sentato lo sviluppo della rete idrografica piemontese, con l’ubica- zione delle stazioni di misura disponibili in tempo reale durante l’evento. 45 Eventi alluvionali in Piemonte ANALISI METEOROLOGICA ED IDROLOGICA 1.4.2 L’EVENTO DI PIENA LUNGO LA RETE IDROGRAFICA PRINCIPALE L’evento alluvionale appare eccezionale sull’intera asta del Po. A Carignano, grazie ai contributi della parte montana del Po, del Pellice e del Chisone, la portata ha superato i 2000 m3/s. Da segnalare la rarità dell’evento sul Chisone dove il tempo di ritorno del picco ha superato il secolo. Ulteriore notevole contributo alla formazione della piena del Po a monte di Torino è stato quello del Sangone per cui tut- tavia non si dispone di dati misurati. -

Effetti Delle Infrastrutture Sulla Distribuzione E Sulla Mortalità Del Lupo in Alta Valle Di Susa (Torino)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi Tesi di Laurea Magistrale in Conservazione e Biodiversità animale Classe di laurea 6/S Effetti delle infrastrutture sulla distribuzione e sulla mortalità del lupo in Alta Valle di Susa (Torino). Candidato: Relatore: Domenica Perrone Francesca Marucco Correlatore: Elisa Avanzinelli Anno Accademico 2016-2017 A Edo e ai nostri figli, Daniele e Zoe Indice Riassunto ......................................................................................................................... 5 Abstract ........................................................................................................................... 6 1. INTRODUZIONE ..................................................................................................... 7 1.1 Aspetti generali del processo di ricolonnizzazione delle Alpi e stato attuale della popolazione alpina di lupo .................................................................................... 8 1.2 I Progetti di monitoraggio sulle Alpi Occidentali: il Progetto Lupo Piemonte e Life Wolfalps ............................................................................................. 10 1.3 Aspetti genetici del processo di espansione della specie dagli Appennini verso le Alpi e cenni sul trend della popolazione alpina .......................................... 12 1.4 Mortalità e cause di mortalità della popolazione di lupo riscontrate sulle Alpi Occidentali ............................................................................................................ -

Bilancio Di Esercizio 2016
SOCIETA’ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016 Susa, 10 marzo 2015 S.I.T.A.F. S.p.A. Capitale Sociale interamente versato in Euro 65.016.000,00 Situazione ripartizione capitale sociale al 10 marzo 2015 IMPORTO AZIONISTI AZIONI CAPITALE % POSSEDUTE VERSATO IN EURO ANELLO FRANCESCO 7.500 38.700,00 0,0595% ANELLO GIOVANNI 7.500 38.700,00 0,0595% ANAS S.p.A. 6.437.637 33.218.206,92 51,0924% AUTOSTRADA ALBENGA-GARESSIO-CEVA S.p.A. 8.682 44.799,12 0,0689% Aut. Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.A. (A.T.I.V.A.) 136.111 702.332,76 1,0802% SIAS S.p.A. 4.602.895 23.750.938,20 36,5309% S.C.C. srl 15.000 77.400,00 0,1190% FANTINI ROBERTO 5.000 25.800,00 0,0397% INDUSTRIALCAP S.r.l. 75.000 387.000,00 0,5952% I.C.F.A. S.r.l. 5.000 25.800,00 0,0397% ITS S.p.A. 1.250 6.450,00 0,0099% MATTIODA PIERINO & FIGLI AUTOSTRADE S.r.l. 1.284.157 6.626.250,12 10,1917% S.T.I. S.r.l. in liquidazione 1.250 6.450,00 0,0099% GI.CA S.r.l. 2.500 12.900,00 0,0198% BATTAGLIO MARIA 173 892,68 0,0014% STOPPINO ELISABETTA 173 892,68 0,0014% STOPPINO GIOVANNI BATTISTA 172 887,52 0,0014% VIGOFIN S.a.s. di Ada Valle & C. -

Il Tiglio Di Oulx
IL TIGLIO DI OULX Caratteristiche Specie: Tilia cordata Mill. Famiglia: Tiliaceae Circonferenza (a petto d’uomo): 522 m Altezza: 24 m Età presunta: > 200 anni Descrizione aspetto di monumentalità: Impalcato su tre rami. Pianta imponente. Come arrivare L’albero di Tiglio monumentale è facilmente ritrovabile e ben segnalato. Arrivati a Oulx imboccare la strada in direzione del monte Cotolivier, che si trova vicino al ponte che collega le due parti del paese. L’ampio panorama verso la salita del Cotolivier 1 Dopo circa un chilometro c’è il cartello che indica i periodi di apertura della strada stessa (che è chiusa al traffico veicolare in inverno, ma sempre percorribile a piedi). Una volta imboccata la strada, dopo un altro chilometro, si trova il primo tornante, in corrispondenza del quale vi è l’indicazione per la borgata abbandonata di Villaretto: lasciare qui l’auto e proseguire a piedi. Con una rapida camminata in piano e priva di difficoltà, si giunge al villaggio di Villaretto (Viarerè in Occitano), una graziosa borgata alpina ormai abbandonata, situata a 1260 metri di altitudine, ai margini del magnifico bosco delle Grandi Pertiche. Prima di giungere al villaggio, si può notare la frana del Rio Grande Combe, che interessa il settore superiore del Cotolivier ed è dovuta a fenomeni di erosione torrentizia. Il dissesto è classificabile come frana per colamento lento ed è caratterizzato da un punto centrale, corrispondente al letto del torrente, che subisce deformazioni continue a causa del deposito dei detriti. Superato il villaggio, dove si trova la piccola cappella settecentesca dedicata a Sant’Adele e a San Giovanni Battista, occorre proseguire per circa 200 metri diritti sulla pista e si scorgerà l’albero, segnalato da una palina in legno, al margine di un prato. -

Scarica Il Documento
COMUNE DI OULX (PROVINCIA DI TORINO) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 OGGETTO: Progetto di variante del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del Fiume Dora Riparia. Integrazione osservazioni di cui alla deliberazione C.C. n. 36/06 con proposta di definizione delle fasce fluviali. L’anno duemilasette addì dodici del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono Presenti i Signori: N. Cognome e nome Presente Assente 1. CASSI Mauro Sindaco X 2. ROUSSET Elio Vice Sindaco X 3. BELTRAME Roberto Consigliere X 4. MASCIA Massimiliano Consigliere X 5. QUARTA Rita Consigliere X 6. SIGOT Laura Consigliere X 7. VALLONE Francesco Consigliere X 8. FREZET Davide Consigliere X 9. TERZOLO Paolo Consigliere X 10. DE MARCHIS Paolo Consigliere X 11. PIACENTINI Maurizio Consigliere X 12. AMBROSIANI Massimino Consigliere X 13. VITTON Mauro Gaetano Consigliere X Assiste il Segretario Comunale: BONITO dott.ssa Michelina. Il Signor CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. Esce dall’aula il consigliere Beltrame Roberto – presenti: n. 10 IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che la Regione Piemonte – Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. 3529 del 12.06.2006, pervenuta il 15.06.2006 ns. prot. 7732, ha comunicato l’adozione, da parte del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Fiume Po, con deliberazione n. -

POLITECNICO DI TORINO Repository ISTITUZIONALE
POLITECNICO DI TORINO Repository ISTITUZIONALE Catalogo delle portate massime annuali al colmo dal bacino occidentale del Po Original Catalogo delle portate massime annuali al colmo dal bacino occidentale del Po / Barbero, Secondo; Graziadei, Mariella; Zaccagnino, Milena; Salandin, Alessio; Claps, Pierluigi; Laio, Francesco; Ganora, Daniele; Radice, Roberta. - (2012). Availability: This version is available at: 11583/2624190 since: 2015-11-26T14:47:01Z Publisher: Published DOI: Terms of use: openAccess This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository Publisher copyright (Article begins on next page) 04 August 2020 INDICE Premessa 8 Procedura di revisione dati storici del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale 9 Procedure di stima delle piene rilevate dalla rete idrometrica regionale 12 Criteri di ricostruzione delle portate massime annue affluite ai serbatoi artificiali 13 Guida alla lettura del catalogo 16 Ringraziamenti e Bibliografia 21 ELENCO SCHEDE Agogna a Novara 22 Artanavaz a Saint Oyen 24 Ayasse a Champorcher 26 Banna a Santena 28 Belbo a Castelnuovo Belbo 30 Borbera a Baracche 32 Borbore a San Damiano d’Asti 34 Bormida a Cassine (presa canale Carlo Alberto) 36 Bormida ad Alessandria 38 Bormida di Mallare a Ferrania 40 Bormida di Millesimo a Cessole 42 Bormida di Millesimo a Murialdo 44 Bormida di Spigno a Mombaldone 46 Bormida di Spigno a Valla 48 Bousset a Tetti Porcera 50 Breuil ad Alpette 52 Bucera a Ponte Rovine 54 Buthier a Place -

Névache – Bardonecchia – Modane
COUV NEVACHE 11/01/07 16:37 Page 1 799 NÉVACHE – BARDONECCHIA – MODANE NÉVACHE – BARDONECCHIA – par MODANE J.-C. BARFÉTY, R. POLINO, D. MERCIER, R. CABY, J.-C. FOURNEAUX La carte géologique à 1/50 000 NÉVACHE – BARDONECCHIA – MODANE est recouverte par les coupures suivantes de la Carte géologique de la France à 1/80 000 : au Nord-Ouest : SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (N° 179) au Nord-Est : BONNEVAL – TIGNES (N° 179 bis) au Sud-Ouest : BRIANÇON (N° 189) Saint-Jean- Modane Lanslebourg de-Maurienne NÉVACHE La Grave Saint- BRGM Christophe- Briançon SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL en-Oisans B.P. 36009 - 45060 ORLÉANS CEDEX 2 - FRANCE COUV NEVACHE11/01/0716:37Page2 R. WYNS D. MARQUER,P.NEHLIG,ROSSI,J.THIERRY,VASLET, F. HANOT,P.LEDRU,J.LEMÉTOUR,MARCOUX, D. GRANDPERRIN,P.GUENNOC,F.GUILLOCHEAU, T. BAUDIN,M.BRUNEL,J.-L.DURVILLE,FAURE, Secrétaire Général Président COMITÉ DE LA CARTE GÉOLOGIQUE COMITÉ DELACARTE Les recommandationspourfaireréférence àcedocument : J.-M.LARDEAUX; SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL GÉOLOGIQUE SERVICE 20 cm se trouventenpage2delanotice 10 Km : D.JANJOU; DE LAFRANCE 19 BRGM 9 18 Vice-Président Membres 17 8 16 : J.DUBREUILH; : J.-P.BARBEY, 15 7 14 13 6 12 11 5 10 omissions qu’ilsaurontpuconstater. géologique national(SecrétariatdelaCartegéologique)leserreursou chelle 1/50 000 9 É Il seratenucomptedeleursobservationsdanslaprochaineédition. Les utilisateursdecettecartesontpriésfaireconnaîtreau 4 8 7 Achevé d’imprimerpar par OUDINImprimeur Dépôt légalN° 1832 Poitiers (France) 3 6 Décembre 2006 5 Texte vectorisé I O. U D I N S N R I O. U D I N S N O R M O M M M E E E V E M I V T 2 4 M N A .