Cosa Nostra, La Trattativa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
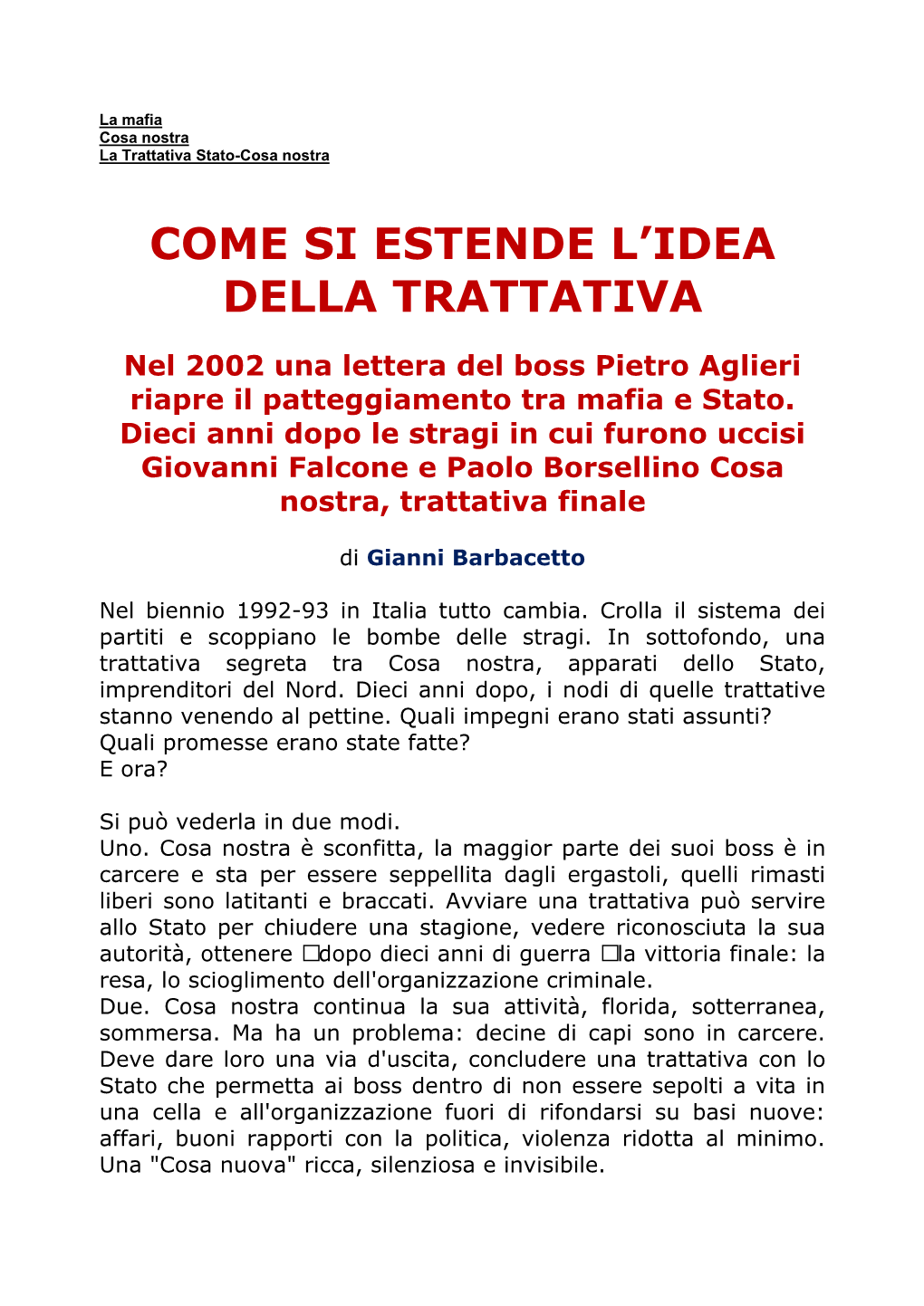
Load more
Recommended publications
-

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

Le Mani Della Criminalità Sulle Imprese, 2011
Le mani della criminalità sulle imprese XIII Rapporto di Sos Impresa Aliberti Editore SosImpresa.indd 5 09/11/11 12:18 © 2011 Aliberti editore Tutti i diritti riservati Sede legale: Via dei Cappuccini, 27 - 00187 Roma Sede operativa: Via Meuccio Ruini, 74 - 42124 Reggio Emilia Tel. 0522 272494 Fax 0522 272250 - Ufficio Stampa 329 4293200 Aliberti sul web: www.alibertieditore.it blog.alibertieditore.it [email protected] SosImpresa.indd 6 09/11/11 12:18 A Libero Grassi, nel ventennale della scomparsa SosImpresa.indd 7 09/11/11 12:18 SosImpresa.indd 8 09/11/11 12:18 Il Rapporto di Sos Impresa Le mani della criminalità sulle imprese è frutto di numerosi apporti e collaborazioni senza i quali non sarebbe stato possibile realizzarlo. Un ringraziamento particolare va a Danila Bellino, Laura Galesi, Massi- mo Giordano, Nino Marcianò, Marcello Ravveduto, Valeria Scafetta e Ga- briella Sensi. I testi sono di Lino Busà e Bianca La Rocca. I dati che forniamo sono nostre elaborazioni sulla base delle statistiche Istat, delle rilevazioni fornite dal Ministero dell’Interno, dei sondaggi condotti da Swg per Confesercenti, delle ricerche del Centro Studi TEMI e delle numerose informazioni e testimo- nianze raccolte da Sos Impresa. Il Rapporto come sempre contiene molti nomi di persone, aziende, luo- ghi. Nomi presenti nelle inchieste giudiziarie, nelle relazioni degli organismi antimafia e delle Forze dell’ordine, nelle cronache giornalistiche. Per tutti coloro che sono chiamati in causa, eccezion fatta per quelli condannati in via definitiva, valgono la presunzione d’innocenza e le garanzie individuali costituzionalmente garantite. 9 SosImpresa.indd 9 09/11/11 12:18 Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia Quali sono le ragioni dell’inaudita potenza di alcuni? Dov’è la forza che assicura l’impunità ai loro delitti? Si chiede se sono costituiti in associazio- ni, se hanno statuti, pene per punire i membri traditori: tutti rispondono che lo ignorano, molti che non lo credono. -

Nomi E Storie Delle Vittime Innocenti Delle Mafie
Nomi e storie delle vittime innocenti delle mafie a cura di Marcello Scaglione e dei ragazzi del Presidio “Francesca Morvillo” di Libera Genova Realizzato in occasione della mostra “900 Nomi vittime di mafia dal 1893 ad oggi” inaugurata ad Imperia il 21 Marzo 2016 in occasione della XXI Giornata della memoria e dell’impegno - ”Ponti di memoria, luoghi di impegno”. I nomi presenti nella mostra sono quelli accertati fino all'anno 2015, ed in particolare quelli letti a Bologna durante la XX Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo 2015). Il lavoro di ricerca, inizialmente limitato a quell'elenco, è stato poi implementato e aggiornato, comprendendo quindi le storie delle vittime innocenti i cui nomi sono stati letti durante la XXI Giornata della Memoria e dell'Impegno (21 marzo 2016). Sarà nostro impegno e cura eseguire successivamente gli aggiornamenti necessari. Siamo inoltre disponibili a intervenire sulle singole storie, laddove dovessero essere ravvisati errori e/o imprecisioni. EMANUELE NOTABARTOLO, 01/02/1893 Nato in una famiglia aristocratica palermitana, presto rimane orfano di entrambi i genitori. Cresciuto in Sicilia, nel 1857 si trasferisce prima a Parigi, poi in Inghilterra, dove conosce Michele Amari e Mariano Stabile, due esuli siciliani che lo influenzeranno molto. Avvicinatosi all'economia e alla storia, diventa sostenitore del liberalismo conservatore (quindi vicino alla Destra storica). Dal 1862 Emanuele Notarbartolo diventa prima reggente, poi titolare, del Banco di Sicilia, al quale si dedica a tempo pieno a partire dal 1876, salvandolo dal fallimento in seguito all'Unità d'Italia. Il suo lavoro al Banco di Sicilia inizia a inimicargli molta gente. -

Processo Lima
CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

Il Giornale Di Sicilia
Confcommercio Sicilia Via Emerico Amari 11. - 90139 Palermo (PA) Tel. 091 323420 - Fax 091 6110891 - web: www.confcommerciosicilia.it - e-mail: [email protected] Rassegna Stampa Il giornale di Sicilia Venerdì 17 Giugno 2011 pagina 21 MAFIA E RACKET, DIECI CONDANNE PER OLTRE UN SECOLO DI CARCERE Le condanne sono dieci, le pene pesanti: 117 anni in tutto. Per molti si tratta di un ulteriore aggravamento di precedenti decisioni: così è per Gioacchino Corso, ad esempio. Lui era già stato condannato, il 30 ottobre 1998, per avere appoggiato la latitanza e fatto da braccio operativo del boss Pietro Aglieri. Ora il giudice Lorenzo Jannelli, nell'operazione «Paesan Blues», col rito abbreviato gli ha dato in totale 22 anni, applicando il meccanismo della «continuazione» rispetto alla prima condanna. Il concetto rimanda proprio all'idea di continuità con i reati contestati 13 anni fa. Poco cioè è cambiato per Ino Corso, ritenuto colpevole dal Gup, ieri, nel processo «Paesan Blues». Anzi è andato avanti nella sua carriera dentro Cosa nostra. Perché ha coltivato pure rapporti con le cosche italoamericane. Perché ha organizzato estorsioni. Perché ora è diventato capo del mandamento di Santa Maria di Gesù, da semplice uomo d'onore che era. Condanne rilevanti, significative. Pure per Giuseppe Lo Bocchiaro c'è la continuazione con un'altra condanna, pronunciata appena cinque anni fa: il Gup ieri gli ha dato 20 anni complessivi. Continuazione pure per il fratello di Corso, Gianpaolo: per lui gli anni sono 12, così come per Giovanni Lo Verde e Francesco Guercio. Quattro le condanne a otto anni e otto mesi: riguardano Massimo Mancino, Girolamo Rao, Giovanni Burgarello e Ignazio Traina. -

Commissione Parlamentare D'inchiesta
SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI XIV LEGISLATURA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITA` ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA 51ª SEDUTA MARTEDI` 16 MARZO 2004 Presidenza del Presidente Roberto CENTARO TIPOGRAFIA DEL SENATO (360) Senato della Repubblica–2– Camera dei deputati XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI INDICE Comunicazioni del Presidente PRESIDENTE: – CENTARO (FI), senatore ............Pag. 3 Sul rapimento dell’onorevole Aldo Moro e la strage di via Fani PRESIDENTE: – CENTARO (FI), senatore ............Pag. 3 SINISI (Mar.DL-U), deputato ........... 3 Audizione del Direttore del Servizio Centrale operativo della Polizia di Stato dottor Luciano Carluccio, del Comandante del Raggruppamento operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri generale Giampaolo Ganzer e del Comandante del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalita` Organizzata della Guardia di Finanza generale Sergio Bosco PRESIDENTE: CARLUCCIO .......................Pag. 4, 25 – CENTARO (FI), senatore ............Pag. 3, 8, 13 e passim GANZER .......................... 8, 27 BRUTTI Massimo (DS-U), senatore .......23, 32 BOSCO ........................... 12 DIANA (DS-U), deputato .............. 22 LUMIA (DS-U), deputato .............. 18 MANZIONE (Mar.DS-U), senatore .......14, 28, 30 e passim NAPOLI Angela (AN), deputato ......... 17 TAORMINA (FI), deputato ............30, 31, 32 e passim VENDOLA (RC), deputato ............. 16 Senato della Repubblica–3– Camera dei deputati XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI I lavori hanno inizio alle ore 10,40. Comunicazioni del Presidente PRESIDENTE. Comunico che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha designato, quali nuovi componenti del Comi- tato su Portella delle Ginestre, gli onorevoli Bricolo e Sinisi e, quali nuovi componenti del Comitato sull’omicidio Alfano, il senatore Peruzzotti e l’onorevole Sinisi. -

Digest of Terrorist Cases
back to navigation page Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org Digest of Terrorist Cases United Nations publication Printed in Austria *0986635*V.09-86635—March 2010—500 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna Digest of Terrorist Cases UNITED NATIONS New York, 2010 This publication is dedicated to victims of terrorist acts worldwide © United Nations Office on Drugs and Crime, January 2010. The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. This publication has not been formally edited. Publishing production: UNOV/DM/CMS/EPLS/Electronic Publishing Unit. “Terrorists may exploit vulnerabilities and grievances to breed extremism at the local level, but they can quickly connect with others at the international level. Similarly, the struggle against terrorism requires us to share experiences and best practices at the global level.” “The UN system has a vital contribution to make in all the relevant areas— from promoting the rule of law and effective criminal justice systems to ensuring countries have the means to counter the financing of terrorism; from strengthening capacity to prevent nuclear, biological, chemical, or radiological materials from falling into the -

«Così Abbiamo Catturato Il Boss Mi Ha Detto: Sì, Sono Pietro Aglieri»
08INT02A0806 ZALLCALL 11 21:34:39 06/07/97 LE CRONACHE l’Unità 13 Domenica 8 giugno 1997 Il numero uno di Cosa Nostra è stato fotografato da una collina, poi nella notte un confronto al computer Altri 5 in carcere «Così abbiamo catturato il boss Decapitati i vertici Mi ha detto: sì, sono Pietro Aglieri» genovesi Il capo della Mobile Luigi Savina racconta il blitz nel covo della Dia PALERMO «Pietro Aglieri ti di- no. Quella notte la tensione era a perdere le sue tracce. Solo alle 10 GENOVA. L’accusaèquelladiunage- chiariamo in arresto.». E lui: «sì. mille. Ci bruciavano gli occhi. in punto abbiamo avuto la se- stione anomala dei pentiti dal 1983 Sono Pietro Aglieri». Fine delle Stavamo impazzendo di fronte ai gnalazione che un signore, che al ‘94. Venerdìè finito in carcere il co- monitor che intanto facevano per noi era sino a quel momento Il pm Sabella comunicazioni fra «u signurinu» lonnello dei Carabinieri ed ex co- e gli uomini della squadra mobi- complicatissime operazioni, un illustre sconosciuto, aveva le più falcidiata dagli agguati ma- complicate almeno per me che parcheggiato di fronte al baglio mandantedellaDiagenoveseMiche- «Ci sentiamo fiosi, più coraggiosa e specializza- non sono del ramo, per misurare ed era entrato. Appena due mi- le Riccio, ieri è toccato a cinque sot- ta nella cattura dei latitanti «im- le distanze orecchio-naso, naso- nuti. E quello che potremmo de- toufficiali dell’Arma. E lo scandalo si in una fase prendibili». E a dialogo concluso, occhi, naso-bocca e così via... finire il secondo goal della parti- allarga. -

RPG Phd Thesis
Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/85513 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Peña González R. Title: Order and Crime: Criminal Groups ́ Political Legitimacy in Michoacán and Sicily Issue Date: 2020-02-20 Chapter 5. Cosa Nostra: Tracking Sicilian Mafia’s Political Legitimacy At 2012, El Komander, popular Mexican "narco-singer", released his new single entitled "La mafia se sienta en la mesa" (Mafia Takes a Sit on the Table). El Komander, the artistic name of Alfredo Ríos, as well as other performers of the so-called narcocorridos (or, as it was later named, movimiento alterado) were forbidden to perform public concerts in Mexico. That was also the case in Michoacán, where a local public officer argued that Komander's ban was due to the lyric´s songs, which touch "very sensitive topics" (Velázquez, 2018). Certainly, most of his songs are dedicated to assert Mexican "narcos" as stylish and brave popular heroes. However, the lyrics of "La mafia se sienta a la mesa" were slightly different. Instead of glorifying exclusively Mexican “narcos”, this song did “[…] a twentieth-century history seen from the mafia’s point of view” (Ravveduto, 2014), in which “someone” in Sicily did start “everything”: “En un pueblito en Sicilia, un hombre empezó las cosas. Fue el padrino en la familia y fundó la Cosa Nostra. Desde Italia a Nueva York, traficó vino y tabaco. La mafia lo bautizó, fue el primer capo de capos” (In a small town in Sicily, a man started everything. He was the godfather in the family, and founded the Cosa Nostra. -

Quaderni-Camilleriani-2-La-Sto
La storia, le storie Camillo Faverzani, Dario Lanfranca To cite this version: Camillo Faverzani, Dario Lanfranca. La storia, le storie: Camilleri, la mafia e la questione siciliana . Camillo Faverzani, Dario Lanfranca. La storia, le storie. Camilleri, la mafia e la questione siciliana, Nov 2015, Saint-Denis, France. Università degli Studi di Cagliari, pp.70, 2016, Le collane di Rhesis. Quaderni Camilleriani. hal-01672252 HAL Id: hal-01672252 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01672252 Submitted on 16 Jan 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. LE COLLANE DI RHESIS Le Collane di Rhesis Quaderni camilleriani 2 La storia, le storie. Camilleri, la mafia e la questione siciliana Comitato Scientifico MASSIMO ARCANGELI (Università di Cagliari), ANTONIO ÁVILA MUÑOZ (Universidad de Málaga), LORENZO BLINI (Università degli Studi Internazionali di Roma), FRANCESCA BOARINI (Università di Cagliari), PAOLA CADEDDU (Università di Sassari), CESÁREO CALVO RIGUAL (Universidad de Valencia), DUILIO CAOCCI (Università di Cagliari), GIOVANNI CAPRARA (Universidad -

RESOCONTO STENOGRAFICO N. 100 EDIZIONE PROVVISORIA
SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI XVI LEGISLATURA RESOCONTO STENOGRAFICO n. 100 EDIZIONE PROVVISORIA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE AUDIZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA, DOTTOR SERGIO LARI Esame di proposte del Comitato Regime degli atti Esame di proposte del Comitato Regime degli atti a 102 seduta: lunedì 26 marzo 2012 Presidenza del Presidente Giuseppe PISANU Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Resoconto stenografico della seduta del 26.3.2012 EDIZIONE PROVVISORIA I N D I C E Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, dottor Sergio Lari 2 Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Resoconto stenografico della seduta del 26.3.2012 EDIZIONE PROVVISORIA Interviene il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, dottor Sergio Lari, accompagnato dai procuratori aggiunti, dottor Amedeo Bertone e dottor Domenico Gozzo e dai sostituti procuratori, dottor Nicolò Marino, dottor Onelio Dodero e dottor Stefano Luciani. I lavori hanno inizio alle ore 17,30. (Si approva il processo verbale della seduta precedente). Sulla pubblicità dei lavori PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. (Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito). Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, dottor Sergio Lari PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, dottor Sergio Lari, accompagnato dai procuratori aggiunti, dottor Amedeo Bertone e dottor Domenico Gozzo e dai sostituti procuratori, dottor Nicolò Marino, dottor Onelio Dodero e dottor Stefano Luciani. -

Sicilian Mafia, Patron Saints, and Religious Processions: the Consistent Face of an Ever-Changing Criminal Organization
Sicilian Mafia, Patron Saints, and Religious Processions: The Consistent Face of an Ever-Changing Criminal Organization Rossella Merlino Ma una festa religiosa, che cosa è una festa religiosa in Sicilia? Sarebbe facile rispondere che è tutto, tranne che una festa religiosa. È, innanzitutto, una esplosione esistenziale. Poiché è soltanto nella festa che il siciliano esce dalla sua condizione di uomo solo. A religious festival, what is a religious festival in Sicily? An easy answer would be that it is everything but a religious festival. It is, above all, an existential explosion, as it is only during religious festivals that Sicilians abandon their state of loneliness. —Leonardo Sciascia1 The altars frequently found in the hideouts of mafiosi and the overt religiosity displayed by mafia bosses in both private and public occasions are but a few of the numerous examples of a relationship between the mafia and religion. These instances represent different aspects of the religious dimension of the Sicilian mafia, Cosa Nostra, facets that are as inextricably related to each other as they are profoundly diverse, thereby making it impossible for this complex phenomenon to be analyzed as one homogeneous whole or through a single disciplinary means. Relying chiefly on socio-anthropological theories of religious rituals and performance, this article adopts an interdisciplinary approach to look at the noticeable role that the mafia plays in local religious festivals. Evidence suggests that the practice of financing, organizing and performing a central role in religious processions in honor of local patron saints has occurred throughout the history of the organization. In this study, a set of instances from different periods and geographical areas of Sicily will be taken into account.