Emigrazione Dei Calanchini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
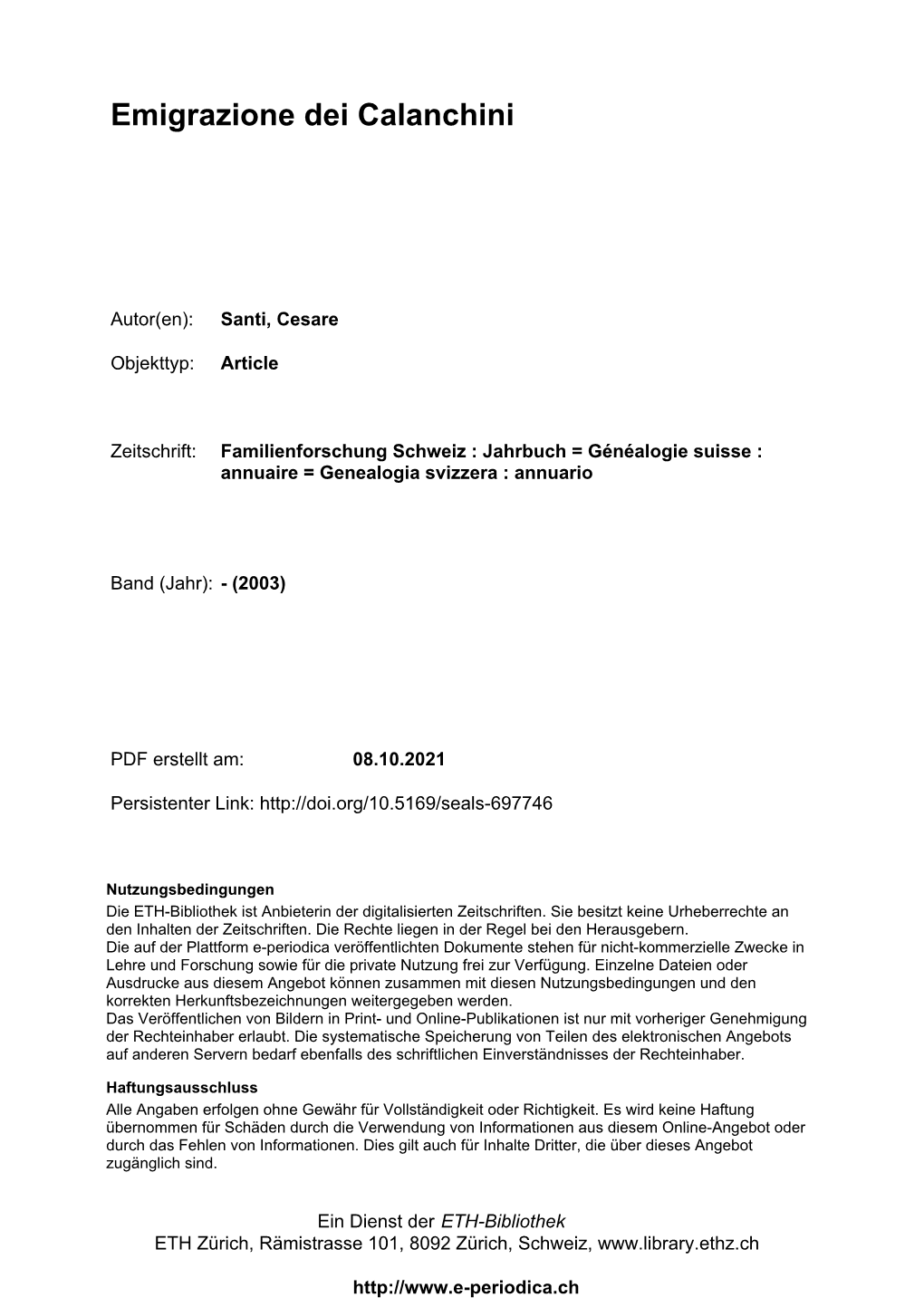
Load more
Recommended publications
-

Sprachgebiete Der Schweiz
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Statistik BFS Abteilung Bevölkerung und Bildung 1 Bevölkerung Mai 2017 Sprachgebiete der Schweiz Auskunft: Auskunftsdienst der Sektion Bevölkerung + 41 58 467 25 25 [email protected] Espace de l’Europe 10 2010 Neuchâtel www.statistik.admin.ch 1 Ausgangslage Die Sprachgebiete in der Schweiz wurden 2016 zum ersten Mal seit der Volkszählung 2000 neu be- rechnet. Die Sprachgebiete der Schweiz gehören wohl zu den am häufigsten angesprochenen geogra- fischen Einheiten auf grossregionaler Ebene. Es handelt sich um die älteste nicht-institutionelle Gliede- rung der Schweizer Statistik. Die Sprachgebiete der Schweiz sind auf der Ebene des Bundes nicht verfassungsmässig festgelegt. Der Sprachenartikel der Bundesverfassung legt aber unter anderem fest, dass die Kantone ihre Amtssprachen bestimmen (Art. 70 Abs. 2, SR 101). Dies führt dazu, dass die mehrsprachigen Kantone verschiedene sprachpolitische Konzepte erarbeitet haben. Die einen definie- ren innerkantonale Sprachenräume, andere überlassen die Sprachenpolitik den Gemeinden. Es gibt in einigen Kantonen vom Kanton offiziell anerkannte zweisprachige Gemeinden. Am komplexesten ist die Situation wohl in Graubünden. Selbst bei verfassungsmässiger Zuordnung einer Gemeinde zu einem Sprachgebiet bedeutet dies nicht zwingend, dass Verwaltungs- und/oder Schulsprache diejenige des Sprachgebietes zu sein hat. Nicht zuletzt, weil keine rechtlich verbindliche Definition der Sprachgebiete auf Bundesebene existiert, hat sich das BFS in der Vergangenheit immer auf die Mehrheitsverhältnisse gemäss den Volkszählungsergebnissen auf Gemeindestufe gestützt. In der Vergangenheit schied das Bundesamt für Statistik BFS alle zehn Jahre die Räume mit mehrheit- lich deutscher, französischer, italienischer oder rätoromanischer Hauptsprache aus, wie sie sich durch die Resultate der Volkszählungen ergaben. 1 Dabei wurde in einem ersten Schritt die relative Mehrheit einer Landessprache auf der Ebene der Gemeinde ermittelt und dann die Sprachgebiete festgelegt. -
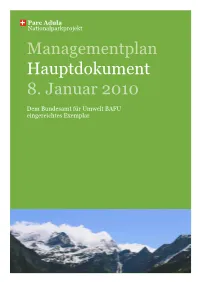
Verein Parc Adula Format
Parc Adula Nationalparkprojekt Managementplan Hauptdokument 8. Januar 2010 Dem Bundesamt für Umwelt BAFU eingereichtes Exemplar Parc Adula Managementplan für die Errichtungsphase Hauptdokument Dem Bundesamt für Umwelt BAFU eingereichtes Exemplar Deutsche Version 8. Januar 2010 Verein Parc Adula Ca’ Rossa Tel. 091 820 38 10 CH-6537 Grono Fax 091 820 38 12 www.parcadula.ch / [email protected] Managementplan Parc Adula Impressum Projektleitung: Riccardo Tamoni Verein Parc Adula Ca' Rossa 6537 Grono Leitungsausschuss: Fabrizio Keller, Präsident, Calanca und Mesolcina Luca Baggi, Vizepräsident, Regione delle Tre Valli Nello Bruni. Regione delle Tre Valli Sep Cathomas, Regiun Surselva Gion Michael, regioViamala Sandro Vanina, Regione delle Tre Valli Geschäftsführer der Regionalverbände: Duri Blumenthal, Regiun Surselva Nadia Ghisolfi, Regione delle Tre Valli Martin Hilfiker, Regione Mesolcina Alessandro Massa, Organizzazione Regionale della Calanca Casper Nicca, regioViamala Dario Zanni, Regione Tre Valli Koordination Managementplan: Stefan Forster Remo Kellenberger ZHAW Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR Fachstelle Tourismus und Nachhaltige Entwicklung FS TNE Center da Capricorns 7344 Wergenstein Copyright © Associazione Parc Adula 2009 Managementplan Parc Adula Autoren . Vorwort Fabrizio Keller Zusammenfassung…………………………..Riccardo Tamoni 1 Parkgebiet 1.1 Vorgeschichte Riccardo Tamoni 1.2 Perimeter Riccardo Tamoni 1.3 Natur und Landschaft, Teil Natur Dunja Meyer 1.3 Natur und Landschaft, Teil Flora Franziska Andres 1.3 Natur -

Amtliches Gemeindeverzeichnis Der Schweiz Angekündigte
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Statistik BFS Abteilung Register 0 Statistische Grundlagen und Übersichten November 2016 Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz Angekündigte Änderungen 2016 Ausgabe vom 03.11.2016 (ersetzt Ausgabe vom 22.06.2016) 1 Allgemeines 1.1 Kurzbeschreibung Nach Art. 19, Abs. 3 der Verordnung vom 21. Mai 2008 über die geographischen Namen (GeoNV - SR 510.625) sind die Gemeindenamen und Gemeindenummern des amtlichen Gemeindeverzeichnis- ses behördenverbindlich. Das Bundesamt für Statistik vergibt für jede Gemeinde eine Nummer und erstellt, verwaltet und veröffentlicht das amtliche Gemeindeverzeichnis der Schweiz (GeoNV - Art. 19, Abs. 1). Im amtlichen Gemeindeverzeichnis werden alle von der Eidgenössischen Vermessungsdirek- tion (swisstopo) genehmigten Änderungen von Gemeindenamen sowie weitere von den zuständigen kantonalen Stellen gemeldeten Änderungen (Aufhebung von Gemeinden, Gebietsveränderungen und Änderungen in den Bezirken oder einer vergleichbaren administrativen Einheit des Kantons) nachge- führt. 1.2 Struktur Das amtliche Gemeindeverzeichnis ist nach Kantonen sowie nach Bezirken oder einer vergleichbaren administrativen Einheit des Kantons gegliedert (GeoNV - Art. 19, Abs. 2). 1.3 Wichtigste Anwendungen Das amtliche Gemeindeverzeichnis wird als definitorische Grundlage zur Gemeindeidentifikation und Gemeindenamen in zahlreichen Verwaltungsapplikationen auf Stufe Bund, Kantone und Gemeinden sowie in der Privatwirtschaft eingesetzt. Espace de l'Europe 10 CH-2010 Neuchâtel www.statistik.admin.ch -

Alcune Particolarità Della Terminologia Relativa Ai Circoli Nei Grigioni, in Prospettiva Storica E Comparativa
Alcune particolarità della terminologia relativa ai Circoli nei Grigioni, in prospettiva storica e comparativa Gianpiero Raveglia Origine e funzioni dei Circoli Il circolo è una circoscrizione giudiziaria o ammi- nistrativa nell’ambito dell’organizzazione statale, cono- sciuta sia in Ticino, sia nei Grigioni, sia in altri cantoni svizzeri, di lingua tedesca (Kreis, nei Cantoni Argovia e Turgovia) o francese (cercle, nel Canton Vaud). La parola esiste anche in Italia in ambito burocratico, con il signifi- cato simile di ‹circoscrizione›2, termine che nella Svizze- ra Italiana verrebbe piuttosto tradotto con circondario, Codice civile del Cantone Grigione del 19 giugno 1861, entrato in vigore il 1° per esempio «circondario delle poste» o «circondario settembre 1862, nelle tre versioni in italiano (1861, tradotta dai poschiavini delle dogane». Nella legislazione grigione il sostantivo Prospero Albricci e Gaudenzio Olgiati), tedesco (testo originale, 1862) e «circolo» è talvolta usato in modo improprio3, come tra- romancio (1863, traduzione di Louis Vieli). duzione di Kreis o Amtkreis, per ‹circondario›4, ‹circo- scrizione›5 o ‹giurisdizione›6. Il presente articolo sintetizza uno studio di circa 80 In Svizzera il termine circolo è stato introdotto con pagine rimasto finora inedito, terminato nel 2010, che si le costituzioni cantonali incluse nell’Atto di Mediazione riferisce alla terminologia delle varie cariche e funzioni del 1803, quindi su influenza francese, per indicare delle legate ai Circoli grigioni (consiglio di circolo, assemblea circoscrizioni intermedie tra il cantone, il distretto e il di circolo, giudice di pace-conciliatore, denominazio- comune7, con funzione elettorale (in particolare per l’e- ni femminili delle cariche, ecc.) e delle relative elezioni lezione dei granconsiglieri) e giudiziaria (giudicature di (elezioni di Circolo-Vicariato). -

Hike and Fly Calancatal 4-Tägiger Urlaub Im Wunderschönen Regionalpark Calancatal Und Misox
Hike and Fly Calancatal 4-tägiger Urlaub im wunderschönen Regionalpark Calancatal und Misox Enea Bettè-Mozzini H&F Calancatal und Misox SHV Gleitschirm Tandempilot MisoX-Alps Session Frühling 2020 ESA Wanderleiter http://www.flymoesa.ch H&F Session Herbst 2020 CH-6535 Roveredo GR Contents Das Calancatal und Misox: die graubündene Wildperle der südalpen Ebene. ............................................... 3 FlyMoesa: euere Referenz fürs Hike&Fly im Region Misox............................................................................. 4 Tourdetails....................................................................................................................................................... 5 Einführung ................................................................................................................................................... 5 1. Tag ........................................................................................................................................................... 6 2. Tag ........................................................................................................................................................... 7 3. Tag ........................................................................................................................................................... 8 4. Tag ........................................................................................................................................................... 9 Detailprogramm ........................................................................................................................................... -

Durchbllick 2016, Graubünden in Zahlen
Durchblick 2016 Graubünden in Zahlen 2 2016 Inhalt Vorwort 5 Bevölkerung 7 Arbeit und Erwerb 10 Aussenhandel 11 Volkswirtschaft 12 Industrie, Dienstleistungen 13 Land- und Forstwirtschaft 16 Bau- und Wohnungswesen 18 Tourismus 20 Mobilität und Verkehr 23 Soziale Sicherheit 24 Gesundheit 25 Bildung, Wissenschaft 25 Politik 28 Öffentliche Finanzen 30 Strukturelle Gliederung des Kantons 32 Tabelle 1 34 Gesamtfläche, Ständige Wohnbevölkerung, Bau- und Wohnungswesen Tabelle 2 42 Arbeitsstätten und Vollzeitäquivalente, Unternehmensgründungen, Beherbergungsstatistik Tabelle 3 52 Gemeindefinanzen Definitionen 57 Quellen 58 2016 3 4 2016 Vorwort Liebe Leserinnen und Leser Das unsichere internationale Umfeld und die herausfordernde wirtschaftliche Lage Graubün- dens verlangen von den Entscheidungsträgern in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik einiges ab. Gerade in solchen Zeiten steigt das Bedürfnis nach unabhängigen, auf wissenschaftlicher Basis erhobenen Grundlagen. Informationen aus der öffentlichen Statistik sind bei der Bewältigung von schwierigen Aufgaben verschiedenster Art von grossem Nutzen. Sie liefern wertvolle Fakten, um Ausgangslagen zu analysieren sowie Szenarien und Lösungsansätze zu erarbeiten. Auf knappem Raum findet sich in der vorliegenden Broschüre naturgemäss nur Platz für die wichtigsten Daten. Viele vertiefende Informationen und weitergehende Hinweise zu allen Themenbereichen der öffentlichen Statistik finden Sie auf der Webseite des Amtes für Wirtschaft und Tourismus Graubünden unter www.awt.gr.ch (Statistik und Register) -

Rapporto Di Gestione 2018
RAPPORTO DI GESTIONE 2018 Lostallo Buseno Cama Castaneda Comune Grono di Calan- ca Mesocco Rossa Roveredo San Soazza Sta Maria Vittore in Calanca SOMMARIO 1 Compiti regionali ..................................................................................................................... 2 2 Organi ..................................................................................................................................... 2 3 Personale e indirizzi di contatto ............................................................................................... 4 4 Resoconto attività 2018 ........................................................................................................... 6 4.1 Attività svolte .................................................................................................................... 6 4.2 Principali decisioni prese dal Comitato Regionale (CR) .................................................... 7 Principali decisioni prese dalla Conferenza dei Sindaci (CdS) ..................................................... 7 4.3 Gestione e movimenti del personale ................................................................................. 8 4.4 Logistica ........................................................................................................................... 8 4.5 Compiti regionali ............................................................................................................... 8 4.5.1 Ufficio Esecuzioni e Fallimenti (UEF) ........................................................................ -

Seite 41.415, Cagliatscha - Calanca (Val) Internet
eLexikon Bewährtes Wissen in aktueller Form Seite 41.415, Cagliatscha - Calanca (Val) Internet: https://peter-hug.ch/41_0415 Main mehr ins Val Colla und 8 km nö. Lugano. Postablage; Postwagen Tesserete-Bidogno. Gemeinde, den Weiler Almatro inbegriffen: 62 Häuser, 291 kathol. Ew.; Dorf: 42 Häuser, 192 Ew. Kirchgemeinde Tesserete. Acker- und Weinbau, Viehzucht. Starke periodische Auswanderung. Die den h. Matteo und Maurizio geweihte Kirche ist eine der ältesten im Thal. Cagliatscha (Kt. Graubünden, Bez. Heinzenberg, Kreis Schams, Gem. Clugin). 1182 m. Burgruine, auf einem Felssporn über dem linken Ufer des Hinterrheins, sw. Clugin und 1 km n. Andeer. Cagnial (Piz) (Kt. Graubünden, Bez. Albula, Kreis Oberhalbstein). 2970 m. Felsgipfel, in der Gruppe des Piz Platta, sw. vom Piz Forbisch und 6-7 Stunden sw. Mühlen. Zwischen Val Gronda, Val Curtins und Val Starlera. Caillettes (Les) (Kt. Waadt, Bez. Aigle, Gem. Bex). 528 m. Einzelstehendes Haus, am S.-Rand des Plateaus von Chiètres, über der Felswand Sous Vent; 2,3 km s. Bex und 1,8 km nö. der Station Saint Maurice der Simplonbahn. In dem kleinen von hier zur Rhone hinabführenden Thälchen findet sich in Menge der Seeigel Toxaster complanatus, Leitfossil des Neocom. Caischavedra (Kt. Graubünden, Bez. Vorderrhein, Kreis Disentis, Gem. Tavetsch). 1837 m. Alpweide mit 12 Sennhütten, in kleinem rechtsseitigen Nebenthal zum Val Acletta, 4 km nö. Sedrun und 3 km w. Acletta. Cala (Monte) (Kt. Tessin, Bez. Leventina, Gem. Chironico). 1492 m. Alpweide mit 20 im Frühjahr und Herbst bezogenen Hütten und Kapelle, im Val Chironico, 3½ Stunden sw. der Station Lavorgo der Gotthardbahn. Calabri (Kt. Bern, Amtsbez. -

Calancatal: Arvigo – Santa Maria in Calanca (Misox)
Calancatal: Arvigo – Santa Maria in Calanca (Misox) Wegbeschrieb leicht | 2.40 h | 8.3 km | 428 Hm 291 Hm | Santa Maria | Apr – Nov Ausgangspunkt der Wanderung ist die Bushaltestelle Arvigo Filovia bei der Seilbahnsta- tion, die nach Braggio im Calancatal führt. Den Ausgangspunkt Arvigo erreicht man von Wanderung im Calancatal im Misox von Arvigo nach Santa Maria in Grono im Valle Mesolcina (Misox), welcher an der Route zum San Bernardino und nach Calanca oberhalb von Grono. Unterwegs warten herrliche Aussichten Bellinzona liegt. Das Val Calanca ist ein Seitental des Misox und gehört zum italienisch- auf die Berge des Misox und der See Laghet di Buseno lädt mit schö- sprachigen Gebiet des Kantons Graubünden. nen Feuerstellen zum Stopp ein. Von der Bushaltestelle führt der Weg parallel dem Fluss Calancasca, auf der wenig befah- renen Strasse entlang abwärts, Richtung Buseno. Man passiert einen Gneiss-Steinbruch Ausgangspunkt: Arvigo, Filovia – Bushaltestelle und vereinzelte Häuser, bis man nach rund 20 Minuten die Strasse nach rechts überquert. Endpunkt: Sta. Maria in Calanca, Paese– Bushaltestelle Nun geht es auf dem Wanderweg leicht bergauf, dann über ein Geröllfeld und schliesslich Einkehr: nur Verpflegung in Santa Maria in Calanca: Ristorante Bellavista, im stetig leichten Auf und Ab zum Weiler Buseno. Nachdem man den Weiler hinter sich Ristorante-Bar Molera, Ristorante Baita gelassen hat, überquert man ein Flüsschen auf einer Brücke, wo man kurz darauf zu einer Anforderungen: T2 – Bergwandern Weggablung kommt. Hier geht man nach links hinab zum Laghet di Buseno. Die Route führt Highlights: Laghet di Buseno, Ausblicke von Piöt und Santa Maria in Calanca, nun in den schönen Wald hinein bis zum Ufer des Stausees. -

Poststellenchronik Schweiz 1849 - 2015
Poststellenchronik Schweiz 1849 - 2015 Chronique des offices de poste suisses de 1849 à 2015 Chronicle of Swiss Post Offices 1849 - 2015 Autor: Karl Gebert, Kapplerstrasse 27, CH-9642 Ebnat-Kappel Nachführung ab Sommer 2010: Hansjörg Vogt, 6947 Vaglio 091 943 32 26; [email protected] Stand 30.6.2015 Alle seit Erscheinen des Buches im Februar 1999 bekanntgewordenen Korrekturen und Ergänzungen sind berücksichtigt. Die Schweizerische Post betrieb am 1. Januar 2015: 1561 Poststellen, 660 Postagenturen, 1277 Hausservices 2 Poststellenchronik Schweiz 1849 - 2015 Erstmals publiziert zum Jubiläum 150 Jahre Eidgenössische Post (1999) Vorwort Diese Chronik enthält sämtliche Ortsnamen der Schweiz, von denen jemals ein Aufgabestempel für Postsen- dungen existierte: a) Postämter, Postbüros, Postagenturen = 01-11 (ganzjährig geöffnet, im Postkreis I-XI) b) Postablagen = 01-11 (ganzjährig geöffnet, im Postkreis I-XI) c) Paketannahmestellen = PA d) Postannahmestellen = PO e) Reisendeneinschreibstellen = RE f) Saisonpoststellen = SA g) Selbstbedienungs-Poststellen = SB h) Mobile Postbüros = MP i) Agenturen in Geschäften, Läden oder Büros = Ag und zwar stets nach dem Text der Poststempel, nicht nach der Schreibweise in den Ortsverzeichnissen, die sehr oft mit den Stempeln nicht übereinstimmte. Es kam vor, dass die offizielle Bezeichnung gänzlich anders war als der Stempel (z.B. Poststelle: Schooren, Stempel: Kirchberg). Kantonsbezeichnungen werden nur dort angeführt, wo sie gemäss den Ortsverzeichnissen der Post zum Namen gehören (gleichlautende Ortschaften in verschiedenen Kantonen); unterschiedliche Schreibweisen werden nicht berücksichtigt, sondern stets die offizi- ellen Abkürzungen gebraucht. b) Postablagen: Bis 1925 galt die Regelung, dass nichtrechnungspflichtige Ablagen nur einen Stabstempel (Balkenstempel) erhielten. Wurde die Ablage rechnungspflichtig, bekam sie erstmals einen runden Datum- stempel. Der Stabstempel verblieb weiterhin bei der Ablage und wurde als Formularstempel, aushilfsweise oder gefälligkeitshalber auch als Entwertungsstempel benützt. -

Verzeichnis Der Poststellen Kanton Graubünden
Verzeichnis der Poststellen Kanton Graubünden Poststelle Stempel Kanton Postkreis Stabstempel Rundstempel LT Kommentar GMV Art KAP Acla (Medels i/O) Acla (Medels i/O) GR 10 15.06.1912 15.09.1919 SA Acla (Safien) Acla b/Tenna GR 10 15.09.1885 Acla (Safien) Acla GR GR 10 1892 Acla (Safien) Acla (Safien) GR 10 1915 01.07.1925 Acla (Safien) 7105 Acla (Safien) GR 10 13.07.1967 30.09.1968 Acla (Safien) 7104 Acla (Safien) GR 10 01.10.1968 1986 RE Aeuja Aeuja GR 10 01.10.1903 01.07.1907 Aeuja 7250 Aeuja GR 10 12.09.1966 30.11.1993 Gemeinde Klosters Albigna Albigna GR 10 01.05.1957 30.04.1960 Kraftwerkbau (Bergell) Albula Hospiz Albula Hospiz GR 10 Ovaler Privatstempel von 1900 Almens Allmens GR 10 1850 Almens Almens GR 10 1885 01.07.1907 Almens 7499 Almens GR 10 01.06.1967 Almens 7416 Almens GR 10 04.06.1984 31.08.2007 Alp Grüm Alp Grüm GR 10 15.07.1910 Alp Grüm 7749 Alp Grüm GR 10 01.06.1967 31.10.1969 Alvaneu Bad Alveneuerbad GR 10 1850 Alvaneu Bad Alveneu Bad GR 10 01.07.1870 Alvaneu Bad Alveneubad GR 10 01.09.1881 Alvaneu Bad Alvaneu-Bad GR 10 01.05.1903 Alvaneu Bad 7499 Alvaneu Bad GR 10 01.06.1967 Alvaneu Bad 7473 Alvaneu Bad GR 10 04.06.1984 31.08.1996 Alvaneu Dorf Alveneu GR 10 1850 Alvaneu Dorf Alveneu Dorf GR 10 01.08.1875 Alvaneu Dorf Alvaneu-Dorf GR 10 01.04.1903 Alvaneu Dorf Alveneu Dorf GR 10 01.12.1932 Alvaneu Dorf 7499 Alvaneu Dorf GR 10 01.06.1967 Alvaneu Dorf 7492 Alvaneu Dorf GR 10 30.05.1988 05.04.2013 Alvaneu Dorf 7492 Alvaneu Dorf GR 10 08.04.2013 Ag Alvaneu Station Alvaneu Station GR 10 1914 1919 RE Alvaschein Alvaschein -

Export USN 14 03 2018.Pdf
Verzeichnis der systematischen Benutzer der AHVN13 Annuaire des utilisateurs systématiques du NAVS13 Elenco degli utenti sistematici del NAVS13 Identität der Stelle – identité de l'institution – identità dell'istituto Firmenname Adresse Postfach PLZ Ort Raison sociale Adresse Case postale NPA Lieu Ragione sociale Indirizzo Casella postale Luogo Luogo A.H. Meyer & Cie AG Personalvorsorgestiftung Badenerstrasse 329 120 8040 Zürich Aargauische Pensionskasse Hintere Bahnhofstr. 8 2127 5001 Aarau Aargauische Sprachheilschule, Laufenbrug Winterthurerstrasse 5 5080 Laufenburg Aargauische Sprachheilschule, Lenzburg Turnerweg 16 5600 Lenzburg Aargauische Sprachheilschule, Oftringen Campingweg 12 4665 Oftringen Aargauische Sprachheilschule, Wettingen Bahnhofstrasse 107 5430 Wettingen aarReha Schinznach Badstrasse 55 5116 Schinznach Bad ABB Pensionskasse c/o Avadis Vorsorge AG Zollstrasse 42 1077 8005 Zürich Alte Wollerauerstrasse ABC Learning Tree GmbH 34 8832 Wollerau Abraxas Informatik AG Rosenbergstrasse 30 9001 St. Gallen ABS Betreuungsservice AG St. Jakobstrasse 66 1105 4133 Pratteln ABSMAD Association Broyarde pour la promotion de la santé et le maintien à domicile Rue du Temple 11 1530 Payerne Abteilung Militär- und Bevölkerungsschutz des Kantons Obwald, Polizeigebäude Dienstelle Zivilschutz Foribach Postfach 1465 6061 Sarnen 1 Abteilung Wehrpflichtersatz Kanton Uri Lehnplatz 22 6460 Altdorf ABZ-SUiSSE GmbH Wiggermatte 16 6260 Reiden Academia Engiadina Samedan Quadratscha 18 7503 Samedan academia International School Schifflände 3 4051 Basel